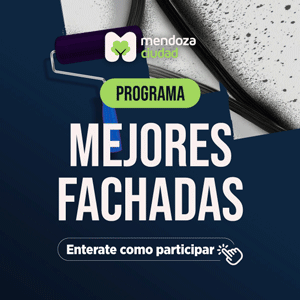Il virus Zika è uno dei patogeni più insidiosi che possono essere trasmessi dalla puntura delle zanzare. Noto per la capacità di provocare malformazioni fetali. E per la velocità con cui si diffonde in un nuovo ambiente quando è presente il suo vettore naturale, la zanzara del genere Aedes aegypti (fortunatamente per ora assente nel nostro paese). Un nuovo studio pubblicato su Communications Biology, e coordinato dai ricercatori della Liverpool School of Tropical Medicine, rivela oggi uno dei meccanismi alla base di questo suo elevato potenziale epidemico: Zika infatti sarebbe capace di modificare la pelle delle persone che infetta, facendo produrre sostanze chimiche che attirano le zanzare, e aumentano le probabilità di nuove infezioni. Il virus Zika è stato scoperto per la prima volta in Uganda nel 1947, e inizialmente si è diffuso lentamente intorno al globo. Verso la metà del secolo scorso aveva raggiunto il Sudest asiatico, per l’inizio del 21esimo secolo era riuscito ad attraversare il Pacifico, sbarcando in Sud America. Da lì, di colpo, ha iniziato a correre, diffondendosi a macchia d’olio sul Continente. Attualmente è presente in più di 90 nazioni, e con un bacino così vasto di persone ha iniziato a mostrare il suo vero volto. Per decenni infatti non era stato considerato come una minaccia concreta, perché nella stragrande maggioranza dei pazienti l’infezione risulta asintomatica o di lieve entità. Con l’arrivo in paesi popolosi come il Brasile, però, si è scoperto che l’infezione può esporre a conseguenze estremamente gravi, soprattutto quando colpisce le donne durante il primo trimestre di gravidanza, esponendo il feto al rischio di microcefalia, uno sviluppo anomalo della testa e del cervello che produce sintomi irreversibili. Per questo motivo, Zika è diventato un sorvegliato speciale in tutto il mondo, e si sono moltiplicati gli sforzi per comprendere i meccanismi della sua diffusione. La nuova ricerca ha indagato cosa accade nella pelle dei pazienti durante un’infezione da Zika virus. Dimostrando che il patogeno è in grado di modificare l’espressione genica a livello dei fibroblasti, le cellule responsabili del mantenimento dell’integrità strutturale della pelle. Il risultato di questi cambiamenti è un’alterata produzione di molecole note come composti organici volatili (Voc), che in seguito all’infezione diventano maggiormente appetibili per le zanzare del genere Aedes, trasformando il paziente in una sorta di calamita per i morsi di zanzara, e quindi in una fonte perfetta di nuove infezioni (il virus ha bisogno delle zanzare per essere trasportato da un ospite all’altro). Testando gli effetti del virus con delle zanzare in carne ed ossa, gli autori dello studio hanno dimostrato che la presenza dei composti organici volatili prodotti in seguito all’infezione aumenta del 60 percento la percentuale di femmine di Aedes aegypti che mostrano comportamenti di persistenza intorno a un campione di sangue. I Voc prodotti dall’infezione renderebbero anche più facile l’identificazione delle prede, visto che negli esperimenti tra il 10 e il 27 percento delle zanzare ha raggiunto i campioni in cui erano presenti i composti entro 10 secondi, contro il 3 percento che ha individuato quelli non contaminati dal virus. «I nostri risultati mostrano che il virus Zika non è trasmesso passivamente, ma manipola attivamente la biologia umana per assicurare la propria sopravvivenza», spiega Noushin Emam, della Liverpool School of Tropical Medicine. «Con i casi di Zika in continuo aumento e le zanzare Aedes che espandono il loro areale, comprendere i meccanismi che forniscono al virus un vantaggio nella trasmissione potrebbe aiutarci a sviluppre nuove strategie per combattere questi arbovirus. Ad esempio, sviluppare interventi genetici che interrompano i segnali trasmessi dalla pelle che sembrano attrarre le zanzare».
Simone Valesini