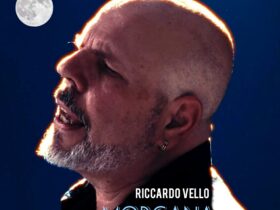Enrico Baj a Bruno Munari
Giovanni Cardone
Fino al 24 Novembre 2024 si potrà ammirare al Palazzo delle Paure Lecco la mostra Milano Anni’60 da Lucio Fontana, Piero Manzoni, Enrico Baj a Bruno Munari furono i maestri dell’arte nata a Milano negli anni ‘60 curata da Simona Bartolena. L’esposizione prodotta e realizzata da ViDi cultural, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, completa il ciclo espositivo di Percorsi nel Novecento, programma ideato dalla Direzione del Sistema Museale Urbano Lecchese e affidato per la sua progettazione e realizzazione a ViDi Cultural che analizza la scena culturale italiana del XX secolo. Palazzo delle Paure ospita una mostra che racconta un decennio straordinario, nel quale il capoluogo lombardo ha confermato il proprio ruolo da protagonisti sulla scena culturale internazionale. La rassegna presenta 60 opere di autori quali Lucio Fontana, Piero Manzoni, Enrico Baj, Bruno Munari, Arturo Vermi, Ugo La Pietra, Gianni Colombo, Grazia Varisco e altri, capaci di raccontare e approfondire i nuovi linguaggi artistici e le ricerche rivoluzionarie, sorte a Milano in questo irripetibile momento storico, caratterizzato da un clima di grande fermento che porterà a un radicale cambiamento del pensiero creativo. Già dal secondo dopoguerra Milano è teatro di una lunga serie di attività culturali: aprono nuove gallerie, si inaugurano mostre, si formano gruppi e movimenti, vengono pubblicati manifesti. Gli artisti reagiscono alle distruzioni belliche cercando strade sempre più sperimentali e linguaggi più idonei alla nuova condizione sociale e antropologica e tessendo una rete di relazioni e dialoghi che la rendono una delle capitali indiscusse dell’arte europea. Rispetto al decennio precedente, dove prevalevano codici espressionisti e informali, negli anni Sessanta gli autori abbandonano l’istinto e il gesto veemente, per assumere un atteggiamento nuovo, più calibrato. Molti di essi guardano ai tagli di Lucio Fontana che tratta la tela non più come superficie ma come materia; altri restano fedeli alla pittura, cercando di rinnovarne l’idea. In una mia ricerca storiografica e scientifica sull’arte a Milano negli ami ’60 apro il mio saggio dicendo: A partire dal secondo dopoguerra l’Italia recupera i contatti con l’estero, che erano nettamente diminuiti durante il ventennio fascista, e diventa culla di raggruppamenti e movimenti non figurativi, quali il gruppo Forma 1, a Roma, e, a Milano, lo Spazialismo, l’arte nucleare e il Movimento arte concreta (MAC). La rete di relazioni si infittisce nel corso degli anni Cinquanta e soprattutto dei Sessanta, quando, sull’onda del “miracolo economico”, lungo tutto lo stivale vengono inaugurate numerose gallerie private, le quali, mentre svolgono il ruolo di sostegno e promozione degli artisti, si rivelano spazi di grande rinnovamento estetico. Quest’aspetto emerge con maggiore evidenza dalla seconda metà degli anni Sessanta, momento in cui le gallerie, più che le istituzioni pubbliche, si impegnano a documentare un clima artistico che ha superato la stagione informale e vede convivere la linea programmata e quella concettuale. Ospitando opere proiettate nello spazio cioè libere dall’essere pura rappresentazione pittorica, quadro da cavalletto, environment e happening, che con il loro carattere effimero annullano ogni interesse economico, le gallerie modificano la propria storica accezione di immutabile luogo espositivo. Non solo, esse iniziano a convivere con spazi espositivi non deputati, dalla vita più breve, ma dall’altrettanto forte carica innovatrice, come nel caso del torinese Deposito D’Arte Presente. Fabio Sargentini, proprietario della galleria romana L’Attico, ha infatti notato che, in un momento in cui le gallerie americane, imprigionate sui grattacieli, lavoravano esclusivamente come spazi espositivi, quelle europee tendevano a configurarsi più come laboratori, come “spazi vivi di lavoro”.
Dal canto suo Plinio De Martiis, titolare a Roma de La Tartaruga, ha descritto la propria galleria come un “luogo di incontri e di scambi, di stimoli, di notizie e di idee”. E ancora, in occasione della rassegna del 1981 Linee della ricerca artistica in Italia. 1960- 1980 si è ricordato che tra gli anni Sessanta e Settanta il “cubo bianco della galleria” è stato “il luogo dove si è vissuta una condizione tra le più ampie di libertà” e si è manifestata la “più vasta fenomenologia del fare artistico”. Sebbene nell’Italia della seconda metà del Novecento l’interesse verso le nuove forme dell’operazione estetica riguardi particolarmente le città di Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, è possibile individuare in quello che Bruno Corà ha definito il “triangolo Torino-Milano-Roma” l’area più ricca di gallerie e personalità che influenzeranno gli sviluppi della ricerca artistica. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta Milano è già una città moderna, fortemente industrializzata e proiettata nel futuro, insomma una “ritrovata città del futurismo”, avanguardia riscoperta proprio in questo periodo e alla cui diffusione lavora ad esempio la Galleria Blu dell’imprenditore Peppino Palazzoli, fondata nell’aprile del 1957. Il vitale clima artistico della città è dominato dalle personalità di Lucio Fontana, Vincenzo Agnetti, Mario Nigro, Bruno Munari; dall’attività dei nucleari Baj, Dangelo e Joe Colombo; dalle esperienze di Piero Manzoni ed Enrico Castellani con la galleria e la rivista “Azimuth”; dalle sperimentazioni cinetiche e programmate che il Gruppo T di Giovanni Anceschi, Gabriele De Vecchi, Gianni Colombo, Davide Boriani e Grazia Varisco porta avanti in concomitanza con il Gruppo N di Padova, il Gruppo Zero di Düsseldorf e il Groupe de Recherche d’Art Visuelle (Grav) di Parigi. Fra i critici d’arte si distinguono Gillo Dorfles e Guido Ballo e un importante ruolo istituzionale di riferimento è svolto dalla Triennale, mentre manca una sede pubblica che possa garantire un programma costante. Questa lacuna è colmata da una ricca rete di gallerie private, le quali, sin dalla prima metà degli anni Sessanta, prediligono i contatti con la Francia e si dimostrano meno permeabili alla Pop art statunitense rispetto a quanto avviane nello stesso momento a Roma, città profondamente segnata dalla relazione con il panorama americano. “Oggi Milano, dopo Parigi, è considerata il centro artistico e commerciale più importante d’Europa”. È quanto dichiara nel 1962 Guido le Noci, direttore della Galleria Apollinaire, nata nel 1954, e figura cardine del rapporto della città con la Francia in quanto legato da profonda amicizia al critico d’arte francese Pierre Restany. Quest’ultimo infatti presenta nel 1957 alla Galleria Apollinaire la prima personale in Italia di Yves Klein, con undici tele monocrome, e nel maggio del 1960 introduce nella stessa galleria i Nouveaux Réalistes. Il gruppo francese, di cui Restany è il teorico, riceve così una consacrazione ufficiale, accompagnata dalla comparsa del suo primo manifesto, pubblicato dalla stessa Galleria Apollinaire, in cui si legge una ormai netta opposizione alla pittura di cavalletto in favore dell’adozione di tecniche e poetiche neodadaiste, in parallelo a quanto stava accadendo negli Stati Uniti. Dopo la fondazione del gruppo – ufficializzata nello studio di Klein, a Parigi, il 27 ottobre 1960 – la galleria milanese dedica una serie di personali alla maggior parte dei suoi rappresentanti, tra cui Yves Klein, César, Arman, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Daniel Spoerri, Christo e Mimmo Rotella, unico italiano del gruppo. Le strade di Guido Le Noci, Pierre Restany e i Nouveaux Réalistes si incroceranno di nuovo nel 1970, quando il direttore della galleria Apollinaire e il critico francese, con il concorso della municipalità di Milano, organizzeranno il decimo anniversario della fondazione del gruppo alla Rotonda della Besana, con una serie di azioni, tra cui i celebri empaquetage di Christo, che animeranno le vie e le piazze del centro cittadino. Il lungimirante gallerista milanese aveva sostenuto la necessità di spostare il proprio ruolo promozionale dall’oggetto al fare artistico appena due anni prima, organizzando all’Apollinaire la prima personale di Daniel Buren, che, per l’occasione aveva chiuso fisicamente e metaforicamente l’ingresso esterno della galleria con i suoi “utensili visivi” bianchi e verdi. Negli anni in cui la Galleria Apollinaire comincia a promuovere i Nouveaux Réalistes, un altro spazio privato milanese, La Galleria dell’Ariete di Beatrice Monti, inaugurata nel 1955, propone gli artisti New Dada e pop americani e inglesi, ospitando Robert Rauschenberg nell’ottobre del 1961, ad un anno esatto la prima personale italiana di Jim Dine e nel 1964 una mostra a quattro con Jasper Johns, Morris Louis, Kenneth Noland e ancora Rauschenberg. Lo statunitense Jasper Johns aveva già tenuto la prima personale italiana nel 1959 presso la Galleria del Naviglio di Carlo Cardazzo, attiva a Milano dal 1946. Nel capoluogo lombardo il mercante d’arte, storico e collezionista Arturo Schwarz sceglie invece di dedicare le esposizioni della galleria che porta il suo nome, aperta dal 1961 al 1975, agli esponenti più significativi delle avanguardie storiche, soprattutto dadaisti e surrealisti, e del secondo dopoguerra. Memorabile è la retrospettiva europea su Duchamp del 1964, con 108 lavori, che sarà trasferita in vari musei europei. Nel panorama milanese dei primi anni Sessanta si distingue anche la fulminea e intensissima attività della galleria Azimut e dall’omonima rivista (“Azimuth”), diversificate nel lettering, fondate da Piero Manzoni ed Enrico Castellani nel settembre del 1959 e chiuse nel luglio del 1960. La galleria espone i primi Corpi d’aria, gli Achrome e le Linee di Manzoni e nell’anno della sua chiusura ospita la mostra La nuova concezione artistica, con Castellani, Klein, Manzoni ed esponenti del Gruppo Zero di Düsseldorf, rivelando così legami anche con l’ambiente artistico tedesco. L’ultima esposizione, che presenta un’arte fruibile solo in modo effimero e mentale, è Consumazione dell’arte dinamica del pubblico di Manzoni, una sorta di happening in cui il pubblico della galleria è invitato a mangiare delle uova sode sulle quali l’artista ha lasciato l’impronta del proprio pollice. Azimut diviene così un punto di riferimento per gli artisti concettuali e per la formazione del giovane torinese Luciano Fabro, che alla fine degli anni Sessanta entrerà nel gruppo dei poveristi. Alle attività e all’organizzazione della galleria avevano preso parte anche i futuri membri del Gruppo T, costituitosi nell’ottobre del 1960, a due mesi dalla chiusura di Azimut, con il manifesto Miriorama 1, come viene intitolata la prima collettiva del gruppo ospitata a gennaio dalla Galleria Pater. Quest’ultima si distingue nel contesto espositivo milanese per il ruolo svolto nell’ambito delle nuove ricerche programmate. La mostra Miriorama 1, cui seguiranno dodici edizioni fino al 1962, presenta infatti spazi agibili aperti alla trasformazione da parte del fruitore. “Azimut – ha scritto Gabriele De Vecchi – che avrebbe potuto essere la sede naturale e inaugurale per la cinetica partecipata del Gruppo T segnò, invece, il distacco ideologico da Manzoni avviato alla ri-consacrazione mitica dell’artista mentre il fare Gruppo T non si esauriva nell’artista, ma mirava a coinvolgere sperimentalmente lo spettatore”. Nei secondi anni Sessanta Milano assiste all’apertura in successione di una serie di gallerie che stabiliscono contatti con l’ambiente artistico torinese, del quale accolgono i poveristi. Fra esse lo Studio Marconi di Giorgio Marconi, attivo dal 1965, ospita nel 1966 una personale di Aldo Mondino. Nel 1966 inaugura la sede milanese della Galleria Sperone, del torinese Gian Enzo Sperone, e nello stesso anno vi espongono Luciano Fabro48 , Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto e Piero Gilardi. Nel novembre del 1967 ritroviamo gli ultimi tre, in una collettiva che comprende anche Mario Merz, alla neonata galleria milanese De Nieubourg, poi ribattezzata Toselli, di Franco Toselli. A questa data si è appena conclusa la mostra, costitutiva del gruppo poverista, Arte povera – Im-spazio, organizzata da Germano Celant a Genova presso la Galleria La Bertesca, attenta, insieme alla De Foscherari di Bologna, allo sviluppo di questa nuova tendenza. Per quanto riguarda le vicende artistiche della Capitale, che nei secondi anni Sessanta condivide con Milano e soprattutto con Torino l’interesse verso i poveristi, la città, come anticipato, è contrassegnata sin dagli anni Cinquanta da uno stretto rapporto di interscambio con gli Stati Uniti. Il reciproco avvicinamento culturale dell’Italia e dell’America si era avviato nel secondo dopoguerra, quando la nostra nazione aveva cominciato a godere degli aiuti economici garantiti dal piano Marshall. All’indomani del conflitto mondiale Lionello Venturi, tra gli antifascisti rientrati in Italia dall’esilio e dalla prigionia, aveva partecipato alla rinascita e al rinnovamento della cultura italiana informando il contesto artistico sulle avanguardie newyorkesi. La Biennale di Venezia del 1950 aveva inoltre dato grande rilievo ai lavori di Jackson Pollock, Arshile Gorky e Willem de Kooning, presentati nel padiglione degli Stati Uniti, e nello stesso anno Peggy Guggenheim aveva curato presso il Museo Correr di Venezia la prima personale italiana di Pollock. Sono solo alcuni degli eventi che nei primi anni Cinquanta portano la generazione di Piero Dorazio, Afro e Toti Scialoja a progettare viaggi oltreoceano, mentre giungono a Roma gli americani Robert Rauschenberg e Cy Twombly. A cavallo fra i decenni Cinquanta e Sessanta la città della “dolce vita” gode anche della rete di relazioni internazionali stabilite dall’Art Club, “associazione artistica internazionale indipendente”, secondo quanto precisava appunto il primo Bollettino, fondata nel 1945 dall’ex futurista Enrico Prampolini e dal pittore polacco Joseph Jarema e attiva fino al 1964. L’Art Club, attento alla diffusione delle ricerche internazionali astratte attraverso un’intensa attività di mostre e dibattiti, fonda diverse sedi sul territorio italiano e all’estero e si collega con il M.A.C. di Milano, con André Bloc e i francesi del Gruppo Espace e con i raggruppamenti romani di Forma 1, Origine e dell’Age d’Or. Insieme all’associazione Age d’Or organizza inoltre nel 1951 la mostra Arte Astratta e Concreta in Italia presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, diretta dalla giovane Palma Bucarelli. Certamente le figure fondamentali di questo fu Lucio Fontana comunemente conosciuto come l’artista dei “Tagli” e dei “Buchi”, nasce scultore ed è tale almeno per i primi venticinque anni di attività. È solo all’età di cinquant’anni, infatti, che inizia a forare le sue tele ed è solo a sessant’anni circa che inizia a praticare su di esse i suoi celebri tagli. La stessa azione di perforare o lacerare la tela, per cercare un altro spazio, una terza dimensione, non può essere definita pittura in senso classico. Invero, pur adoperando nel corso della sua carriera diversi mezzi e supporti, dal gesso alla terracotta, dalla ceramica al grès, dalla tela al legno, non è possibile distinguere un Fontana pittore dal Fontana scultore. Egli persegue “un’arte totale”, scegliendo di superare i limiti della forma e dei generei per sviluppare una maniera, uno stile, che non trova distinzione tra scultura, pittura o architettura, ma che ha la finalità di coinvolgere l’uomo nello spazio immateriale delle sue invenzioni. Ad intuire tale tratto distintivo è stato già Lionello Venturi che, in un articolo de “L’Espresso”, afferma: «è difficile parlare di Lucio Fontana (1899), che non si sa bene se sia più scultore o pittore, che ha una genialità senza limiti Forse la colpa è nostra, che non abbiamo sufficiente fantasia per seguirlo.» Se Fontana ha potuto definirsi come “artista spaziale” è perché ha scelto lo spazio come proprio raggio d’azione creativa e immaginativa. Questo primo capitolo ha, dunque, la finalità di delineare l’attività non marginale del primo Lucio Fontana scultore – se è possibile definirla tale, separandola da quella di pittore attraverso un’analisi storico-critica dagli inizi in Argentina presso l’atelier del padre, fino alle ultime sculture “missilistiche” realizzate sul finire degli anni sessanta, con l’intenzione di provare a delineare meglio come si sia sviluppata la sua tecnica in ceramica. Lucio Fontana nasce il 19 febbraio del 1899 a Rosario di Santa Fé, in Argentina. Il padre, Luigi Fontana, originario di Varese, era anch’egli scultore ed aveva avviato in Argentina una profittevole azienda specializzata in scultura cimiteriale e monumentale. È facile, quindi, comprendere come, fin da giovane, la formazione di Lucio sia orientata alla carriera artistica. Affidato allo zio matero, Tiziano Nicora, studia in Italia presso l’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di Milano scuola di capomastri e costruttori edili – e contemporaneamente al Liceo Artistico annesso all’Accademia di Brera. Nel 1916 è ammesso alla Scuola Superiore di Arti Applicate all’Industria, nel Castello Sforzesco, dove studia presso la sezione di architettura. Interrompe gli studi nello stesso anno per arruolarsi come volontario nell’esercito italiano, allora impegnato nella prima guerra mondiale. Qui raggiunge il grado di sottotenente di fanteria, ma a causa di un infortunio e del conseguente congedo ritorna a Milano dove, ripresi gli studi, ottiene il diploma di perito edile. Nel 1922, in seguito alla morte del fratellastro Delfo, figlio di seconde nozze del padre con Anita Campiglio, fa ritorno in Argentina, dove inizia a lavorare nell’azienda paterna, Fontana y Scarabelli. Nel 1924 vince un concorso, bandito dall’Università di Medicina del Litorale, con un bassorilievo commemorativo dedicato a Louis Pasteur e decide di mettersi in proprio aprendo uno studio personale in calle España 565, con la finalità di condurre una ricerca autonoma, indipendente dalla committenza e dall’influenza del padre. Il vero esordio professionale avviene nel 1925, quando partecipa all’ VIII Salòn de Bellas Artes di Rosario, nel quale espose l’opera Melodias «di fatto un ritratto femminile condotto in gagliardo e sommo plasticismo orientato all’accentuazione dell’espressività psicologica, diresti d’eco remota di matrice europea dopo Rodin, fra Bourdelle e Despiau» . Tuttavia, già l’anno dopo, nel Ritratto di Juana Zocchi, esposto nel I er Salòn de Artistas Rosarinos è evidente come la sua ricerca si sia orientata verso un rifiuto del modello tardo rodiniano dimostrando, di contro, un interesse per la scultura cubista a lui contemporanea, rappresentata all’epoca, in Argentina, da Antonio Sibellino, ispirato sia al lavoro di Bourdelle che a quello di Archipenko e Lipchitz. In questi primi anni di attività, quindi, l’arte di Fontana è orientata a un gusto ufficiale, dall’accento simbolista e tardo secessionista, come appare già in alcuni disegni realizzati per il numero di febbraio del 1925 del mensile “Italia”, edito dalla Società Dante Alighieri di Rosario di Santa Fe. In realtà sono due le principali influenze artistiche di questi anni: la prima è rappresentata dall’arte di Archipenko «che lo seduce per l’eleganza e la disinvoltura della forma», come già aveva rilevato Edoardo Persico, mentre la seconda dall’artista simbolista Aristide Maillol, messa in evidenza da Enrico Crispolti in tempi più recenti. Quella di Maillol è un’influenza priva delle citazioni alla mitologia classica, dove però emerge «una figurazione tendente ad accentuare valori plastici assoluti: un plasticismo denso e turgido, con una continua rotondità delle superfici levigate.» Solamente nell’opera La mujer y el balde è stato evidenziato un accento più classicheggiante; emerge, infatti, un plasticismo che predilige la figura, il volume e l’incidenza della luce. L’influenza del sodo plasticismo di Maillol risalta, con maggiore evidenza, in opere come Maternidad, Mary o ancora nel monumento El puerto de Rosario a Jauna Blanco. L’arte di Maillol rappresentava a quel tempo la restituzione di pienezza plastica in senso figurativo in contrapposizione al vitalismo rodiniano. Dall’altra parte, invece, la sintesi plastica dinamica e il sodo plasticismo di Archipenko, emergono in opere come un piccolo nudo del 1926, oppure in la Mujer y el balde, databile tra il 1926 ed il 1927. In entrambe le opere emerge un interesse verso volumi articolati liberamente nello spazio, a cui si unisce la stessa maniera di Archipenko di torcere le figure a cui si unisce un certo decorativismo ancora di ascendenza secessionista e déco. D’altro canto la presenza di Maillol non abbandona il giovane scultore quando, nel 1927, lascia la carriera, già avviata dal padre, nella città natale, per tornare in Italia, con il desiderio di aggiornarsi con le nuove tendenze culturali europee. Arrivato in Italia, scrive all’amico Julio Venzo: « sono a Milano da pochi giorni e già mi sento rinascere a nuova vita. Ieri sono andato a vedere l’Esposizione Permanente di Milano, in cui quest’anno prevalgono i novecentisti. La scultura è stata una delusione l’unico è Wuilt veramente meraviglioso, credo che se resto a Milano frequenterò il suo studio, si dà il caso che mio cugino architetto sia intimo amico di Wuilt . È grazie alle conoscenze del cugino, l’architetto Bruno Fontana, che Lucio inizia a frequentare lo studio dello scultore simbolista Adolfo Wildt, iscrivendosi successivamente ai suoi corsi di scultura, presso Accademia di Belle Arti di Brera, durante l’anno accademico 1927-28, dimostrando una maestria tale da essere promosso, a conclusione del primo anno, direttamente al quarto. L’arte di Wildt presenta una forte matrice romantica di impronta simbolista che risente, con riferimento ad esempio all’uso dell’oro e per l’esaltazione della superficie, delle Secessione Viennese; le sculture dell’artista italiano sono caratterizzate da superfici estremamente levigate e smaterializzate. Le prime opere milanesi di Fontana risentono molto dell’influenza del maestro, come si evince, per esempio, in El Auriga, presentata all’esame di diploma. Conosciuto anche come Eroe che doma il cavallo è già evidente come i passaggi dei paini, concavi e convessi, tipici dell’arte del maestro, si modulano nella luce con una sintesi che rivela una predisposizione all’ambientazione spaziale . Oggi perduti, ma visibili tramite una fotografia del suo studio in via Generale Genova 27, sono un Cristo in croce e un San Sebastiano, evidentemente di destinazione funeraria, dove nel gusto calligrafico del San Sebastiano, impostato su uno sfondo piatto, è visibile la lezione wildtiana. Di contro, l’articolazione spaziale della figura stilizzata e la composizione dei segni nello spazio rimandano ancora all’influsso di Archipenko. Queste opere dimostrano come Fontana sia, in questo primo periodo di attività, ancora impegnato nella scultura cimiteriale, soprattutto presso il Cimitero Monumentale di Milano. Questa esperienza rappresenta certamente una “palestra” utile per misurarsi con la scultura architettonica, ma, è, di contro, comunque legata al gusto della committenza e alla necessaria approvazione di una Commissione Tecnica, che ha il compito di verificare l’artisticità del progetto. Inoltre, il gusto dell’epoca è ancora di fortemente improntato al Decò e l’arte di Wildt è caratterizzata in massima parte da un linearismo secco, che rende l’immagine estremamente polita e levigata, quasi scarna. Testimonianza di questa attività è una Madonna in bronzo per la Tomba Mapelli, commissionata nel 1927, ma realizzata nel 1928, in collaborazione con il cugino Bruno ed Ercole Faccioli. La levigata fusione del bronzo denuncia l’influenza di Wildt, che in quel periodo è impegnato nella realizzazione di una Madre per il monumento Ravera, realizzato nel 1929, di cui Fontana ha sicuramente visto i disegni. Al Monumentale di Milano, Fontana lavora anche su commissione di Costantino Lentati alla realizzazione di due loculi. Il primo è quello per la madre, Emilia Pasta, mentre il secondo per la figlia Giuliana, morta precocemente all’età di tre anni. La Madonna Pasta appare la trasposizione in bassorilievo della Madonna Mapelli, qui la lezione del maestro emerge non solo nell’uso dell’oro, steso entro la cavità del marmo, ma soprattutto nella lavorazione dei piani fino alla trasparenza. Per la figlia del committente, Fontana esegue invece un grande Angelo con putto alato ricavato all’interno di una nicchia. Ancora figlia della scuola wildtiana è la politezza formale delle figure, le cui forme vengono quasi astratte e geometrizzate attraverso linee incise e un secco panneggio; ma nella grazia dei volti e nella leggiadria dell’intonazione è stata notata un’affinità con le figure di Giò Ponti e le ceramiche di Arturo Martini. Qualche tempo dopo, dallo stesso Lentati, gli è commissionata la tomba per il suocero Ettore de Medici, padre della moglie Maria, morto nel 1928. Questa è formata, secondo il progetto originario, dalla celebre scultura Dormiente, esposta successivamente alla II Sindacale Lombarda, che funge da coperchio ad un semplice sarcofago in granito. Considerata da Persico come realizzata «nel più puro stile novecentista», è stata accostata da Crispolti al sodo plasticismo di Maillol, mentre Paolo Campiglio la avvicina, per il primitivismo con cui viene delineato il volume della figura umana, alla produzione grafica di Domenico Rambelli. Inoltre, il senso plastico delle figure e la concezione primeva delle masse si avvicinano molto alla plastica di Mario Sironi, filtrata da altri artisti novecentisti attivi nel Cimitero Monumentale di Milano. Allo stile di Sironi e Carrà si accostano, ancora, i bassorilievi in bronzo posti ai lati del sarcofago e di cui ci rimangono i bozzetti in gesso. Il bassorilievo raffigurante ‘La famiglia’, se da un lato ricorda le composizioni di Carrà come l’Attesa o Le figlie di Lot, dall’altro rimanda alla scultura di Martini per la loro figurazione incerta e a tratti scabra e incisa. Mentre il secondo rilievo, quello rappresentante la Vedova, anticipa con il suo profilo squadrato quella che diventerà l’opera simbolo della rottura con l’arte del novecento, l’Uomo Nero, esposto nel 1931 alla sua prima personale milanese. Infine, in ambito cimiteriale, è da citare la Tomba Berardi che rappresenta “la sintesi plastica novecentista, nella compattezza dei volumi, nella sobrietà della composizione, nell’accordo preciso tra architettura e scultura”. In conclusione, la lezione di Wildt si scopre nell’uso dell’oro, costante sia in opere successive che in altri esempi di questo periodo, come nel caso del Ritratto di Teresina o del Fiocinatore. Come ha voluto ricordare Guido Ballo è proprio da Wildt, «che esasperava i piani concavi e quelli convessi, che facevi i buchi negli occhi», che si può individuare la matrice concettuale da cui Fontana trae l’dea prima dei Buchi e successivamente dei Tagli. Intorno ai primi anni Trenta, la ricerca di Fontana si sviluppa e si orienta, di fatto, su almeno tre fronti: le sculture in terracotta colorata del 1931 – 1932, le celebri tavolette graffite e una serie di rilievi in terracotta dalle forme anatomiche appena definite, che trovano il loro antecedente diretto nell’Uomo nero. È con quest’opera, in particolare, esposta tra gennaio e febbraio del 1931, alla sua prima mostra personale, presso la galleria del Milione, che avviene la rottura con l’arte del Novecento. Tale scultura rappresenta «il primo segno di liberazione, un primitivismo un po’ ingenuo e arbitrario» . Primitivismo non da ricondurre a quell’arcaismo culturistico della corrente tardo-metafisica italiana, che aveva in Arturo Martini il suo esponente di punta, ma piuttosto influenzata ancora della lezione di Ossip Zadikine e Archipenko. Purtroppo distrutta, dopo il secondo conflitto mondiale, l’opera è stata realizzata in gesso, sul quale è stato versato del catrame, «dove, in una compattezza di massa instaura motivi strutturali paralleli alla ricerca di Wotruba», cioè la stessa maniera, appunto, rendendo la figura quasi un solido geometrico. L’uomo nero è il superamento della lezione classica verso l’espressionismo, a cui è stato attribuito, tra l’altro, il significato del terrore di ciò che non c’è, lo specchio del non essere. La materia graffiata e incisa rimanda ai primi graffiti delle caverne, all’arte primitiva. Primitivismo che emerge soprattutto per il modo istintivo, arbitrario, con cui è stata realizzata la figura, «massivo concretamente, non idealmente, primevo come magma originario, e non come protostorico in senso più o meno storicistico». Con quest’opera Fontana, quindi, rompe con il passato, con la scultura classicheggiante del Novecento italiano che ha cercato di restaurare la figurazione dopo l’iconoclastica espressionista, futurista e cubista per aprirsi verso l’arte europea. Da questo momento in poi l’arte di Fontana non segue una cronologia logica, ma emergono più ricerche differenti; si susseguono l’un l’altra, come se già, fin dall’inizio, esistessero in lui e solo ora trovassero attuazione. Dopo l’Uomo nero, Fontana inizia a utilizzare materiali come il gesso e la terracotta, forse per quest’ultima influenzato da Arturo Martini, il quale ha avuto il merito di aver rivalutato criticamente le fonti scultoree italiane, rielaborando la scultura etrusca, il torso e il frammento in terracotta. Fontana, forse sotto il suo influsso, verso la fine del 1929, inizia ad utilizzare la terracotta, non come rivisitazione storico-archeologica, ma come mezzo per accentuare l’immediatezza dei caratteri e della forma. Si avvale del suddetto materiale soprattutto per quella serie di rilievi figurativi, appena consistentemente colorati, quali – inter alia – Le amanti dei piloti. Schiacciate, quasi da sembrare un bassorilievo, sono definite da un profilo inciso nella materia dai colori accesi, quasi “fauves”, e lo stesso appiattimento dà alla composizione un spetto al limite tra scultura e pittura. La materia, invece, “appena rappresa, a rigonfi e depressioni improvvise, come di lava, “sa” di spazio, partecipa allo spazio.” Il sopracitato primitivismo di Fontana de l’Uomo nero viene evidenziato, ancora di più, nelle celebri tavolette graffite in gesso, realizzate a partire dal 1930, esposte per la prima volta, presso la Galleria del Milone il 14 gennaio del 1935. Definite da Carlo Carrà “rabeschi plastici”, rappresentano, con la loro figurazione molto sintetica e lineare, la perfetta fusione tra scultura e pittura e uniscono alla suggestione surrealista, anzi parasurrealista, del segno inciso in maniera automatica, l’astrazione organica e fitomorfa. La terracotta, per eseguire ritratti femminili e piccole sculture a tutto tondo. Qui il suo spontaneo primitivismo è risolto rendendo una figurazione al limite della narratività poichè la materia è trattata ancora in maniera elementare e informale. Le sagome delle figure risultano nuovamente segnate dalla materia graffiata e definita solamente con il colore posto a freddo che diventa il vero protagonista. Sono queste le opere a cui Crispolti fa riferimento parlando di “l’espressionismo fenomenologico di Fontana”, cioè di «una figurazione immersa del divenire della materia», «radicalmente opposta al naturalismo lirico della scultura di Martini». Sono opere tra cui Bagnante e Gli amanti, presentate come arredo alla V Triennale di Milano del 1933. La Bagnante è stata realizzata per decorare il bordo piscina della Villa Studio per un artista eseguita dagli architetti razionalisti Figini e Pollini, mente Gli amanti sono pensati per la Casa del Casa del Sabato degli Sposi, opera del gruppo BBPR. Secondo Argan, «il colore non è un fenomeno di superficie, ma è il principio plastico, spaziale, della scultura» cioè viene utilizzato come mezzo per accentuare la superficie, al fine di rendere un risultato maggiormente drammatico. Altre opere, simbolo di queste ricerche in senso coloristico, sono Fiocinatore e la Signorina seduta. Di quest’ultima si è detto come sia un’opera che guarda ancora al passato dialogando con certe figure femminili di Martini, con il Portiere accovacciato di Manzù e ancora con Archipenko e Zadikine, ma allo stesso tempo è piena di futuro poiché, per i colori con cui è realizzata (oro e nero) due colori non colori, astratti sembra rappresentare la stessa aspirazione all’assoluto di Yves Klein. Il Fiocinatore tra il 1933- 1934 realizzato interamente in oro, come fontana per il Mercato del pesce di Milano, sembra piuttosto un ritorno all’ordine, se confrontata con l’Uomo Nero, ma è piuttosto l’opera che più si avvicina al calco aureo di Arman realizzato da Yves Klein nel 1962. Contemporaneamente alle sculture figurative, la ricerca di Fontana si orienta verso la realizzazione di una serie di sculture astratte, eseguite a partire dal 1934, esposte per la prima volta nella celebre mostra alla Galleria del Milione nel gennaio del 1935 (la prima mostra di Arte Astratta in Italia) che è riproposta poco tempo dopo alla 1 a Mostra Collettiva di Arte Astratta Italiana a Torino, tenutasi presso lo studio di Felice Casorati ed Enrico Paolucci. Sono semplici forme ritagliate nello spazio o strutture dinamiche articolate in modo da captare il vuoto, bifronti, di piccole dimensioni, accostamenti di ferro e gesso, linee spezzate che si piegano e che si curvano secondo linee geometriche “fitomorfiche”. Nascono dall’intuizione delle tavolette graffite e hanno il loro miglior esempio nella, purtroppo oggi dispersa, scultura astratta per l’atrio di casa Ghiringhelli in Piazzale Lagosta, che rappresenta il primo esempio di astrattismo italiano su scala monumentale. La loro forma geometrica è stata considerata più semplice di quelle di Arp o dei cubisti ed è stato notato da Palma Bucarelli che, per la prima volta, la linea più elementare dei segni assurgeva a elemento plastico autonomo, unica determinante dello spazio. Anche se la forma di queste sculture viene definita geometricamente sulla base dell’imprevedibilità e della sperimentalità queste ultime non hanno, come le opere di Calder o di Melotti, il medesimo rigore dei calcoli matematici, ma sono tali per il disequilibrio o l’equilibrio involontario che nasce dalla sua immaginazione. Nel palare di questo artista la mente corre subito ai tagli. Queste tele incise in maniera netta da parte dell’artista argentino sono probabilmente i suoi lavori più famosi. Ma prima di tutto possono essere considerati come le opere simbolo del movimento Spazialista, fondato dallo stesso Fontana nel 1947 con la scrittura e pubblicazione del primo manifesto dello spazialismo. Scritto in durante un periodo in Argentina il manifesto spazialista pone le base teoriche di questo movimento e pone le basi per gran parte del lavoro dell’artista argentino. Questa corrente artistica aveva come obiettivo primario quello di “superare” l’arte classica, diventata agli occhi di Fontana stagnante e vecchia. Questo doveva avvenire attraverso la produzione di nuove opere con mezzi innovativi frutto dell’evoluzione tecnica e tecnologica. Il principio cardine doveva essere il superamento dell’arte naturalistica attraverso l’utilizzo di nuovi elementi e strumenti come la luce o, appunto, lo spazio. Ad esempio, possiamo ricordare la Struttura al neon che l’artista creò in occasione della IX Triennale di Milano. Fontana fonda quindi questo movimento con lo scopo di superare determinati limiti in cui l’arte precedente costringeva l’artista. L’obiettivo dello spazialismo diventa quindi quello di entrare e muoversi in nuove dimensioni inserendo il tempo e lo spazio all’interno della produzione artistica. Nonostante la loro fama le prime opere spazialiste di Fontana non furono i tagli ma un ciclo di opere chiamato “Buchi” che consistevano in spirali create appunto bucando la tela. Il ciclo dei buchi verrà portato avanti a lungo ma con alcune differenze. I buchi disordinati delle prime opere lasciano infatti spazio all’ordine con cui l’artista crea i suoi buchi costruendo costellazioni ordinate e regolari. Il ciclo dei buchi costituisce solo una delle molteplici parti che costituiscono il grande gruppo dei Concetti spaziali. Sicuramente i Concetti spaziali più famosi sono i Tagli che Fontana incominciò a produrre a metà degli anni Cinquanta. Il senso e l’interpretazione di queste opere sono sempre stati molto vari. Possiamo però dire che Fontana con un solo gesto, non solo crea il taglio ma riesce anche ad andare oltre il confine della tela. Con i tagli e i buchi l’artista mette in discussione la bidimensionalità dello spazio pittorico mostrandocela come una banale superficie in cui ogni rappresentazione è illusoria. Con la lama Fontana riesce a creare una terza dimensione oltre la tela in pieno stile spazialista. Ma ritornando alla figura di Carla Lonzi e per meglio tracciare una storia delle relazioni tra arte e femminismo nell’Italia degli anni Settanta e nello specifico del contesto romano, risulta d’obbligo passare per l’esperienza di una delle protagoniste principali della riflessione teorica femminista del nostro Paese, Carla Lonzi. L’interesse nei confronti di questa pensatrice si rivela in questa sede determinante, perché l’approdo al femminismo si verifica dopo un’intensa attività nell’ambito della critica d’arte. Il lavoro di Lonzi come critica è passato per lungo tempo inosservato, sovrastato dal peso della teorizzazione femminista che si rivela, dopo una lunga riflessione, nel 1970 con il rivoluzionario Manifesto di Rivolta Femminile, oggi pietra miliare del pensiero femminista italiano e internazionale. Tuttavia un’ulteriore causa della mancata identificazione di Carla Lonzi come critica d’arte risiede nella persona di Lonzi stessa. Il passaggio al femminismo determinò un completo abbandono, o meglio un rifiuto, di qualsiasi forma di cultura, prima fra tutte di quella che le era appartenuta e in cui aveva creduto di potersi riconoscere: l’arte. Ciononostante è possibile oggi rintracciare delle linee di continuità nell’esperienza di questa pensatrice, a partire dall’impegno radicale e totalizzante che caratterizza prima il ruolo di critica e poi quello di femminista. Il passaggio per Carla Lonzi è doveroso anche a livello cronologico. Prima di tutto per la pubblicazione nel 1969 di Autoritratto, precoce esperienza di entrata del privato in ambito culturale alla figura di Lonzi è inoltre legata la nascita di Rivolta femminile, uno dei primi gruppi femministi italiani, fondato a Roma nel 1970. Laureatasi in Storia dell’arte a Firenze nel 1956 con Roberto Longhi, Lonzi rifiuta la proposta di pubblicazione del suo lavoro, rinunciando così alla professione accademica. Nel 1960 comincia a lavorare a Torino presso la Galleria Notizie diretta da Luciano Pistoi, attraverso la quale entra in contatto con gli artisti che occuperanno le pagine di Autoritratto. Nel frattempo collabora regolarmente con il periodico culturale della RAI, “L’approdo letterario”, e con “Marcatré” nella rubrica Discorsi, lasciando emergere da subito un atteggiamento insolito. Dalla forma usuale dell’intervista, il rigido e strutturato alternarsi di domanda e risposta, si arriva a un fluire più libero di pensieri e parole, fino alla sostituzione delle questioni poste agli artisti con i puntini di sospensione. Così facendo Lonzi sottrae al critico d’arte ruolo e ragion d’essere, eliminando il tradizionale compito di direzione e organizzazione del dibattito. Lo scetticismo nei confronti della critica d’arte è già messo in questione nel corso degli anni Sessanta. Autoritratto, come detto, esce nel 1969, stampato dall’editore De Donato in poche centinaia di copie. L’autrice monta liberamente le conversazioni che ha registrato in momenti distinti nel corso di cinque anni, tra il 1965 e il 1969, con quattordici artisti tra i più significativi rappresentanti dell’avanguardia italiana degli anni Sessanta: Carla Accardi, Getulio Alviani, Enrico Castellani, Pietro Consagra, Luciano Fabro, Lucio Fontana, Jannis Kounellis, Mario Nigro, Giulio Paolini, Pino Pascali, Mimmo Rotella, Salvatore Scarpitta, Giulio Turcato, Cy Twombly. Il testo non è diviso in sezioni né tantomeno ordinato cronologicamente; si ha piuttosto l’impressione di un unico lungo incontro, una sorta di grande convivio, a cui Lonzi prende parte ponendo quesiti e formulando opinioni. I temi trattati sono molteplici, dal processo del fare artistico, al rapporto con la società e la critica, al confronto ossessivo con gli artisti americani, fino a questioni apparentemente slegate dal mondo dell’arte. Ne deriva un lavoro strettamente connesso al vivere quotidiano: le pagine di Autoritratto restituiscono efficacemente porzioni di vita. La trascrizione del parlato aderisce il più possibile al momento vissuto, garanzia di autenticità di quanto avvenuto. L’uso del registratore consente di mantenere intatto l’episodio a favore di un vero e proprio «culto della cosa accaduta». L’autoritratto a cui allude il titolo è contemporaneamente unico e plurimo. Ogni artista si ritrae singolarmente con le proprie parole, ma forse più verosimilmente è la stessa Lonzi che ritrae sé stessa, artefice arbitraria del montaggio di quanto viene pronunciato, responsabile della ‘forma’ del testo. Il discorso è ‘modellato’ da Lonzi, segue un percorso preciso da lei pensato, seppure tramite una mescolanza di parole sue e parole di altri. «Io voglio stare vicino agli artisti e liberarmi io», dichiara. Proprio per questo primato della distanza, della visione, della personalizzazione risulta paradossale pensare che accanto alle vergini bizantine e ad alcuni miti pop anche Carla Lonzi abbia rischiato una sorte simile. Archetipo incarnato dell’anti-mito lei che abbandona la produttività dell’autrice per riparare lontano dagli sguardi da sotto in su che l’autorità produce Lonzi si presta bene, con le sue tracce sparpagliate scritti, fotografie, relazioni e i suoi modi non convenzionali registrazioni, ricerche, legami, a essere fatta icona. A lungo in bilico tra una vaga indifferenza troppo lontana dalle rotte consuete e una fiera celebrazione lontana dalle rotte consuete, ella è stata oggetto di una strana forma di appropriazione da parte di autrici, teoriche e artiste di tutti i sessi che ne hanno visto il valore. Distinguo autrici, teoriche e artiste poiché l’entrata nel mito di Carla Lonzi ha proprio a che fare con una lettura parziale che tiene conto solo di alcuni suoi tratti, elidendone altri. Tale scrematura avviene per lei in maniera particolare, ovvero distinguendo tra un pre- e un post-, tra la critica d’arte e la femminista, tra colei che è nel mondo e colei che celebra la differenza attraverso l’assenza. Così, del suo vissuto si racconta una rottura improvvisa, eclatante tra l’esperienza dell’arte e quella del femminismo, rischiando di offrirne un ritratto statico e distante, le cui linee di contorno saturano il quadro. Fuor di metafora, sezionare la vita di Lonzi in questo modo dà luogo a una «narrazione che ha avuto l’effetto di rendere opaco proprio il durante» , ovvero il percorso non il momento, o lo scoppio attraverso il quale il femminismo “si fa”. L’inizio, canonico, è Autoritratto. Tuttavia, nella lettura stimolante e fresca che ne dà Zapperi, quel testo appare come un’epigenesi. Lì, Lonzi devia dal ruolo della critica d’arte sia in quanto persona con una certa autorità, sia in quanto modalità di prendere visione (sguardo ed epistemologia) per istituire un rapporto orizzontale con gli artisti. Composto delle registrazioni delle conversazioni con questi ultimi, il testo lascia che siano gli artisti stessi i soggetti della parola dell’arte, presenti e non rappresentati. Al contempo, la critica d’arte (persona e opera di mediazione) non scompare: è la sua presenza a garantire la diffusione di queste voci. Lonzi è in quel lavoro il soggetto-prisma che incamera la luce e, attraverso l’operazione di montaggio di parole e immagini, la diffrange. Seguendo il percorso trasversale tracciato da Zapperi, la ricomposizione della complessità del pensiero di Lonzi avviene senza forzature, non per tappe, ma per transizioni. Quando non relegato nel “pre-” della retorica sminuente della rottura, Autoritratto si può leggere come il canovaccio sul quale verrà organizzato un processo di liberazione femminile che, sebbene prenda le fattezze di una pratica molto personale il “partire da sé, l’autocoscienza, avrà delle ripercussioni dirompenti, molteplici e plurivoche, tanto da caratterizzarsi «come una pratica collettiva potenzialmente estendibile al di fuori del gruppo» .In Autoritratto, Lonzi si appropria, quasi istintivamente, essendo il femminismo ancora non fatto di una dimensione collettiva, in cui la partecipazione e i rapporti consentono lo schiudersi delle differenti soggettività. L’avvicendarsi di registrazione presenza degli artisti e montaggio presenza di un soggetto che ne fa esperienza e se ne appropria è una pratica sperimentale che si lega ai tanti fili che poi andranno a intessere il femminismo di Rivolta femminile. Qui già si manifestano la vocazione al riportare gli scambi su un piano orizzontale e la necessità a quella connessa di logorare i ruoli che andrebbero occupati. Il “disertare i ruoli”, la messa in mora di una istituzionalizzazione della propria soggettività, rimanda a sua volta alla sperimentazione costante da cui far emergere una soggettività differente. Ancora, all’interno di un lavoro dalla possibile disposizione accademica, l’uso di tecniche sperimentali e l’integrazione delle conversazioni private, «aspetti tradizionalmente rimossi dalla vita sociale» , guadagnano l’allure di un preludio. Così, si vede come dalla modalità di composizione di questo esperimento affiorino già i «temi dal “significato apertamente politico» della ripetizione, dell’anacronismo e dell’interruzione” poi maturati appieno nel 1972 in Sputiamo su Hegel. Le conversazioni dirette momento quanto mai contingente estendono (e modificano) il loro valore nell’essere tramutate in segni materiali che si nutrono non solo dell’ascolto, ma anche e forse in primo luogo di un gesto di mediazione che li inserisce in un contesto più ampio e complesso. La tecnica della registrazione è la prima esperienza di quello che diventerà poi una «sorta di palinsesto» , sul quale si struttureranno il diario (Taci anzi parla. Diario di una femminista) e il congedo dal compagno Consagra (Vai pure), opere fondazionali per il femminismo di Lonzi. Il montaggio, la scrittura del diario, la trascrizione sono forme distinte, ma contigue tramite le quali rivalutare, a posteriori, un momento contingente ri-presentandolo, esse “segnalano il momento in cui passato e presente si sovrappongono, riconfigurandosi uno attraverso l’altro” . Questo turbinare di momenti, sfilaccia il tempo della storia linea retta che progredisce, tipica di una specifica lettura sui cui si è invitati a sputare, portando alla luce una temporalità fratturata, scandita in primo luogo dalla rivalutazione del presente, quale momento unico, contingente e indomabile in cui il soggetto “si incarna”, delineandosi «nei termini di una potenzialità all’interno di una dinamica collettiva» . In questa temporalità c’è, dice Lonzi, “tutto”. L’intreccio di passato, presente e futuro si pensi ancora al registratore: ascoltare nel futuro un presente che è passato e che viene, nel presente, rimodulato convoglia pratiche per loro natura plurali, collettive e “deperibili” «capaci di innescare processi di soggettivazione che contrastano il proprio assoggettamento» . Ritorna a questo punto centrale il legame che corre tra la femminista e la critica. Infatti, come ben si coglie dalla ricostruzione di Zapperi, è nel rapporto con gli artisti e, soprattutto, con le artiste che Lonzi capisce che l’arte (come chi la produce) non può farsi vettore di quelle forme liberatorie di costituzione del sé e di formazione dei legami. Di più, è a partire da una rinnovata concezione dell’arte impossibile da ottenere se non stando in quel dominio, agendo sui concetti a questa propri che si rende possibile l’articolazione di un pensiero politico imperniato sull’assenza. Andiamo per ordine: sono le incomprensioni con le artiste che gravitano intorno a Rivolta come Suzanne Santoro o quelle, dolorose, che gravano sui rapporti affettivi più intimi Carla Accardi e Pietro Consagra, che accompagnano l’autrice verso inquadramento dell’arte come ad appannaggio “maschile”. L’arte è un campo già strutturato, che presuppone il primato di un soggetto creatore, le cui produzioni possono essere fruite, al massimo possedute. Essa si mostra alfine una pratica istituzionalizzata, i cui prodotti presentano forti affinità con i frutti alienanti del lavoro. Così, la creazione artistica rimanda all’idea dell’unicità del creatore non del prodotto, attenzione, siamo nel mito, postulando l’asimmetria tra l’artista demiurgo e lo spettatore recipiente la cui soggettività si dà nell’accettazione passiva del prodotto. Se in Autoritratto l’interazione con gli artisti era un moto di soggettivazione, Lonzi capisce che l’arte non può avere una vocazione liberatoria quando si avvede che il “mito dell’unicità” che permea arte, attività artistica e artista non lascia spazio per la ritrazione, per il vuoto, per l’assenza. Forme, queste, dello stesso movimento che Lonzi farà femminismo. Il soggetto dell’arte non contempla la ritrazione, poiché pretende di riconoscere l’altra a partire da sé, piuttosto che aprirsi al riconoscimento di sé a partire dall’altra. Allo stesso modo, l’artista abbraccia l’autenticità quale attestazione di unicità individuale, invece di cercarvi l’appartenenza a una collettività riconoscendo il vuoto in sé, facendo vuoto di sé. E infine, la creazione artistica si cristallizza nella presenza, al cospetto del prodotto tangibile dell’attività artistica, mentre per Lonzi la creatività abita il ‘ruolo ricettivo’ che permette all’assenza di farsi compresenza, “permette di far esistere l’altra persona attraverso una relazione” . Eppure, attenzione. Tale movimento verso l’altra persona lo dimostra l’amarezza con cui Carla rimprovera ai suoi affetti assenti o presenti di non accordarle il giusto riconoscimento non è piano, oblativo, estraneo a dinamiche gerarchiche o verticalizzanti. Strappare Lonzi dal mito significa anche lasciar fiorire le profonde contraddizioni che abitano la persona, svelando il complicato rapporto tra vissuto e tessuto forse tra vita e arte della vita. Zapperi, con la levità della sua ricostruzione è difficile scrivere di vite convolute su cui molti, anche chi le ha vissute, hanno scritto, restituisce a Lonzi anche questa dimensione, riconoscendole una grande forza: non quella bruta di dare corpo a uno strappo netto chiusura, abbandono, rigetto, ma quella davvero tutta femminista per come Lonzi stessa tenta di definire cosa questo comporti di fare del fallimento l’occasione paradossale di una liberazione» . Interessante notare che questo passaggio viene confezionato da Zapperi a partire da un montaggio che mette in dialogo Lonzi con le teoriche queer e post-coloniali che molto hanno appreso dal femminismo, ma che anche molto lo hanno perturbato. Strane cose accadono a Lonzi: trascinata nel mito per l’appropriazione di coloro che le sono (state) prossime, viene riscattata da chi scompagina una distinzione sessuata che le è comunque fortemente appartenuta. Artiste e femministe si sono avvicinate troppo spesso a Lonzi come a un’icona, ne sono prova e qui dissento dalla lettura appassionata di Zapperi i modi in cui negli ultimi anni il mondo dell’arte ha rimesso in circolo la voce e, meno spesso, la persona di Lonzi attraverso installazioni, performance e produzioni che ne fanno brillare la radicalità netta. Lavori che strillano che “siamo tutte clitoridee” appiattiscono l’irsuta, agitata pienezza di «colei che si è ribellata all’identificazione con quel prodotto già finito e disponibile che viene chiamato “donna” . Forse, il riconoscimento ready-made offerto da alcuni tributi sancisce l’oscuramento di un femminismo che «coincide con il fallimento» . La mossa di liberazione è proprio quella che si esprime in una “postura di diniego”, in una “soggettività impossibile”, in qualcosa che non “incarna”, né “agisce in conformità” con un sistema unico, univoco, unificante di valori. Il soggetto imprevisto non si fa trovare lì dove deve essere, né nel tempo che le è proprio: questo il nodo. Qualsiasi forma di riconoscimento tradisce Lonzi, perché la tinta della sua politica, vita, esperienza è quella dell’ineffabilità:completamente fuori dal campo della visione, Lonzi tocca, anzi parla. Ed è questo il maggiore dei riconoscimenti: anche quando ritagliata, appiattita, saturata l’esperienza di Lonzi mette in atto degli effetti, muove degli affetti, fa fare cose. Delle quali Lonzi stessa forse si sarebbe lamentata. Concludo con un’immagine per tener fede all’impossibilità di essere fedeli alla lettera lonziana. La bella foto di copertina del libro mostra una Lonzi aureolata dalle luci di un luna-park, che con le braccia conserte si schermisce per poi elargire uno sguardo d’intesa inafferrabile rivolto, comunque, a qualcuno che è poco più sopra e a destra di chi fotografa, o di chi guarda. L’esposizione dunque segue, narrativamente, la conversazione tra Fontana e Lonzi, permettendo la realizzazione di un percorso antologico, ma non dogmatico, con lavori che toccano i momenti salienti e peculiari della ricerca fontaniana, un itinerario nel pensiero e nella pratica di un artista che riteneva che l’arte dovesse essere vissuta attraverso una nuova dimensione, all’interno della quale entravano anche nuove tecnologie e materiali. Vengono esposte opere di vari periodi, dalle sculture degli anni Trenta ai “Concetti spaziali” (“Buchi” e “Tagli”) dagli anni Quaranta ai Sessanta, oltre ai “Teatrini” e alle “Nature” bronzee; spettacolari sono l’enorme New York 10 del 1962, pannelli di rame con lacerazioni e graffiti,in dialogo con la luce a evocare la sfavillante modernità della metropoli, e la potentissima La fine di Dio, 1963, grande opera realizzata a olio, squarci, buchi, graffiti e lustrini su tela, emblematica della concezione spazialista e insieme religiosa dell’artista. Il percorso si chiude con opere di Enrico Baj, Alberto Burri, Enrico Castellani, Luciano Fabro, Piero Manzoni, Giulio Paolini, Paolo Scheggi, provenienti dalla collezione personale di Fontana, artisti più giovani da lui seguiti e promossi. Nel contempo lo sviluppo del Movimento Nucleare attraverso una selezione di opere firmate dai fondatori e dagli artisti che con loro collaborarono. e della seconda fase nucleare, in cui si accentua la materialità organica della pittura di Baj. Ma è Luigi Castellano a dettare il passo successivo, promuovendo nel 1958 l’omonimo gruppo formato da giovani artisti napoletani: Biasi, Del Pezzo, Di Bello, Fergola, Luca, Persico, e pubblicando nel giugno dello stesso anno il primo manifesto collettivo, accolto “in un clima di sgomento, di ostilità e di scandalo”. Punti di riferimento esterni alla città rimangono Baj e il gruppo nucleare, trovando inoltre una sponda utile e prestigiosa nella rivista Il Gesto, cui Biasi collabora negli stessi anni. Altro momento chiave giunge nel gennaio 1959, quando la mostra gruppo ’58+Baj alla galleria S. Carlo l’unica galleria che sostiene il gruppo, come viene sottolineato e il parallelo Manifeste de Naples, sanciscono definitivamente il connubio artistico tra la sperimentazione napoletana e quella nucleare, guardando contestualmente alle esperienze di Phases a Parigi e di Edda a Bruxelles: non a caso tra i corrispondenti di Documento Sud compaiono proprio Edouard Jaguer e Jacques Lacomblez, direttori delle due riviste. Contestualmente, è chiaro il ruolo strategico che in Italia svolgono periodici come i già citati Il Gesto e L’esperienza moderna, che non a caso condividono con la pubblicazione napoletana contraddistinta però da una maggiore “intransigenza” e autoreferenzialità autori e artisti, e rimandano nelle pagine pubblicitarie alle stesse riviste internazionali menzionate da Documento Sud, a sua volta posto tra le “riviste raccomandate” da Il Gesto. La rivista diretta da Castellano, in tale contesto, si propone di essere “il ponte” tra varie esperienze, “servendosi soprattutto (e non è un paradosso), di molte inedite tradizioni locali e del materiale di “colore” del vecchio Sud”, cui va aggiunto un certo orientamento generale verso tutto quello sperimentalismo centro-europeo (dalla seconda “vague” surrealista ai “Cobra”, ai “nucleari” ecc.) il quale sottolinea una certa aspirazione universale alla più spregiudicata libertà delle forme, così come è facilmente riconoscibile nel programma dell’avanguardia napoletana (e quindi nel suo organo) una ben precisa simpatia verso tutti i tentativi di instaurazione di una nuova infanzia figurativa (seconda una riscoperta in chiave “magica” del repertorio figurale). Così come vengono dichiarate le fonti ispiratrici, nella mappa culturale redatta all’interno di Documento Sud sono ben chiari anche i poli negativi e i riferimenti artistici da cui differenziarsi. È così che Mario Persico, in “Prima idea per una etica dello scandalo”, invita a superare le “ricette alla Fautrier o alla Wols” che portano ad allontanarsi da una adesione epidermica alla realtà, uccidendo “ogni percezione e sintomologia esistenziale”, e sostenendo invece “una mostruosa unità di pensiero”. Il pericolo, continua Persico, è di “schematizzare delle sensazioni”, riducendo “in formula ogni mistero Ogni cosa è registrata, lo stupore quasi non esiste, ogni immagine ha il suo freddo cifrario.”. La “condanna” di Wols e Fautrier nasce ovviamente dalla necessità di prendere le distanze da un tipo di pittura che, per le crettature della superficie e l’immersione materica del colore, avrebbe potuto essere avvicinata alle sperimentazioni degli artisti napoletani, che invece evidenziavano orgogliosamente la collaborazione con l’ambito nucleare, arricchito da risonanze surrealiste francesi e da un empito panico soggettivo unito alla riscoperta di una materia pittorica pulsante. Ne è chiaro esempio l’articolo “valore delle cose” , dello stesso Mario Persico, che si serve della pittura per spiegare il testo e viceversa, in un dialogo tipografico che costituisce uno dei tratti distintivi di Documento Sud. Gesto pittorico e scavo euristico procedono di pari passo, Persico si concentra sulla valorizzazione e riscoperta di “presenze paleontologiche ancora palpitanti” che progressivamente si impongono sulla superficie dell’opera, dando luogo a un incessante susseguirsi di “Fatti emozionali” enigmatici e sorprendenti di cui percepisco soltanto il fascino, Fatti o Cose che io definisco presenze ancestrali. Un naso, una bocca, un braccio, un organo genitale, o qualsiasi altra cosa può trasformarsi in un essere avente una propria “spina dorsale”. Siamo in effetti sempre all’interno di una dimensione figurativa che viene allentata e fratturata, percorsa da scoppi di colore, ma che pure resiste e riemerge. È una concezione che trova significativamente una stretta corrispondenza con le “immagini attive” teorizzate da Jaguer nell’articolo “Matiere + Mouvement = Feu” pubblicato nel primo numero del Il Gesto giugno 1955. Il critico francese invita gli artisti a creare delle immagini che sorgano dall’immediato confronto con il fluire della vita, liberando l’autore dalle costrizioni socio-culturali imperanti. Una tale volontà artistica non può che confliggere con un altro indirizzo coevo, cioè gli ultimi esiti dell’Informale, oggetto di specifici attacchi sia su Il Gesto che su Documento Sud: in particolare nel contributo “Così come vi furono un tempo dei poeti maledetti.” di Edouard Jaguer per quanto riguarda il primo; nell’articolo “invettive” di Guido Biasi e nel commento di Toni Toniato dedicato a Sergio Fergola per quanto riguarda il secondo. In particolare l’articolo di Jaguer, pur risalente al 1957, sembra funzionare da cornice di quanto emerso fino ad ora, affrontando una ricostruzione più ampia dello sviluppo storico artistico coevo, a partire dalla necessaria rivalutazione del Surrealismo e di Dada e dalla constatazione che le ultime urgenze artistiche nascono dall’“insurrezione contro la trascrizione puramente oggettiva della realtà”. Eppure, “questo movimento che va sotto il nome abusivo di ‘Tachisme’ o di ‘Informe’è evidente che non può minimamente pretendere di aver superato il surrealismo e l’arte astratta dei tempi eroici”. Aperture e chiusure seguono nel raggio di poche righe: Jaguer da un lato concede a Pollock di essere animato “da una foga spettacolare, da una specie di rabbia sacra introducendo tecniche ancora poco usate”, ma dall’altro precisa subito che tuttavia tali tecniche erano “procedenti in gran parte da scoperte anteriori, sovente di marca surrealista”, e che in ogni caso “non si trovava ‘LA’ questa ‘Art Autre’ di cui si è tanto parlato . O piuttosto, si, fu questo ‘ART AUTRE’, ma di fatto esisteva già dall’avvento di DADA”. Se nei primi artisti “informali” Jaguer ravvisa dunque delle note positive pur circoscritte e definite, è contro le derive attuali che viene puntato il dito “oggi assistiamo ad un’orgia reiterata di macchie colorate, sempre più aleatorie sprovviste delle connessioni psichiche che drammatizzavano l’opera di WOLS o di DE KOONING”, individuando invece le radici di un’avanguardia genuinamente rivoluzionaria nell’“azione considerevole del gruppo ‘REFLEX’, del movimento COBRA (1948-1951) e l’attività vigorosamente polemica del Movimento Nucleare di Milano”. Il commento di Toniato, si concentra sulla definizione della pittura come espressione di un dettato interiore, capace di tradurre “una aderenza assoluta alle strutture fenomenologiche e psicologiche” del mondo contemporaneo in “presenze emergenti di una concreta esperienza, di una situazione vissuta nelle sue varie dimensioni ed implicazioni”. Non c’è più il simbolo allora, quanto piuttosto “segni” che nascono da una “de-simbolizzazione dell’oggetto” e che portano in sé memoria del “mimetismo surreale di una loro originaria relazione”. In sostanza, Toniato vuole marcare la lontananza rispetto alla “sensibilità inerte di una incontrollata visione informale”, rispetto alla quale, a suo parere, le opere di Fergola, così come quelle degli altri pittori d’avanguardia napoletani, portano evidenti le tracce di un’archeologia visuale, da ritrovare sia nei ricordi personali, sia negli archetipi mitici meridionali: elementi questi che emergono anche nella scelta di disseminare la rivista di proverbi napoletani e di inserire spesso una foto dedicata a squarci di vita partenopei nelle prime pagine dei diversi numeri. Del resto, il ruolo chiave della figurazione viene giocato anche nel campo della scultura, come dimostra l’articolo di Marcello Andriani su Antonio Venditti , capace di riscoprire temi arcaici, perfino legati “allo stupore religioso del primo uomo: animali, gruppi di figure, e ancora figure, figure, figure…”, e di ridefinirli all’interno “di una mitologia nuova, complessa, misteriosa”. Venditti, sottolinea ancora Andriani, è “uscito sano e salvo dall’incubo dell’astrazione più amorfa”, facendo ritorno a una scultura in grado, oltreché di valorizzare gli aspetti formali, artigianali, della materia, anche di essere “metafora dei propri sentimenti” ancora una volta figurazione, elaborazione di un universo mitico ed echi di memorie personali si amalgamano all’interno di un’articolata ermeneutica interpretativa. Ma figurazione non vuole dire ovviamente scadere nel realismo, visto come conseguenza della negazione della libertà espressiva nei paesi socialisti. Lo testimoniano almeno due articoli: “L’avantgarde en Pologne” di Alexandre Henisz e “Realismo socialista nella Repubblica Democratica Tedesca” di Walter Fedler. Nel primo l’autore, parlando dell’Esposizione d’Arte delle 32 Repubbliche Popolari svoltasi a Mosca nel dicembre 1958, sostiene che il padiglione polacco fosse stato il più visitato, scandalizzando gli “ortodossi” del partito ed esaltando invece il pubblico per il tentativo di riprendere il dialogo con le avanguardie europee, interrottosi dapprima a causa della guerra e poi per le imposizioni staliniste di sviluppare un’arte di impronta realista. Anche Fedler, nel suo pezzo centrato sulla situazione delle arti nella Germania Est, non esita a denunciare una situazione in cui tutto è stato ridotto al livello di “una cattiva arte di fare manifesti”, soggetta alle volontà “dell’onnipotente funzionario culturale” e succube di un contenuto che non deve essere “in disaccordo con le direttive dell’ufficio politico . Vive soltanto il ‘realismo socialista’, l’arte di fare manifesti del pittore politico”. L’obiettivo dei due articoli è evidentemente quello di funzionare da raccordo con quelli rivolti contro l’Informale, per evitare che si ingenerasse nei lettori l’equivoco di assimilare la volontà di sovversione culturale del Gruppo 58, a quella militante partitica degli artisti legati al P.C.I.. Quella promossa dall’avanguardia napoletana è invece una lotta morale che nasce prima di tutto da un’esigenza personale e intima di “liberare” il Mezzogiorno da un’asfissia morale e culturale, con il proposito di “realizzare una graduale ibridazione dei diversi modi di pensare e di essere, tanto necessari a restituirci un individuo più vivo e sensibile”. L’accusa di essere provinciali viene ribaltata dagli artisti napoletani ammettendo da un lato il legame inscindibile con il territorio di provenienza (sottolineato anche nel lessico: “ovemai fossimo ‘guappi di cartone’ il nostro agire sarà sempre meno mortificante che se fossimo artisti disonesti e uommene e niente”), e dall’altro enfatizzando la necessità di promuovere un’arte che non sia imbrigliata in griglie omologanti. D’altra parte, i termini “provinciale” e “dialettale”, intesi in senso provocatorio e positivo, possono essere utili per leggere alcune delle caratteristiche della poetica portata avanti negli anni da Documento Sud, che tra i suoi obiettivi pone anche quello di valorizzare e risemantizzare la tradizione popolare napoletana: non a caso, in uno degli editoriali precedentemente citati si dichiarava di voler dare vita a “un sud laico e popolare”. È così che nascono, in senso antifrastico, i continui richiami alla superstizione e alla numerologia, riletti però secondo un’ottica surrealista, in grado cioè di attivare memorie recondite e creare cortocircuiti inventivi. Ne è un chiaro esempio l’inserto in cartoncino rosso di quattro pagine dedicato alla prima mostra del Gruppo 58+Baj la cui copertina è riquadrata dalla scritta “La superstizione contro la ragione”, commentata a sua volta dall’aforisma di Goethe che recita “La superstizione è la poesia della vita: in modo da non ferire il poeta di essere superstiziosi”. Funziona da controcanto giocoso il trafiletto intitolato “Il vostro destino” al centro della pagina, in cui la superstizione, dopo l’apertura a Goethe, torna a essere ricompresa nel suo senso tradizionale legato appunto alla numerologia e alle previsioni astrologiche. È evidente però che per Documento Sud, nella prospettiva di rileggere e valorizzare le credenze meridionali, la superstizione sia vista innanzi tutto come la capacità poetica di trasfigurare la realtà, facendo emergere sulla superficie significati arcani e reconditi: l’allusione all’arte degli aderenti al Gruppo 58 è lampante, e infatti molti commenti ruotano attorno al potere immaginifico delle pitture degli avanguardisti napoletani, in grado di filtrare e trasfigurare la realtà attraverso la propria sensibilità. La superstizione allora non sarà più un retaggio culturale da nascondere e lasciare nell’oblio, quanto piuttosto un’anticipazione, per certi versi, degli studi psicanalitici. A questo sembra almeno alludere Mario Persico nell’articolo “Gli atti deformanti”, accompagnato da una sua opera del 1959 . Persico sostiene che ogni trasformazione, innovazione decisiva, risieda “in un ‘atto’ o in una ‘deformazione’, indipendenti dalla realtà fino a quel punto concepita; vale a dire in una relazione illogica con essa”: da qui nascono dipinti e lavori in grado di trovare rapporti nuovi con la contemporaneità, a partire da una lettura personale del reale. È un percorso evolutivo che avviene in prima battuta nell’interiorità dell’artista, seguendo un processo euristico che deve molto alla psicanalisi e alle letture surrealiste ad essa connesse: “Freud ebbe coscienza della forza e delle conseguenze di quel ‘non logico’, e mosse da ‘esso’ per esplorare i labirinti dell’IO”. Associazioni mentali incongruenti, capacità inventive fantastiche: è la stessa interpretazione che Henry Delau offre delle pitture di LUCA nell’articolo Imagerie cosmica meravigliosa . Delau spiega infatti che una delle principali qualità di Castellano è quella di trasportare l’osservatore in una dimensione arcana, solcando territori inesplorati eppure visibili, superfici artificiali eppure memori di una loro profonda naturalità esistenti da sempre. Un ruolo chiave, in questa dinamica di riti arcani e tradizioni riaffioranti, è svolto dalla città di Napoli che permea di sé la rivista, sia attraverso la pubblicazione di proverbi e detti locali, sia attraverso opere d’arte che la presuppongono o la ritraggono direttamente. Ad esempio Castellano in Napulione e’ Napule , pubblicata sul secondo numero della rivista, con procedimento simile a quello di Baj di cui si dirà a breve, sovrappone una sua fotografia su una cartolina con il golfo di Napoli: il busto dell’artista emerge dal Vesuvio sullo sfondo, esprimendo un legame indissolubile con la città, e rendendo manifeste quelle intersezioni tra razionale e irrazionale, visibile e invisibile, di cui parla Delau nel suo articolo. Ma questa rilettura in chiave surrealista di Napoli contraddistingue tutto il periodico, a partire dalle foto inserite a fianco dell’editoriale nei primi quattro numeri, e raffiguranti aspetti tipici, folkloristici o legati all’ambito religioso popolare: nel primo numero una fila di reggiseni, nel secondo un teschio sormontato da una candela in quello che sembrerebbe un sepolcro sotterraneo, nel terzo un “madonnaro” all’opera , nel quarto una strada o un cortile con vari oggetti disposti alla rinfusa. L’intento è evidentemente quello di far scattare nel lettore collegamenti visivi e mentali inaspettati, cercando di rendere tangibile, come scrive Mario Persico in un’altra circostanza, “questa compenetrazione di ‘essenze’, facendo convivere il pessimo e l’ottimo, il brutto e il bello, il bene e il male (in tutte le loro accezioni) e tutte le apparenti antitesi che si possano immaginare”. Ideali antenati di simile operazione non possono dunque che essere “i Duchamp, i Max Ernst, gli Schwitters e altri, quando introdussero nel surrealismo il ‘readymade’ e ‘l’objet trouvé’”. Tuttavia, spiega ancora Persico, “essi miravano a produrre una serie di ‘schoc’ del tipo più generale, a trasferire sulla tela quel ‘fortuito incontro di un ombrello e una macchina da cucire su di un tavolo operatorio’ profetizzato da Lautreamont ”, mentre finalità del Gruppo 58 è “annullare ‘il giudizio di valore’, formulare un’estetica dell’accettazione totale”. Ancora più diretto è Guido Biasi che nel suo “Elogio del rifiuto”, partendo dall’assunto secondo cui “oggi il rifiuto è ormai irrifiutabile”, sostiene la centralità poetica e artistica “di oggetti in disuso, di cose usate e smesse, di rottami in disordine, di avanzi confusi”, capaci di riscattare la loro precedente destinazione funzionale attraverso una vita postuma, purificandosi, e tornando a essere “significato” e non più “funzione”: “Il rifiuto è la vendetta fantastica delle cose che si ribellano”. Le carte sono così definitivamente svelate ed è di nuovo Biasi, nelle “invettive” del quarto numero, ad affermare con decisione che “sia inutile negare che il Surrealismo abbia deposto le sue uova segrete in un luogo da noi ereditato, e che esse abbiano maturato il senso delle formidabili avventure che noi ci apprestiamo a vivere. Assistiamo oggi alla metamorfosi del fumoso fantasma onirico in allucinante Realtà di carne”. Quello che viene reclamato è dunque il permanere dell’immagine che segue sentieri associativi e meccanismi visivi surrealisti, abbinati a un senso tattile della pittura ma nel caso del rifiuto e del reimpiego entrano in gioco necessariamente anche Pierre Restany, il Nouveau Réalisme e il suo sviluppo successivo, ovvero la Mec-art, di cui infatti farà parte anche Bruno Di Bello. Snodo fondamentale sono in questo senso le sperimentazioni portate avanti da Baj, tra cui gli “specchi”, che vengono interpretati da Andriani come metafora della fantasia inventiva dell’artista “che ‘specula’, al momento, sulla magia delle superfici ‘speculari’”, ma soprattutto come manifestazione eclatante “di una visione violentata dalle crepe e moltiplicata dai frammenti apparentemente sconvolti”, che rivela a sua volta “un altro aspetto (magico ma presente fino alla più spiccata suggestione e sensazione delle dita) di quella ambiguità e plurivocità fantastica che lo affascinano fin dal fortunato e fortunoso periodo delle ‘montagne’ (1957-58)”. Non sorprende allora che nello stesso numero le opere di Colucci siano lette alla stregua di “larve e immagini di larve; larve future di prefigurazioni presenti, simboli di fatti senza data – la sua bicicletta di smalti pedala dentro liquidi soli verso violenze cromatiche dalle cifre inaudite”, in cui dunque dato pittorico e contenutistico si innervano l’un l’altro. Non diversamente, i lavori di Cena sono frutto di una profonda riflessione interiore “i suoi segni sono dettati da un impulso interno, per un discorso intimo con una realtà dello spirito”, che attraverso un “lungo processo formativo” si concretizza in un “mondo fatto di un messaggio di segni e forme” che “materializza sensazioni e percezioni nuove per un’epoca nuova”. È un sovrapporsi di stati emotivi e di materia pittorica che arriva a concretizzarsi visivamente in alcune opere presentate sul periodico, a partire dai quadri di Enrico Baj. È lo stesso artista a presentare una delle sue opere nate dalla sovrapposizione di oggetti incongruenti su pitture precedenti , facendo “apparire l’arrivo di alcuni sputnik o di personaggi di altri mondi su fondi assolutamente convenzionali”. L’effetto di spaesamento era accresciuto appunto dallo stratagemma di ricorrere a “fondi dipinti da altri pittori artigianali”, quanto di più “convenzionale e antiemozionale esista nel campo della visione” un effetto simile, aggiunge Baj, a quello provato quotidianamente da ciascuno di noi allorché, uscendo di casa, si immette in un sistema preesistente, prendendovi parte del riferimento eclatante alle “passeggiate” surrealiste. Dall’ambito surrealista il Gruppo 58 eredita anche le allusioni e un linguaggio critico afferente alla sfera sessuale, come dimostra, tra l’altro, l’articolo. “L’Eden e la satrapia del sesso” che Riccardo Barletta dedica a un dipinto di Sergio Fergola (Elegia). Tutto il commento, rispettando del resto l’iconografia del quadro, si sviluppa sui poli centrali della composizione (l’elemento fallico accanto a Eva, “esaltato da un alone luminoso”, e invece “l’esplosione vitalistica di una macchia di rosso acceso”, accanto ad Adamo), che arrivano a enucleare “il mito della caduta, il valore del sacro, il destino del mondo, l’antitesi tra sesso ed amore”. A livello pittorico, Fergola sviluppa invece un denso “simbolismo realistico” in cui riesce a conciliare il rispetto della forma e della figurazione con un uso espressivo del colore, rendendo “esperibili esistenzialmente le realtà rappresentate”. Una pagina propriamente surrealista è poi quella in cui a Il tagliatore di teste (collage del 1960) di Mario Persico viene affiancato uno scritto di Marcello Andriani , che svolge il tema della decapitazione dando vita a diversi micro racconti di poche righe: dalla richiesta di un marito che cerca “Tagliatore di Teste Anche Non Autorizzato Disposto Sopprimere Mia Moglie” alla narrazione postuma di un condannato a morte “Sentii la lama fredda dividere in un istante più rapido degli istanti normali la mia testa dal mio busto. La mia nuca batté con forza contro il fondo del paniere di vimini”, dall’elenco di decapitati “celebri” (Luigi XVI, Golia, Maria Antonietta, Tommaso Moro, Oloferne) alla redazione di un verbale poliziesco con finale satirico “La perizia necroscopica ha potuto stabilire che la decapitazione è stata eseguita in maniera pressoché perfetta, si ha ragione dunque di sospettare che l’assassino sia un macellaio o un chirurgo”. In un simile contesto non poteva poi mancare un esplicito riferimento al librocollage surrealista forse più famoso: La Femme 100 Têtes di Max Ernst. Ragnar van Holten nel suo pezzo affianca un’incisione di François Boucher tratta da Faunillane ou l’Infante Jaune, di Carl Gustaf Tessin, in cui il principe Perce-Bourse ritrova, passeggiando nel parco, la testa di una statua femminile, che poi ricomporrà per intero, a una delle incisioni di tema analogo di Max Ernst, ricavandone, a suo dire, un documento storico sui diversi atteggiamenti e comportamenti. Mario Persico, in cui il primo racconta al secondo il suo incontro nella metropolitana parigina con la “Giovane Masturbatrice presso il finestrino, sonnolenta, con l’ultimo piacere spento come una cicca sotto gli occhi fumosi. Aveva le unghie tutte lunghe, eccezion fatta per il medio della destra dove l’aveva cortissima”. Ricordi surrealisti, ambizioni poetiche, avanguardie artistiche dialogano dunque sulle pagine di Documento Sud che tra 1959 e 1961, come visto, prova ad attirare l’attenzione del mondo culturale sul Meridione d’Italia, collegandolo alle grandi imprese artistiche italiane ed europee, in particolare milanesi, francesi e belghe. Il tentativo sicuramente in parte riesce, anche grazie alla preziosa collaborazione con artisti e critici del calibro dei vari Jaguer e Lacomblez citati in apertura, ma non avrà forza a sufficienza per andare oltre i sei numeri del periodico. Tuttavia, il seme della rinascita era stato piantato e crescerà negli anni seguenti attraverso gli esperimenti editoriali di Quaderno tre fascicoli concentrati nel 1962, promossi da Stelio Martini e maggiormente virati sull’ambito della Poesia Visiva e Linea Sud sei numeri tra 1963 e 1967 promossi di nuovo da Castellano riviste diverse tra loro e anche rispetto a Documento Sud, che perfino nel suo aspetto tipografico aveva cercato di funzionare da ponte con altre esperienze d’avanguardia. Nel presente contributo si è cercato di offrire una prima panoramica d’insieme della rivista, evidenziandone gli apporti surrealisti e la parabola creativa, ma naturalmente molte altre piste d’indagine sarebbero ancora percorribili, analizzando ad esempio in profondità l’impatto della rivista sugli artisti napoletani intorno al 1960, considerando anche che molti degli aderenti al Gruppo 58 lasciarono poi la città. Un filo che però in qualche modo non si interruppe, grazie ancora una volta a Luigi Castellano e alla sua Linea Sud. Nel 1966 illustra la traduzione italiana di Luciano Caruso dell’opera patafisica «Ubu Cocu» di Alfred Jarry. In Persico l’interesse per le teorie patafisiche una sorta di ironico ritorno a quanto di esoterico rimane nel pensiero occidentale, secondo l’insegnamento di Alfred Jarry, demone dell’assurdo e della derisione è una costante della sua opera. Fin dagli anni cinquanta Mario Persico frequenta e collabora con Edoardo Sanguineti.Tra i momenti più interessanti di questa collaborazione si possono annoverare le scenografie e i costumi per l’opera Laborintus II di Sanguineti su musiche di Luciano Berio, andata in scena alla Scala nel 1973. Più recentemente ha firmato con Sanguineti, Dorfles e Pirella il «Manifesto dell’Antilibro» ed ha realizzato nel 2001, alla Biennale di Venezia, due «Bandiere della Pace» impagina nei modi della «poesia visiva» un testo di Sanguineti. Ancora nel 2003 ha illustrato un «Omaggio a Goethe» e nel 2004, un «Omaggio a Shakespeare, nove sonetti», con traduzioni di Sanguineti. Dal 2001 divenne il Rettore Magnifico dell’Istituto patafisico partenopeo e stampa «Patapart» , una delle più belle, colorate e difficili da sfogliare riviste d’arte contemporanea ma i avute a Napoli. Intanto si consolidavano i contatti con i Nouveaux réalistes francesi e con gli italiani di Parigi a essi collegati, tra tutti Mimmo Rotella. Il quarto e ultimo fascicolo de Il gesto, pubblicato nel settembre di quell’anno, fu dedicato all’Arte interplanetaria, con scritti e opere, tra gli altri, di Jaguer, Farfa, Antonio Recalcati e Giovanni Anceschi. Nacquero allora i primi Specchi, rotti o tagliati e poi ricomposti; Baj dette avvio alle prime Modificazioni, riconducibili alle prospettive dell’arte interplanetaria; incominciò la serie dei Generali, il «tema dominante nel 1959», destinato a influenzare tutta la sua prima produzione, al quale approdò attraverso un processo di personificazione delle Montagne realizzò le prime Dame, serie che riprese tra il 1974 e il 1975. Tutte opere nelle quali, sotto il comune segno dell’ironia dissacratoria, prevalsero la visione ludica, il desiderio di lavorare con ogni tipo di materiale, l’attenzione privilegiata per l’infanzia e l’«adesione-rottura alla storia della pittura». Nel biennio 1960-61, mentre gli Specchi, con le loro trame di prefigurazioni, venivano presentati alla galleria del Naviglio di Milano (gennaio 1960), Baj continuò il lavoro sui Generali, cimentandosi pure nei primi Cartoni (ripresi nel 1964-66 e nel 1970) e nei Mobili, poi sviluppati nei Personaggi in legno dal 1962, dove l’oggetto stesso si faceva protagonista. Intanto, per l’intensità del suo humour e per l’oggettualità del suo lavoro, la critica lo indicò tra i maggiori esponenti del neodadaismo. Il 1962 fu un anno decisivo, segnato dal significativo incontro a Parigi con Breton: Baj si accostò ancor di più al mondo della poesia, che da tempo frequentava per i legami con personalità quali Jaguer, Jouffroy, Dal Fabbro, Sanguineti, Sanesi, Balestrini, a cui si aggiunsero, tra gli altri, André Pieyre de Mandiargues, Octavio Paz, Raymond Queneau, Jean-Clarence Lambert e, più tardi, Dino Buzzati. Rapporti che nel tempo lo condussero anche a collaborare per rare edizioni di poemi accompagnati da incisioni, collage e libri-oggetto. Sempre nel 1962 Baj raggiunse gli Stati Uniti, dove un suo Specchio venne presentato nella grande mostra «The art of assemblage», organizzata in autunno da William C. Seitz al Moma di New York. In quell’occasione conobbe Marcel Duchamp: nacque un’amicizia destinata a durare negli anni. Ancora nel 1962 Schwarz dette alle stampe una monografia sull’Arte nucleare, nella quale veniva indagata l’intera opera di Baj. Di lì a poco, nel luglio 1963, Breton gli dedicò un ampio saggio su L’Oeil. I contatti con il mondo artistico parigino erano allora quanto mai intensi; mentre allestiva a Milano un nuovo studio in via Bonnet, dal 1963 al 1966 Baj lavorò per lunghi periodi a Parigi, presso lo studio, già di Max Ernst, in Rue Mathurin Régnier. In accordo con il Collège pataphysique di Francia, il 7 novembre 1963, fondò l’Istituto patafisico milanese, con l’intervento di Queneau e sotto la presidenza di Farfa. Intanto, sue personali venivano organizzate a New York, San Paolo e Torino. In occasione della mostra «Visione e colore», tenuta a Venezia a Palazzo Grassi nell’estate del 1963, Baj presentò alcuni quadri-oggetto con personaggi realizzati con i mattoncini Lego. Contestualmente si dedicò alle prime sculture in Meccano «totem-robots privi delle connotazioni macabre e metafisiche della fantascienza», presentate l’anno successivo in una sala personale alla XXXII Biennale di Venezia e alla XIII Triennale di Milano. In questa sede, dove allestì un ambiente a Specchi, Baj era stato invitato da Umberto Eco e Vittorio Gregotti; a Venezia, presentato in catalogo da Queneau, nel generale clima di critica negativa nei confronti della nuova figurazione, alcune sue opere furono oggetto di censura . Baj ritirò i Nudi, ma espose parate militari e comizi politici, che manifestavano l’impegno civile contro ogni tipo di aggressività. Nel 1964 giunsero altre importanti occasioni espositive. Tra tutte, gli fu dedicata una sala nell’esposizione «Pittura a Milano dal 1945 al 1964» al Palazzo Reale di Milano; Baj fu inoltre invitato alla mostra sul «Nieuwe Realism» al Gemeentemuseum dell’Aja. L’anno si chiuse con un incontro fondamentale: Baj conobbe Roberta Cerini, che nel 1966 sposò in seconde nozze e con la quale ebbe sempre un intenso scambio intellettuale. Dalla loro unione nacquero quattro figli: Angelo nel 1967, Andrea nel 1968, Pietro nel 1969 e Marianna nel 1978. Nell’estate del 1965 gli fu dedicata la prima retrospettiva, «Omaggio a Baj», nell’ambito della rassegna Alternative attuali 2, presso il Castello Spagnolo dell’Aquila. Nella mostra, curata da Crispolti, furono presentate circa ottanta opere, tra dipinti e sculture, e si approntò una prima sistemazione storiografica del suo lavoro. Tra un susseguirsi di personali e collettive, nello stesso anno Baj fu invitato alla mostra «Pop art, Nouveau realisme» al Palais des beaux-arts di Bruxelles. All’immaginario pop, tra l’altro, si stava confrontando in Italia il lavoro di Baj, già al tempo della Biennale, e più chiaramente negli scritti di Crispolti, prima in occasione della retrospettiva aquilana, poi nel volume . Tra il 1966 e il 1969, mentre cresceva il suo impegno come scrittore d’arte per cataloghi, giornali e riviste, Baj iniziò a interessarsi di multipli e si dedicò con assiduità alla grafica e all’incisione per edizioni numerate. Tra le tante: L’intérieur di Sanguineti e Limbo di Lambert nel 1966 Meccano ou l’analyse matricielle du langage di Queneau e Les incongruités monumentales di de Mandiargues nel 1967; I ricatti di Guido Ballo e il suo Baj chez Picasso, con testi di Jean Cassou, Queneau, de Mandiargues, Sanguineti, Buzzati e Pierre Seghers, nel 1969. Sempre in quegli anni Baj si recò in Australia e viaggiò a lungo tra gli Stati Uniti e l’Europa per personali e retrospettive, tenute, in particolare, a Chicago (1966), L’Aia e Gand (1967), Praga, San Francisco e Parigi (1969). Sul finire degli anni Sessanta, nella produzione di Baj presero forma le prime riprese ironiche e parodistiche delle opere di Picasso; tra i d’après, presentati alla galleria Creuzevault di Parigi (1969), si segnalavano i monumentali Les demoiselles d’Avignon e Guernica . Allo stesso tempo si datano i primi lavori per i quali si servì dei materiali plastici, già impiegati in passato e da quel momento adoperati, ad esempio, nelle Cravatte, simbolo della cultura occidentale, esposte al 15° premio Lissone (1967) e allo Studio Marconi di Milano (1969). Nelle Plastiche la «mitologia del “nuovo materiale”veniva intaccata proprio con i “nuovi materiali”». Mentre gli anni Settanta si aprirono con la pubblicazione del primo catalogo ragionato dedicato alle opere grafiche e ai multipli di Baj, a cura di Jean Petit (1970), e con tre importanti retrospettive, tenute tra la primavera e l’estate del 1971. A Ginevra, al Musée de l’Athénée, a cura di Petit si presentò la produzione grafica; a Venezia, a Palazzo Grassi, a cura di Sanesi si esposero oltre cento opere; a Chicago, al Museum of contemporary art, a cura di Jan van der Marck furono raccolti i lavori nel tempo confluiti nelle collezioni statunitensi. Nelle mostre di Venezia e Chicago comparvero anche i celebri Chez Seurat, presentati già a Lugano nella primavera dello stesso anno in occasione della collettiva «D’après. Omaggi e dissacrazioni nell’arte contemporanea». Tra questi, La grande jatte assurgeva a simbolo dell’immobilismo della borghesia. Tra una «continuità di fondo ideologica e quella che potremmo chiamare una continuità confirmatoria», sin dai primi anni Settanta Baj pervenne a nuovi traguardi e a «grandi impennate immaginative», che lo condussero soprattutto all’installazione e alla «disseminazione ambientale» . Al 1972 si data il primo lavoro di Baj di denuncia civile legato alla cronaca, fino a quel momento, tra l’altro, il più grande collage realizzato dall’artista (circa 12 metri di lunghezza per 4 di altezza), I funerali dell’anarchico Pinelli , dedicato al ferroviere morto precipitando da una finestra della questura di Milano, dove era trattenuto per accertamenti in seguito alla eplosione di una bomba in piazza Fontana. L’opera venne realizzata con «oggetti vari, consistenti in nastri, cordoni, passamanerie, fiocchi tutto un materiale cadente e decadente , che sta a simboleggiare una caduta culturale, il degrado di un sistema, vuoi di sviluppo, vuoi politico», più che dei suoi funerali, si trattava di lui stesso, dell’anarchico che precipitava al suolo su un ipotetico selciato, antistante una non tanto ipotetica questura. Il titolo definitivo restò “I Funerali dell’Anarchico Pinelli”, sia perché il corteo degli anarchici ricordava, per mestizia mista a bandiere, un corteo funebre, sia per il richiamo a quel precedente quadro “I Funerali dell’Anarchico Galli che è una delle migliori opere del Carrà futurista e dell’arte moderna italiana. La grande installazione doveva essere presentata a Milano nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale il 17 maggio, lo stesso giorno in cui fu ucciso il commissario Luigi Calabresi, che a quell’epoca alcuni indicavano come responsabile della morte di Pinelli. Annullato subito l’evento per ragioni di ordine pubblico, il Pinelli, nel 1973 presentato a Rotterdam, a Stoccolma e a Düsseldorf, si poté vedere a Milano nel 2000, presso la Galleria Giò Marconi, e solo nel 2012 a Palazzo Reale. Nello stesso tempo, mentre Baj continuava a scrivere testi di critica d’arte e a lavorare per edizioni numerate, tra fiocchi, cordoni e passamanerie, presero vita nuove Dame «degne compagne» dei Generali a cui dette titoli solenni, che rintracciò soprattutto nelle pagine del Grand Larousse Illustré , e che presentò qualche tempo dopo: nel 1975 allo Studio Marconi di Milano, nel 1976 alla Arras gallery di New York. Nel 1974 Baj si traferì definitivamente a Vergiate, dove aveva già risieduto lungamente sin dalla fine degli anni Sessanta, rendendo la sua villa di campagna luogo di «convivio» per intellettuali italiani e stranieri . Fu allora che donò collezioni complete delle sue stampe alla Bibliothèque Nationale di Parigi, al Boijmans di Rotterdam e al Cabinet des Estampes di Ginevra. Sempre nel 1974 giunse un ulteriore grande impegno, simile al Pinelli per dimensioni e per la presenza di sagome. Il collezionista di Chicago, Milton Ratner, che da tempo apprezzava il suo lavoro, gli commissionò (senza però poterla poi acquistare) un’opera che raccontasse un episodio della storia statunitense: «si convenne» per «Nixon e Kissinger alla parata del Columbus Day», titolo che per abbreviazione divenne Nixon Parade (Parma, CSAC). Nella composizione, tra le più sarcasticamente Dada, «il mostruoso del politico e la pornografia del potere giungevano per Baj al loro apice». I fiori di plastica, a copertura dell’intera superficie in basso, simboleggiavano il kitsch, l’aspetto per Baj più caratteristico dell’attualità.





Diversamente dal Pinelli, l’opera venne presentata subito nelle sale del Palazzo Reale di Milano, dove nel maggio di quell’anno ebbe luogo una grande retrospettiva con lavori dal 1960 al 1974, poi allestita al Palais des beaux-arts di Bruxelles in ottobre e alla Kunsthalle di Düsseldorf nella primavera del 1975. L’anno successivo Baj donò l’intero corpus di opere grafiche al Comune di Milano (donazione perfezionata nel 1987), presentato a dicembre al Castello Sforzesco in una grande esposizione accompagnata dalla pubblicazione di due cataloghi: il primo dedicato alle stampe originali con testi di Antonello Negri, Zeno Birolli, Baj e Queneau; il secondo dedicato ai multipli con testi di Negri, Birolli, Baj e Breton. Negli ultimi anni Settanta Baj viaggiò molto; si recò in Messico e in Egitto e si dedicò intensamente alla lettura, producendo pochissimo; fu profondamente suggestionato da L’èsprit du temps del 1962 L’industria culturale1974 di Edgar Morin, da La società dei consumi (1976) di Jean Baudrillard . Fu proprio dal saggio di Lorenz che prese spunto per l’ultimo grande impegno del decennio: un vastissimo collage rappresentante l’Apocalisse (Vergiate, Archivio Baj), incominciato sul finire del settembre 1978 e concluso nel marzo dell’anno successivo (con uno sviluppo finale di oltre 60 metri lineari per 4 di altezza), a cui Eco dedicò un volume . Allestita per la prima volta nei tre piani dello Studio Marconi di Milano nel marzo 1979 e composta da tele dipinte con tecnica informale e sagome dipinte o intagliate in legno, l’Apocalisse metteva in scena il degrado della contemporaneità, l’asservimento alla tecnoscienza e al modernismo in una commistione di elementi tragici e grotteschi che annunciavano e palesavano il dominio del mostruoso attraverso un percorso ascensionale che richiamava i gironi danteschi. Nel 1983 Baj aggiunse all’Apocalisse, considerata un work in progress, alcune sagome e tele; più tardi inserì altre tele, in particolare dedicate alle storie di Gilgamesh, realizzate tra il 1999 e il 2003. Gli anni Ottanta, che si aprivano con la monografia Enrico Baj del 1980, introdotta dal sociologo francese Baudrillard, con il quale Baj ebbe vari incontri e collaborazioni, furono contrassegnati da nuovi progetti, pur sempre coerenti, che lo condussero a sperimentare nuove tecniche e tipologie compositive, anche nel «recupero del mezzo pittura, in ruolo del tutto protagonistico, e insomma in un vero e proprio “a solo” mediale». Intanto, nella necessaria «conquista del presente nel suo presenzialismo», sia nelle opere, sia nella scrittura, la critica alla contemporaneità, alla robotizzazione dell’uomo e al consumismo si fece sempre più presente. Una grande mostra personale, in cui si presentarono i lavori di vaste dimensioni del decennio precedente, venne inaugurata il 1° maggio 1982 al palazzo della Ragione di Mantova. Per l’occasione Edoardo Sanguineti lesse il suo Alfabeto apocalittico contestualmente Baj partecipò al convegno Il mostro quotidiano, con interventi, tra gli altri, di Morin e Baudrillard. Nello stesso anno pubblicò Patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie, un ampio studio sulla scienza inventata da Alfred Jarry, sua passione da sempre, a cui seguì, l’anno successivo, una vasta esposizione al Palazzo Reale di Milano, «Jarry e la Patafisica», che curò con Vincenzo Accame e Brunella Eruli. Dal 1983, anno in cui dette alle stampe per Rizzoli la sua Automitobiografia. Dai giorni nostri alla nascita, raccontando se stesso, tra invenzioni e no, Baj si allontanò dal collage e dall’uso gestuale del colore, che adoperò, invece, in modo più disteso, a favore di ampie campiture. Di questo periodo sono i cicli Futurismo statico ed Epater le robot, dove emergono gli omaggi a Campanella (La città del sole) e a Voltaire (Studio per Micromégas), presentati allo Studio Marconi di Milano in ottobre. L’abuso della tecnologia e l’alienazione dell’uomo denunciati in queste opere furono alla base del coevo Manifesto per un futurismo statico (1983). Nel 1985, tra l’inverno e l’estate, si tennero due importanti mostre, la prima al Center for fine arts di Miami dove si presentarono Parate e grandi opere come Guernica, Pinelli e l’Apocalisse, e la seconda al Forte di Bard in Valle d’Aosta, in cui vennero esposte Generali e Dame accanto a Meccani e alle tele dedicate a Ubu Roi. In quello stesso anno, sempre per l’editore Rizzoli, Baj dette alle stampe Impariamo la pittura: un manuale semiserio per artisti, falsari e pittori d’ogni tipo. Per lo stesso editore, due anni dopo, uscì Fantasia e realtà: un dialogo tra Baj e Renato Guttuso sull’arte, la cultura e la società. Altro impegno editoriale fu il volume Cose, fatti, persone (1988), in cui raccolse numerosi scritti, anche inediti, pubblicati in giornali e riviste a partire dal 1981. Le serie di quegli anni, la prima dedicata ai Manichini, la seconda intitolata Metamorfosi metafore (che nasceva da una collaborazione con il poeta Giovanni Giudici), evidenziano ancora il momentaneo abbandono del collage. Se nella prima emergono chiari riferimenti al manierismo e alla metafisica, nella seconda lo sviluppo della figurazione, dell’immaginario e del fantastico anticipa le successive ‘opere kitsch’, alle quali Baj approdò nel 1989 per rappresentare la volgarità del kitsch attraverso grandi composizioni dette combinatorie, ottenute dall’assemblaggio di piccoli pannelli a indicare la futura esplosione demografica. Tutti gli anni Ottanta, intensamente animati da incontri e collaborazioni con artisti, poeti, letterati e filosofi di ogni nazionalità, si contraddistinsero, infine, per importanti lavori rivolti al teatro. Tra questi, il più significativo impegno giunse nel 1984, quando Massimo Schuster chiamò Baj a lavorare alla messa in scena dell’Ubu Roi di Jarry, rappresentato la prima volta all’Espace Kiron di Parigi il 15 novembre dello stesso anno con 230 repliche in tutto il mondo. Baj realizzò il boccascena e circa cinquanta marionette in Meccano. Tra il 1986 e il 1987 si dedicò a una rivisitazione in chiave satirica dell’Amleto ‘il lunatico’ di Shakespeare, scritto da Guido Almansi con la regia di Massimo Monaco, prodotto dal Teatro regionale toscano. Successivamente, con il figlio Andrea, creò settanta personaggi in legno per un’Iliade di Schuster, in scena al San Matteo di Piacenza nel gennaio 1988. Il decennio si chiuse con la realizzazione di un ulteriore spettacolo di marionette al quale lavorò ancora con Andrea, Le bleu-blanc-rouge et le noir, opera con libretto di Anthony Burgess e musica di Lorenzo Ferrero, sempre per la regia di Schuster, presentata a Parigi al Centre Pompidou nel dicembre 1989 nell’ambito del Festival d’Automne. Gli anni Novanta si aprirono con alcune significative pubblicazioni: tra tutte, nel gennaio 1990 Baj dette alle stampe per Rizzoli Ecologia dell’arte, un ironico dizionario in 200 voci sull’arte moderna; nel maggio pubblicò per Elèuthera Cose dell’altro mondo, una raccolta di scritti sull’arte americana degli anni Ottanta. Intanto, a cura di Massimo Mussini, per Electa, uscì I libri di Baj, catalogo ragionato delle edizioni numerate. Le più importanti mostre di quel periodo furono «Enrico Baj. Die Mythologie des Kitsches», tenuta nella primavera del 1990 ai Musei civici di villa Mirabello a Varese, ed «Enrico Baj, transparence du kitsch», curata da Baudrillard e allestita nel dicembre dello stesso anno presso la Galerie Beaubourg di Parigi. In entrambe le esposizioni Baj presentò quattro grandi composizioni combinatorie. Gli stessi pannelli furono esposti, l’anno successivo, a Milano, Roma e New York alla personale «Il giardino delle delizie», il cui catalogo curato da Giò Marconi, con testi di Eco, Baudrillard e Donald Kuspit, divenne una monografia sul suo percorso ideologico e stilistico. Altre opere di quel tempo, sullo stesso tema, si rifacevano a figure emblematiche, come Amore e Psiche, Adamo ed Eva o le Tre Grazie (Vergiate, Archivio Baj): tutti soggetti che realizzò anche in maiolica, in un momento in cui ritornò a lavorare la ceramica. Nel 1993 ebbe luogo una grande retrospettiva a Locarno, inaugurata a dicembre in tre diverse sedi, nelle quali si presentarono, rispettivamente, i lavori dal nucleare al kitsch, le opere grafiche e I funerali dell’anarchico Pinelli. Dal 1994 Baj incentrò il suo lavoro sulla serie delle Maschere tribali, immagini di un primitivismo moderno, selvaggio e istintuale, che aprirono un filone nuovo nell’ambito del suo lavoro, sulla cui linea si collocano i Feltri, iniziati nello stesso tempo e realizzati sino al 1998, e i successivi Totem del 1997. Mentre nei primi adoperò nuovamente l’ovatta, ma come base per la pittura, nei secondi sviluppò il tema della maschera in senso verticale e ritornò a citare nei titoli personaggi della storia, talvolta anche in coppia, come ad esempio Lancillotto e Re Artù, Luigi XV e Madama Pompadura (Vergiate, Archivio Baj). Tra le opere più significative di quegli anni vi è il satirico Berluskaiser (Vergiate, Archivio Baj), lavoro dal forte impegno civile nato a seguito delle elezioni del 1994, che mette in scena la conquista del potere di Silvio Berlusconi attraverso una composizione di sagome che richiamano l’Apocalisse. Come ulteriore meditazione sul tema, Sanguineti compose Malebolge 1994-1995, o del malgoverno da Berluskaiser a Berluscaos (pubblicato nel 1995 in collaborazione con Baj). Sempre nel 1995, il Berluskaiser, insieme al Pinelli e all’Apocalisse, furono presentati all’Institut Mathildenhöhe di Darmstadt in una grande retrospettiva con catalogo curato da Gabriele Huber e Klaus Wolbert. Durante la mostra ebbero luogo alcune rappresentazioni teatrali; in particolare Dario Fo, utilizzando come palcoscenico il Pinelli, rappresentò il suo Morte accidentale di un anarchico. Del 1996 sono il progetto per un Monumento a Bakunin, un singolare e inedito assemblage in omaggio all’anarchia, che venne presentato nella primavera in una grande collettiva berlinese dedicata al tema, e l’imponente acrilico su feltro Impressioni d’Africa (Vergiate, Archivio Baj), ispirato all’omonimo libro di Raymond Roussel (1910), che pone alla ribalta il tema del grottesco e del kitsch. Tutta la produzione di Baj, sino a quel momento, fu raccolta nel 1997 nella seconda impresa del Catalogo generale delle opere dal 1972 al 1996. Tra il 1998 e il 2000 una serie di mostre mise in rilievo alcuni aspetti significativi del suo lungo percorso artistico, da sempre segnato da «una certa irriverenza, un’ironia e un gusto del paradosso, quasi siano degli anticorpi dell’uomo contemporaneo». In particolare: con la retrospettiva «Enrico Baj», al Musée d’art moderne et d’art contemporain di Nizza dell’inverno 1998-99, si sottolinearono i legami con la cultura francese sin dagli anni Cinquanta; con la mostra «PicadadaBaj 2000», il cui catalogo contiene una prefazione di Dorfles e testi di numerosi critici italiani, allestita nell’estate del 1999 nel Palazzo del turismo di Riccione, venne presentata larga parte della sua produzione. Il decennio si chiuse con la prima serie dei Guermantes, piccoli ritratti (in totale ne realizzò circa 300) dedicati a Marcel Proust e alla comune Ricerca del tempo perduto. Mentre gli ultimi anni di vita furono quanto mai intensi: mentre si cimentava in nuove imprese editoriali (tra le varie si ricorda Discorso sull’orrore dell’arte, 2002), in libri per edizioni numerate e nuovi progetti per il teatro, nel 2000 Baj ritornò a lavorare con l’amico di sempre Corneille, con il quale aveva già realizzato alcune Montagne. Nello stesso anno, con l’esposizione «Enrico Baj. Masterpieces», organizzata nel febbraio alla galleria Giò Marconi di Milano, venne presentata una serie di opere particolarmente significative insieme al Pinelli e ai Guermantes. L’anno successivo Baj si dedicò all’organizzazione di un’ampia retrospettiva a Roma, tenuta in autunno al palazzo delle Esposizioni, con circa duecento opere che raccontavano il suo lavoro dal 1951 (alcune di grandi dimensioni come Guernica, I funerali dell’anarchico Pinelli e L’Apocalisse); nel 2002 ritornò sul tema delle Dame, presentate l’anno successivo da Dorfles alla galleria Giò Marconi di Milano, per la cui realizzazione adoperò materiali idraulici, quali sifoni, rubinetti, tubi e valvole; nel 2003 due importanti rassegne, la prima al Castello di Masnago di Varese, la seconda a Milano (in quattro sedi: Spazio Oberdan, Accademia di Brera, galleria Giò Marconi, Fondazione Mudima), furono incentrate, rispettivamente, sui rapporti tra Baj e la poesia e sulle grandi installazioni. L’ultima opera cui Baj si dedicò, senza fermarsi e riuscendo a completare il progetto a pochi giorni dalla morte, fu il grande Muro di Pontedera, realizzato postumo, nel 2005, con il contributo dell’architetto Alberto Bartalini: cento metri di mosaico che corre lungo la linea ferroviaria della cittadina toscana, nel quale, come in un testamento spirituale, raccolse e rivelò ogni aspetto del suo lavoro, dall’impegno civile al gioco, dalla realtà all’immaginazione. Infine il grande Bruno Munari sul quale posso affermare che la sua formazione artistica muove dalle esperienze pittoriche condotte nell’ambito del Futurismo, dal quale trarrà la sua ricerca visuale e l’interesse per l’oggetto nella sua complessa definizione e identificazione di caratteri, attributi e significati. Nel 1925 conosce Marinetti, simpatizza con Balla e Prampolini, i futuristi che lo influenzarono maggiormente. Dal 1927 partecipa alle collettive futuriste: espone alla milanese Galleria Pesaro, alla Biennale di Venezia, alla Quadriennale di Roma e a Parigi. Sono del 1933 le sue prime «macchine inutili», concepite secondo i presupposti dell’arte programmata, che lo rendono famoso negli ambienti artistici dell’epoca. Inventa «L’agitatore di coda per cani pigri», studia «il motore per tartarughe stanche». Nel 1939 diventa art director della rivista Tempo. Con Max Huber collabora alla creazione dell’immagine della casa editrice Einaudi. Del 1945 è il suo primo multiplo cinetico «Ora X» del 1948 -49 i suoi «libri illeggibili» del 1951 le «strutture continue» tridimensionali, gli esperimenti sul «negativo-positivo» e quindi successivamente quelli sulla luce polarizzata per proiezioni dalla materia; i numerosi film di ricerca, la progettazione di oggetti di arte cinetica; le sue famose «sculture da viaggio» in cartoncino piegabile oggetti di ornamentazione estetica, progettati allo scopo di creare un punto di riferimento, in qualche modo coincidente col proprio mondo culturale, da collocare nelle anonime camere di albergo o in qualunque altro luogo non caratterizzato. Seguono le «Xerografie originali», i «Polariscop», gli oggetti flessibili «Flexy», i giochi per i bambini e tanti vari oggetti di arte cinetica. A questa intensa ricerca nel campo della sperimentazione visiva e attività nel campo della progettazione, s’accompagna quella non meno costante e feconda nel campo della grafica, in quello degli allestimenti e in quello della saggistica. Tra i suoi numerosi scritti, fondamentali sono «Design e comunicazione visiva» del 1968, «Arte come mestiere» del 1966, «Artista e designer» del 1971, «Codice ovvio» del 1971. Premi e riconoscimenti gli giungono da ogni parte del mondo: il premio della Japan Design Foundation del 1985, quello dei Lincei per la grafica del 1988, il premio Spiel Gut di Ulm del 1971 in seguito verrà premiato nel 1973 e nel 1987mentre nel 1989 gli viene conferita laurea ad honorem in architettura dall’Università di Genova.»Il design dà qualità estetica alla tecnica. Non nel senso dell’arte applicata, come si faceva una volta quando l’ingegnere che aveva ideato la macchina per cucire, chiamava un artista che gliela decorasse in oro e madreperla, bensì nel senso che l’oggetto e la sua forma estetica siano una cosa sola ben fusa assieme, senza alcun riferimento a estetiche preesistenti nel campo dell’arte cosiddetta pura. Un oggetto progettato dal designer non risente dello «stile» personale dell’autore dato che il designer non dovrebbe avere, a priori, uno stile col quale dar forma a ciò che progetta, come avviene quando un artista si improvvisa designer ovvero l’oggetto prodotto dal designer dovrebbe avere quella «naturalezza» che hanno le cose in natura: una cavalletta, una pera, una conchiglia, una scarica elettrica; ogni cosa ha la sua forma esatta. Sarebbe sbagliato pensare queste cose in stile: una cavalletta a forma di pera, una scarica elettrica a forma di, quindi un settore diverso dal design, che ha una sua precisa funzione, è lo styling, dove si progetta moda, dove la fantasia e la novità sono dominanti, per un consumo rapido della produzione. Il vero design non ha stile, non ha moda; se l’oggetto è giusto, nel design non si dice bello dura sempre. Oggetti di design ignoto si usano da sempre: il leggio a tre piedi dell’orchestrale, la sedia a sdraio da spiaggia».Bruno Munari è una della grandi figure del design e della cultura del XX secolo. Milanese, ha vissuto tutte le età più significative dell’arte e del progetto, diventandone un assoluto protagonista sin dagli anni Trenta, con la creazione delle «macchine inutili» e con il contemporaneo lavoro di grafica editoriale, del tutto innovativo nel panorama europeo. Ma è nel secondo dopoguerra che Munari si afferma come uno dei «pensatori» di design più fervidi: la collaborazione con tutte le aziende più importanti per la rinascita del Paese dalla Einaudi alla Olivetti, dalla Campari alla Pirelli e una serie di geniali invenzioni progettuali spesso realizzate per la ditta Danese ne fanno un personaggio chiave per la grande stagione del design italiano. Grafica, oggetti, opere d’arte, tutto risponde a un metodo progettuale che si va precisando con gli anni, con i grandi corsi nelle università americane, come l’MIT, e con il progetto più ambizioso di tutti, che è quello dei laboratori per stimolare la creatività infantile, che dal 1977 sono tuttora all’avanguardia nella didattica dell’età prescolare e della prima età scolare. La sua costante ricerca è stata quella dell’approfondimento di forme e colori, variabili secondo un programma prefissato, e della autonomia estetica degli oggetti. Tali premesse hanno trovato conferma nella pratica dell’industrial design. La sua poliedrica capacità comunicativa si è manifestata nei campi più disparati: pubblicità e comunicazione industriale libri per la scuola L’occhio e l’arte. L’educazione artistica per la scuola media, 1992; Suoni e idee per improvvisare. Costruire percorsi creativi nell’educazione musicale e nell’insegnamento strumentale, 1995, entrambi in collaborazioni inventò giochi, laboratori grafici e libri di ricerca. Munari amava raccontarsi e diceva : “All’improvviso senza che nessuno mi avesse avvertito prima, mi trovai completamente nudo in piena città di Milano, il 24 ottobre 1907. Mio padre aveva rapporti con le più alte personalità della città essendo stato cameriere al Gambrinus, il grande Caffè Concerto di piazza della Scala, dove si riunivano tutte le persone importanti a bere un tamarindo dopo lo spettacolo. Mia madre, in conseguenza di ciò, si dava delle arie ricamando ventagli. A sei anni fui deportato a Badia Polesine, bellissimo paese agricolo dove si coltivavano i bachi da seta e le barbabietole da zucchero. Il caffè veniva dal Brasile, a piedi nudi. Sulla piazza del paese, tutta di marmo rosa, si passeggiava a piedi nudi nelle sere d’estate. Nel caffè niente zucchero. Le vacche erano nel Foro Boario dove improvvisavano ogni mercoledì (mercato) dei cori, non come alla Scala, ma con molto impegno. Dopo le vacche ho avuto rapporti carnali con l’arte e sono tornato a Milano nel 1929 e un giorno di nebbia ho conosciuto un poeta futurista Escodamè che mi fece il favore di presentarmi a Filippo Tommaso Marinetti e fu così che inventai le macchine inutili. E adesso sono ancora qui a Milano dove qualcuno mi chiede se faccio ancora le macchine inutili oppure se sono parente col corridore (che poi era mio nonno, mentre lo zio Vittorio faceva il liutaio e il cuoco. Scusatemi se lascio la parentesi aperta.” Dopo aver trascorso l’infanzia in un piccolo paesino del Veneto, nel 1926 Bruno Munari torna a Milano, città che diventerà il centro della sua attività artistica. Qui uno zio ingegnere lo assume nel suo studio e lo aiuta ad integrarsi nella metropoli. Il primo incontro con i futuristi milanesi risale al 1926, ma è bene ricordare che l’artista sente parlare del futurismo per la prima volta ancora adolescente, nell’albergo dei genitori. Lo stesso Munari racconta infatti: Prima della guerra passavano dei viaggiatori di commercio che si fermavano una o due notti, e fu uno di loro che mi parlò del futurismo. Ricordo che aveva al collo un fazzoletto, cosa strana perché allora si portava solo la camicia con la cravatta, e io mi entusiasmai per i suoi discorsi, avevo più o meno diciotto anni, e allora cominciai a fare dei disegni, ma senza sapere niente, inventando. L’incontro che sancirà l’ingresso di Munari nell’avanguardia, avviene invece girando per le librerie antiquarie, dove egli conosce il poeta futurista Escodamé. Questo incontro permetterà al giovane artista di conoscere Marinetti ed entrare nel gruppo di intellettuali che fonderanno il secondo futurismo milanese. Munari vede nel movimento futurista «l’espressione più coerente con l’idea del nuovo» nata durante i primi mesi passati in città: egli, che si avvicina al mondo dell’arte da un percorso non accademico, individua l’innovazione futuristica nel coinvolgimento di diverse discipline caratteristica essenziale nella successiva attività di Munari in particolare l’attenzione ai problemi della grafica, della pubblicità e dell’arte applicata al quotidiano, in contrasto alle tendenze artistiche novecentiste e al recupero dell’arte classica e aulica. Nonostante Munari sia tra i fondatori del secondo futurismo milanese, le sue origini artistiche sono da ricercare nella prima esperienza futurista, quella di Balla, Boccioni, Carrà e Depero. Sarà significativo il rapporto con Enrico Prampolini, uno degli esponenti più importanti del primo futurismo, in particolare per la sua attenzione verso l’Europa e le esperienze d’arte internazionali tra le due guerre, egli viaggia tra Ginevra, Praga, Berlino e Parigi, mantenendo stretti rapporti con gli ambienti delle avanguardie europee. Prampolini verrà citato da Munari come suo unico referente culturale e interlocutore di tutte le esperienze internazionali diffuse nel Vecchio Continente a partire dagli anni ’20. Gli elementi di contatto più evidenti tra Munari e l’avanguardia italiana si possono individuare all’interno del manifesto programmatico pubblicato nel 1915 da Giacomo Balla e Fortunato Depero. Il documento Ricostruzione futurista dell’universo cita anzitutto l’uso di materiali poveri per la costruzione del «nuovo Oggetto (complesso plastico)». Anche nel Manifesto tecnico della scultura futurista firmato da Boccioni viene sottolineato il rinnovamento nell’uso dei materiali, in particolare attraverso la concezione del polimaterismo: 3. Negare alla scultura qualsiasi scopo di ricostruzione episodica veristica. Percependo i corpi e le loro parti come zone plastiche, avremo in una composizione scultoria futurista, piani di legno o di metallo, immobili o meccanicamente mobili, per un oggetto, forme sferiche pelose per i capelli, semicerchi di vetro per un vaso, filo di ferro e reticolati per un piano atmosferico, ecc. ecc. 4. Distruggere la nobiltà, tutta letteraria e tradizionale, del marmo e del bronzo. Affermare che anche venti materie diversi possono concorrere in una sola opera allo scopo dell’emozione plastica. Il manifesto mette in luce due importanti innovazioni: il rinnovamento dei materiali, ovvero la necessità di abbandonare le materie tradizionali per lasciare spazio a quelle nuove e la «compenetrazione tra gli oggetti e lo spazio circostante». Queste caratteristiche innovative della scultura futurista sono visibili nella progettazione (e realizzazione) delle prime Macchine inutili: per queste opere Bruno Munari seleziona con particolare attenzione le materie da usare, ponendo l’accento non solo sull’accostamento dei colori soprattutto tinte piatte e quindi sulla sensazione visiva che l’oggetto artistico provoca, ma anche sull’effetto tattile, nel desiderio di risvegliare tutti i sensi del fruitore nell’atto di contemplazione dell’opera. Nelle Macchine inutili è evidente anche la fusione tra le componenti fisiche e lo spazio vuoto circostante: l’utilizzo di materiali leggeri come cartoncini colorati, bastoncini di legno e fili di seta permette alla costruzione di essere molto leggera e di potersi muovere con un soffio d’aria. A tale proposito, Munari spiega: «pensavo che sarebbe stato forse interessante liberare le forme astratte dalla staticità del dipinto e sospenderle nell’aria, collegate tra loro in modo che vivessero con noi nel nostro ambiente, sensibili alla atmosfera vera della realtà». I materiali di cui le Macchine inutili sono composte sottolineano la profonda differenza che intercorre tra queste opere e i mobiles di Alexander Calder, con i quali, negli stessi anni, l’artista statunitense conquista la fama nell’ambiente. Anzitutto le sculture di Munari sono composte, come abbiamo visto, da materiali leggeri come cordini di seta, cartoncini con tinte pastello e bastoncini di legno. I mobiles di Calder invece sono di ferro, verniciati di nero o colori violenti. L’elemento comune alle opere risiede nel fatto che entrambe si appendono e girano, ma i modi e i materiali sono agli antipodi. Inoltre gli elementi che compongono le Macchine inutili sono in rapporto armonico tra loro, mentre le forme predilette da Calder sono di ispirazione vegetale. L’attenzione all’uso dei materiali diverrà poi essenziale nella progettazione di oggetti di design e, in particolare, nei giochi e libri per bambini: in ogni progetto di Munari, è il materiale (oltre che la funzione) a suggerire la forma, come nel caso della progettazione della scimmietta Zizì giocattolo in gommapiuma armata che nel 1954 vince il primo “Compasso d’oro” del design italiano dimostrazione di come sia possibile utilizzare in modo innovativo un materiale fino ad allora sfruttato solo per la costruzione di poltrone e divani. Munari viene colpito dalla morbidezza ed elasticità del composto, «che sembra vivo» e che ricorda la sensazione di tenere in braccio un cucciolo. Tornando al manifesto Ricostruzione futurista dell’universo, Balla e Depero danno indicazioni anche sugli oggetti da realizzare, mettendo in luce l’intrinseca volontà del movimento futurista di «raggiungere il cinetismo». In questo passaggio del testo è evidente l’assonanza tra i «complessi plastici», ovvero le «rotazioni» proposti dai due artisti futuristi e le Macchine inutili di Munari. Lo stesso autore, parlando delle sue opere, spiega: «Gli elementi che compongono una macchina inutile ruotano tutti su se stessi e tra loro senza toccarsi». Le Macchine inutili hanno la capacità di muoversi, spostarsi nello spazio attraverso il vento, che fa muovere le «sagome di cartoncino dipinto e qualche volta una palla di vetro soffiato». In terzo luogo, i due artisti futuristi sottolineano l’interesse per i giocattoli, che non dovranno più «istupidire e avvilire il bambino», ma, anzi, abituarlo. Munari si dedica alla progettazione di giochi per bambini a partire dagli anni Cinquanta e pone particolare attenzione non solo al materiale con cui il gioco è realizzato, ma anche all’interazione del bambino con il giocattolo. A tale proposito Marco Meneguzzo, nel descrivere la cura che Munari riserva alla progettazione per l’infanzia, spiega che in un gioco per bambini «Non ci deve essere nulla di tanto caratterizzato da rischiare d’essere più “forte” della personalità in formazione del bambino, nulla che possa plagiarne lo sviluppo» . I giochi progettati da Munari negli anni successivi, con la collaborazione del pedagogista Giovanni Belgrano, rispondono tutti allo stesso principio. Tornando al futurismo, a partire dalla fine degli anni ’20, Munari partecipa a collettive importanti, tra le quali la Biennale di Venezia (1930, 1932, 1934), la Quadriennale di Roma, ma anche eventi a Milano e Parigi. Per quanto riguarda i temi scelti dal giovane artista, negli anni del secondo futurismo la tendenza è quella dell’aeropittura, «che vuol rendere plasticamente gli stati d’animo, le immagini, i sogni e, in un senso soggettivo ed astratto, gli spettacoli naturali offerti dal volo». A questa ultima declinazione della pittura futurista, che risente di influenze surrealiste e metafisiche, Munari aggiunge alcune “stranezze”: fin dai primi anni di attività è evidente la tendenza dell’artista ad allontanarsi da ogni definizione di stile o corrente. Un anonimo recensore, a proposito della Mostra futurista in omaggio a Umberto Boccioni commissionata dai futuristi alla Galleria Pesaro di Milano nel 1933, scrive: Un artista che si serve di tutti gli espedienti possibili per accrescere di valori tattili i valori pittorici, associandoli in modi curiosi, è Munari, il quale con una sua figurazione intitolata, se ben ricordo, Il mormorio della foresta, applica dei piccoli rami d’albero risegati sulla superficie dipinta, e altrove, sconfinando interamente dalla pittura, intenta una sua “Macchina per contemplare”, composta di fiale e tubetti, e liquidi misteriosi. Stranezze, ma spesso divertenti, come la Radioscopia dell’uomo moderno: scheletro umano formato di legno e metallo, con un globo sospeso fra le costole. L’uomo che porta il mondo dentro di sé. Dalla descrizione sopra citata, è chiaro l’interesse di Munari verso una “contaminazione” di media diversi, nonché la devozione alla natura, che spicca particolarmente in una situazione artistica come quella futurista, che tende al meccanico o allo sconfinamento negli spazi cosmici. Per quanto riguarda gli elementi di sviluppo dei modi di fare arte tipici del futurismo, Munari commenta così l’avanguardia che ha contribuito a fondare: Futurismo. Il pittore futurista vuol dipingere il movimento dell’oggetto e non l’oggetto stesso. Da ciò deriva la simultaneità dell’oggetto con l’ambiente, la scomposizione e la compenetrazione dei piani e tante altre cose mentre il visitatore ignaro si sforza inutilmente di ricostruire l’oggetto che ha fornito l’ispirazione. Da questo momento l’oggetto, approfittando del movimento che gli ha imposto il futurismo, parte e non lo vedrete mai più, sotto forma verista, nei quadri moderni . Munari, nel descrivere con parole sue il futurismo, parla indirettamente della “scomparsa dell’oggetto”, ovvero della «eliminazione della funzione narrativa del quadro», che ha inizio con la partecipazione al secondo futurismo e che si concretizzerà negli anni successivi, in particolare dal dopoguerra, periodo in cui gli interessi dell’artista si muoveranno soprattutto verso il design. Il momento storico entro cui il giovane Munari muove i primi passi in ambito artistico, quello cioè delle avanguardie europee e degli scambi tra movimenti, gli permette la sperimentazione di media e supporti, forme e temi sempre diversi, rendendo difficile tracciare i confini stilistici dell’artista fin dal principio del suo percorso. Bruno Munari si avvicina al mondo dell’arte grazie al secondo futurismo, ma la sua curiosità lo spinge oltre questa avanguardia, alla ricerca di nuove contaminazioni, nuovi temi, nuovi modi. Verso la fine degli anni ’30, Munari entra in contatto con l’arte astratta, soprattutto attraverso la mediazione culturale di Prampolini e la Galleria Il Milione di Milano, che in quegli anni propone numerose mostre. Lo spazio, fondato nel 1930 da Peppino e Gino Ghiringhelli, dedica esposizioni ai più importanti artisti d’arte contemporanea italiani, come Sironi, Morandi, De Chirico, Melotti, Fontana, Soldati, Rho, ma anche europei, tra i quali Matisse, Kandinsky, Picasso, Chagall. A proposito della galleria, Munari scrive: Intorno agli anni Trenta si aprì, a Milano, davanti all’Accademia di Belle Arti di Brera, una piccola galleria che ha avuto una grande importanza culturale perché faceva conoscere, in quei tempi oscuri, quelli che oggi sono considerati i grandi maestri d’arte moderna. Tornando all’arte astratta, di questa esperienza artistica il milanese scrive: «Astrattismo e qui, finalmente, il soggetto, dopo tante metamorfosi, scompare. Il soggetto di un quadro astratto è la Pittura, soltanto la pittura e cioè forme e colori liberamente inventati». Come per il futurismo, anche della maniera astratta l’artista coglie alcuni importanti aspetti: fin dai tempi delle Macchine inutili Munari pone l’attenzione alle forme utilizzate dai pittori astratti e se ne appropria, liberandole nella tridimensionalità di una scultura, anziché intrappolarle nella bidimensione della tela. A proposito della nascita di queste sculture, l’artista spiega: Nel 1933 si dipingevano in Italia i primi quadri astratti che altro non erano che forme geometriche o spazi colorati senza alcun riferimento con la cosiddetta natura esteriore. Spesso questi quadri astratti erano delle nature morte di forme geometriche dipinte in modo verista. Personalmente pensavo che, invece di dipingere dei quadrati e dei triangoli o altre forme geometriche dentro l’atmosfera, ancora verista (si pensi a Kandinsky) di un quadro, sarebbe stato forse interessante liberare le forme astratte dalla staticità del dipinto e sospenderle in aria, collegate tra loro in modo che vivessero con noi dentro il nostro ambiente, sensibili alla atmosfera vera della realtà. Con le Macchine inutili, Munari rinuncia al supporto e, dunque, allo sfondo. Egli definisce la pittura di Kandinsky, che pur considera suo maestro, «una natura morta di oggetti irriconoscibili naviganti in una atmosfera vaga che fa da sfondo». Riguardo il tema del supporto e dello sfondo, negli anni in cui Lucio Fontana taglia la tela e Moholy Nagy realizza i suoi Dipinti trasparenti, Munari prepara una serie di dipinti intitolata Anche la cornice, che Tanchis definisce una «dichiarazione di poetica», in quanto « l’annessione della cornice al quadro equivale alla distruzione della sua funzione separatrice». Questa soluzione compositiva astratta crea uno spazio «plastico, integrale, concreto» dove tutto è ambiguità percettiva, dall’effetto di profondità, al confine tra opera e suo contorno. Ma il legame tra Bruno Munari e l’astrattismo è rintracciabile soprattutto nel confronto con due grandi artisti, Paul Klee e Piet Mondrian: con il primo, il milanese condivide intenti e riferimenti culturali, mentre dell’olandese Munari è colpito dalla rigorosa strutturazione ortogonale dello spazio, nel quale colore e forma «esprimono solo se stessi». Un confronto critico tra Munari e Klee viene proposto dallo studioso Aldo Tanchis, che individua per i due artisti nonostante oltre quattro decenni separino la loro attività aspetti affini nel loro metodo di lavoro. Il primo elemento in comune tra i due maestri riguarda «il problema del creare» , che per entrambi è più importante di ciò che viene creato. L’attenzione verso il procedimento di realizzazione dell’oggetto artistico, ovvero il metodo di lavoro, è sottolineato da Munari in un brano nel quale, parlando dell’importanza della distruzione dell’opera collettiva realizzata in un laboratorio creativo, afferma: «non è l’oggetto che va conservato ma il modo, il metodo progettuale, l’esperienza modificabile pronta a produrre ancora secondo i problemi che si presentano» . Allo stesso modo, per Klee «Ogni opera non è a bella prima un prodotto, non è opera che è, ma in primo luogo, genesi, opera che diviene». Questo primo elemento comune, richiama subito il secondo, altrettanto importante per i due artisti, ovvero la loro innata vocazione didattica. Se è il metodo di lavoro la cosa più importante del fare arte, è conseguente il fatto che vi debbano essere degli allievi a cui insegnare a sviluppare il proprio processo creativo. Negli scritti di Munari e Klee è evidente il loro desiderio di insegnare e la volontà di condividere con gli altri dei risultati teorici importanti. Entrambi mirano a favorire la propria disposizione creativa attraverso «modelli critici di comportamento». Per i due artisti le idee preconcette e l’eccessivo uso della ragione sono ostacoli alla creazione. Mentre Klee suggerisce ai suoi allievi «che le figurazione proceda dall’interno», ovvero che non ci siano agenti esterni ad influenzare la loro fantasia, Munari spiega ai suoi studenti: Ho detto loro di non pensare prima di fare. Di non cercare di farsi venire un’idea per fare la composizione. Spesso un’idea preconcetta mette in difficoltà l’operatore. Non pensare prima di fare vuol dire lasciare fuori la ragione e usare l’intuizione, cominciare a disporre a caso le forme. In terzo luogo, lo svizzero e l’italiano condividono l’idea di origine orientale che il cambiamento, il movimento e la mutazione rappresentano la vita e sono costanti essenziali della realtà. Per Munari «Il conoscere che una cosa può essere un’altra cosa, è un tipo di conoscenza legata alla mutazione. La mutazione è l’unica costante della realtà», mentre per Klee «Buona è la forma come movimento, come fare: buona è la forma attiva». Munari sottolinea l’importanza della mutazione anche quando parla dello sviluppo della fantasia e della creatività, soprattutto in età infantile. Egli infatti spiega che «Abituare i bambini a considerare la mutazione delle cose vuol dire aiutarli a formarsi una mentalità più elastica e vasta». Dunque, essere pronti al cambiamento, «essere mobili come la grande natura», spinge entrambi gli artisti ad una conclusione condivisa, che ci riporta al punto di partenza: non è l’oggetto che va conservato, ma il modo. In Munari questo aspetto prende forma nella sesta ed ultima regola che riguarda le tecniche di comunicazione visiva da insegnare ai bambini in un laboratorio creativo, ovvero: «Sesto: distruggere tutto e rifare…». Questa regola è utile ad evitare di creare modelli da imitare. Aldo Tanchis riconosce in questa «volontà antimuseificatrice» e distruttrice un’influenza di origine futurista, alleggerita dalla sua personale ironia, ovvero «un invito ad andare oltre, ad ignorare l’ipotesi di un risultato finale». Tra Munari e Klee vi è anche la condivisione dell’interesse per le forme della natura, in particolare le forme in crescita e i loro sistemi costruttivi: entrambi cercano nella natura le forme archetipe, originarie e, per Munari, essenziali. Klee afferma: «Il dialogo con la natura resta, per l’artista, conditio sine qua non. L’artista è uomo, lui stesso è natura, frammento della natura nel dominio della natura». I due artisti partono dunque dalla stessa ricerca, ovvero un’attenta indagine della natura per trovare la forma archetipa, ma arrivano a risultati diversi: per Klee l’obiettivo è il «prelevamento dell’immagine allo stato puro», Munari invece cerca «una forma di naturalezza industriale», visibile nelle sue opere di design. Infine, il milanese e lo svizzero condividono l’idea che le regole del fare artistico si possono trasmettere, ma la «genialità non la si può insegnare in quanto non è regola bensì eccezione» . Per Munari «È proprio la tecnica che si può insegnare] non l’arte. L’arte c’è o non c’è». Le tecniche e le regole per sperimentare l’arte possono dunque essere trasmesse, ma la genialità è innata. Anche la storica dell’arte Gloria Bianchino conferma la grande considerazione di Munari verso il pensiero teorico di Paul Klee, spiegando come «il dialogo con l’artista svizzero sia stato non solo importante, ma determinante per la ricerca del segno di Munari». Cerco di mettere in luce gli elementi di contatto tra il milanese e lo svizzero attraverso la mediazione della scuola del Bauhaus, nella quale, per volontà di Walter Gropius, Klee insegna pittura dal 1920 al 1931. In questi stessi anni, il pittore tedesco-svizzero farà uso dell’ironia «per suggerire il distacco fra l’immagine rappresentata e il suo primo significato, quello espresso nella didascalia» è ipotizzabile, per la Bianchino, che Munari assuma «l’uso di proporre dei titoli con la funzione di suggerire il piano dell’immagine come diverso da quello del suo primo significato» proprio da Klee, per il quale il senso delle rappresentazioni «non è mai stabile, ma muta a seconda della didascalia». Sappiamo inoltre, dalle parole di Tanchis, che Munari legge Klee, conosce i suoi testi, ma li traduce sempre in maniera operativa, ponendo l’attenzione al risvolto pratico del fare artistico. Ma, nonostante una profonda condivisione del metodo e di svariati richiami culturali, esistono alcune differenze che intercorrono tra i due maestri: anzitutto la pratica artistica, che per Klee rimane circoscritta alla tela, mentre per Munari si sviluppa in opere di natura molto diversa dalle Macchine inutili, agli oggetti di design, ai libri per bambini, ai laboratori creativi. Inoltre, è evidente la «diversità di forza e carattere» tra la scuola del Bauhaus, «democratica fondata sul principio della collaborazione, della ricerca comune tra maestri e allievi» e «vivacissimo centro di cultura artistica in contatto con tutte le tendenze avanzate dell’arte europea», di cui fa parte Klee, e il MAC , movimento artistico fondato da Munari, forse l’unico esempio italiano di discussione di teorie e problemi legati al mondo dell’arte, che altrimenti sarebbero stati trascurati, ma che ha dato scarsi risultati per quanto riguarda la produzione di oggetti artistici, al contrario della ricca produzione bauhausiana. Per concludere, la differenza forse più significativa tra Munari e Klee risiede nel rapporto tra arte e vita: lo svizzero vive l’arte come attività consolatoria, in contrasto con la quotidianità, mentre per il milanese questa distinzione è impossibile, poiché non ci devono essere «un mondo falso in cui vivere materialmente e un mondo ideale in cui rifugiarsi moralmente» . Vedremo più avanti che l’intento teorico di Munari sarà infatti riuscire a fondere arte e vita, per giungere ad un’arte democratica e diffusa nel quotidiano. Il giovane Munari deve a Prampolini anche la conoscenza di Piet Mondrian, fondamentale per la formazione del milanese, che con il maestro olandese condivide i motivi di critica al futurismo. A tale proposito, è lo stesso Munari, in un’intervista ad Arturo Carlo Quintavalle, ad affermare: «Prampolini mi mostrò anche delle opere di Mondrian e fui molto colpito dalla essenzialità e dal modo di occupare lo spazio di questo artista». Il milanese si rende presto conto dell’incapacità del futurismo di passare dalla rappresentazione del movimento al movimento puro questione che egli risolve con le Macchine inutili e la tendenza futurista a considerare il quadro l’opera in generale attraverso motivi che vanno oltre l’opera stessa, prescindendo dai valori sensoriali e formali. Munari riconosce in Mondrian l’artista che per primo arriva «al colore e alla forma che esprimono solo se stessi», ed è colpito, in particolare, dalla sua meticolosa strutturazione ortogonale dello spazio e dal tentativo di eliminare dall’opera ogni forma di “stato d’animo”, ovvero elementi che non hanno nulla a che fare con l’oggettività del manufatto. Questi elementi vengono ripresi da Munari soprattutto nella sua attività di designer: tutti gli oggetti da lui progettati si pensi, ad esempio, al Posacenere cubo o all’Abitacolo rappresentano null’altro che loro stessi, la loro essenzialità formale corrisponde ad una essenzialità funzionale. A confermare il legame tra Munari e Mondrian è il pittore Franco Passoni che, nel Bollettino Arte Concreta n. 5, pubblica un breve saggio dal titolo “Teorema di Munari”, nel quale presenta il lavoro del milanese. Passoni scrive: La prima scoperta fondamentale di Munari nacque dalla valutazione sull’arte astratta impostata da Mondrian, in quell’occasione e attraverso esperienze personali, egli capì che una superficie piana può diventare interessante dal modo come viene divisa, selezionata e colorata, seguendo un rigorosismo estetico al di fuori della proporzionalità euclidea conosciuta in arte come !sezione aurea”. Munari giunge alla conclusione che «la forma nello spazio ha una sua esclusiva natura, una sua ragione d’essere in sé e per sé senza limiti stabiliti» ma la ricerca attorno alla forma del quadrato e la realizzazione dei primi Positivi-Negativi metteranno definitivamente in luce la discontinuità con il pittore olandese: Quando nel passato ho lavorato ai negativi-positivi il mio problema era uscire da Mondrian: ho ancora le sue ortogonali dentro di me… A furia di semplificare, di arrivare ai colori primari, Mondrian ha occupato lo spazio della tela in modo asimmetrico al fine di trovare un equilibrio. Era difficile uscire da questa gabbia. Attraverso i miei negativi-positivi ho tentato di arrivare ad un altro tipo di equilibrio. E credo di esserci riuscito. Conseguenza di questa indagine oggettiva è una certa avversione nei confronti dell’espressionismo, il «barocco moderno» così ricco di soggettività e sentimento, che viene tradotto da Munari in una «ricerca del massimo di purezza e sobrietà dell’oggetto», il quale diventa «autosufficiente e autosignificante, si rappresenta e non rappresenta». La ricchezza di dettagli e decori è, per Munari, inutile alla comunicazione del messaggio e, dunque, alla fruizione dell’oggetto: l’obiettivo del designer è il raggiungimento del famoso motto di Mies van der Rohe “less is more”: Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare. Togliere invece che aggiungere vuol dire riconoscere l’essenza delle cose e comunicarle nella loro essenzialità. Questo processo porta fuori dal tempo e dalle mode. La semplificazione è il segno dell’intelligenza, un antico detto cinese dice: quello che non si può dire in poche parole non si può dirlo neanche in molte. Come per Munari e Klee, il milanese condivide anche con Mondrian lo stretto legame con la natura: per l’olandese, infatti «Nel naturale possiamo percepire che ogni rapporto è dominato da un rapporto primordiale: quello degli estremi opposti attraverso una dualità di posizioni ortogonali tra loro» . Mondrian è anche responsabile della formazione anti-romantica di Munari, in particolare per quanto riguarda la funzione dell’arte: l’operare artistico dipende, per l’olandese, dalla «riconciliazione uomo-ambiente» e deve proseguire verso una progressiva «scomparsa del tragico». In altre parole, Munari recupera l’insegnamento di Mondrian adattandolo alla situazione italiana e coglie dal maestro la volontà di azzerare il linguaggio visivo corrente per crearne uno di nuovo. Questo codice dovrà segnare una totale autonomia rispetto a ciò che lo ha anticipato in particolare il futurismo e il cubismo per giungere ad una diversa figura d’artista, al quale spetterà il compito di legare il problema dell’arte al problema sociale. Dunque, la nuova funzione dell’arte risiede nella capacità dell’arte stessa di interagire e integrarsi con il mondo e con la società e di essere utile all’uomo, nella maniera più naturale possibile. Infine, l’obiettivo di Mondrian di «ricostruire e rettificare il processo della percezione; correggere le storture di una falsa educazione visiva» è condiviso da Munari sia negli scritti teorici, così attenti all’aspetto didattico, ché nell’attività artistica, la quale mira, come abbiamo visto, ad una nuova educazione visiva, purificata da ciò che è superfluo. Influenzato dalle avanguardie e dagli artisti che vi hanno fatto parte, verso la metà degli anni ’30 Munari sperimenta studi di percezione visiva e giunge, dopo la guerra, alla realizzazione di due opere in particolare che segnano un punto di svolta rispetto alle influenze futuriste e astrattiste. Anzitutto le Sculture da viaggio, nate alla fine degli anni ’50, «oggetti a funzione estetica» , vere e proprie sculture in miniatura, leggere e poco ingombranti, che hanno la caratteristica principale di poter essere smontate occupando uno spazio bidimensionale e rimontate ritorno alla tridimensionalità infinite volte e portate con sé anche in viaggio, appunto. Nello stesso periodo Munari realizza anche i primi Positivi-Negativi, a cui abbiamo già accennato, opere che si inseriscono pienamente nell’attività astratta dell’artista. «L’idea base che genera questi dipinti, sta nel fatto che ogni elemento che compone l’opera, ogni forma, ogni parte della superficie, può essere considerata sia in primo piano sia come fondo». La serie Positivi-Negativi è anche un omaggio a Mondrian: la riflessione sul problema dello sfondo viene risolta con l’effetto ottico dove ogni elemento del quadro può essere letto da diversi punti di vista. Questa parte della ricerca munariana è stata collegata da molti studiosi all’esperienza della scuola del Bauhaus, soprattutto attraverso l’attività di tre artisti: Joseph Albers, Moholy-Nagy e Max Bill. A questo riguardo lo scrittore e critico d’arte Guido Ballo scrive: Munari sente la necessità di “sperimentare”, di applicare decisamente l’arte all’industria, di moltiplicare una stessa opera, con punti di vista diversi; né ha il timore di volgersi alla grafica pubblicitaria e all’industrial design. Sa con chiarezza che l’esempio del Bauhaus può essere efficace proprio per il rinnovamento di un’arte nel rapporto con l’industria. Ma è lo storico Aldo Tanchis, a cui «si deve un saggio assai acuto sul designer» come sottolineato da Gloria Bianchino che realizza un quadro completo riguardo le influenze di ambito artistico che hanno interessato l’attività teorica e pratica di Munari. Cominciamo prendendo in esame, seppur in modo sommario, l’attività artistica di Josef Albers, che dal ’25 al ’33 insegna alla scuola di Dessau. L’artista indaga il problema della densità spaziale e della profondità del dipinto, oltre che le proprietà dei materiali, condizionando non poco l’attività del milanese, come conferma lo storico dell’arte Filiberto Menna: Munari si muove soprattutto sulla via aperta da quest’ultimo (Albers), in direzione cioè di un’arte intesa come pura ricerca visiva, come analisi grammaticale del linguaggio pittorico e plastico compiuta con l’ausilio della psicologia della percezione. Due opere di Munari sono da considerarsi il risultato concreto di queste riflessioni: con i Positivi-Negativi il milanese sperimenta l’effetto OP (optical art), attraverso il quale «ogni forma che compone l’opera sembra che si sposti, che avanzi o che vada indietro nello spazio ottico percepito dallo spettatore». Allo stesso modo, il dipinto Anche la cornice del 1935 va interpretato alla luce del nuovo interesse per i problemi di comunicazione visiva, rivolto in particolare ad «una precisa sperimentazione su fenomeni ottici come la irrequietezza percettiva di un pattern e la ambiguità tra figura e sfondo». L’interesse di Munari verso le ricerche di Albers è confermato anche dalla firma alla prefazione del libro del pittore tedesco Interazione del colore, dove il designer mette in luce le infinite variabili che alterano la percezione dei colori e accenna ad alcune delle sperimentazioni cromatiche proposte da Albers all’interno del saggio. Lo stesso Munari sottolinea come tali ricerche «potrebbero essere utili a operatori in campi diversi» e non solo a chi si occupa di arte pura, accennando l’interesse dei designers nei confronti della percezione del colore su materiali utilizzati nell’ambito dell’arte applicata, come ad esempio la reazione di tessuti di materie diverse ad un bagno dello stesso colore. Anche le indagini di Moholy-Nagy appassionano il giovane artista. Dall’esperienza dell’ungherese nell’ambito di ricerca attorno la luce e il movimento, Munari dà vita alle Proiezioni a luce polarizzata. A differenza delle Proiezioni dirette, che si avvalgono di materie plastiche colorate, trasparenti, semitrasparenti o opache inserite in un telaietto per comporre un “quadro statico” proiettato con un comune proiettore per diapositive, le Proiezioni a luce polarizzata hanno i colori della composizione che cambiano per tutto l’arco cromatico fino ai rispettivi complementari, grazie alla rotazione del filtro polarizzante. Nel telaietto vengono inserite materie plastiche trasparenti ma senza colore. Rispetto a questo tema, è ancora Filiberto Menna ad affermare: «l’artista (Munari) si rivolge ad altri strumenti di comunicazione visiva, proseguendo le ricerche sulle possibilità espressive della fotografia condotte da Moholy-Nagy». Per l’artista bauhausiano «L’immagine non è il risultato, ma la materia e l’oggetto della ricerca»: Poiché non c’è visione senza luce, l’analisi dell’immagine (che è sempre luminosa) diventa analisi della luce: la luce essendo movimento, movimento e luce sono le due componenti fondamentali dell’immagine. Essenziale è quindi lo studio delle qualità assorbenti, riflettenti, filtranti e rifrangenti della superficie (texture) delle diverse materie. Sappiamo che Munari conosce bene «le ricerche di Moholy-Nagy sia in fotografia che sul movimento»; a confermarlo è egli stesso poiché, nell’intervista allo storico dell’arte Arturo Carlo Quintavalle, afferma di muovere le proprie sperimentazioni dalla «nuova tecnica fotografica iniziata da Man Ray e da Moholy-Nagy» . Altro punto di contatto con l’ungherese riguarda la ricerca del metodo che risolve il problema dello sfondo: entrambi gli artisti partono dal «rifiuto dell’astrattismo “lirico” di Kandinsky» e arrivano a soluzioni innovative che si avvalgono di strumenti e materiali moderni, dimostrando una profonda attenzione alla contemporaneità. Munari condivide alcuni elementi della sua ricerca anche con Max Bill, allievo dei grandi maestri del Bauhaus e attento indagatore dell’arte concreta, tanto da entrare in contatto, dal dopoguerra, con i fondatori del MAC (Soldati, Dorfles, Monnet, Munari). Nell’intervista a Quintavalle, Munari dichiara di seguire le esperienze di Bill attorno agli alfabeti e ai problemi topologici. La convergenza teorica dei due nei confronti di questioni artistiche oggettive e verificabili, li porta a condividere il rifiuto dello styling, ovvero un tipo di progettazione industriale legato alla moda, che antepone alla progettazione stessa un’idea artistica; l’attenzione ai rapporti forma-funzione, nel modo in cui la forma è il risultato della funzione che l’oggetto deve svolgere; la battaglia per il good design, conseguenza del dissenso allo styling e della ricerca del rapporto forma-funzione. Alla fine degli anni ’40, Munari è ormai proiettato verso la grafica e il design, il suo interesse si è fatto più “pratico” e legato ad un uso quotidiano. La ricerca puramente astratta è limitante per un artista «convinto che l’arte dovesse vivere nel mondo degli uomini, nella realtà fenomenologica, nel flusso delle cose» e anche perché, secondo Munari, «l’arte astratta di allora era in realtà una rappresentazione verista di oggetti. Una natura morta di oggetti inventati: triangolo, quadrati, linee, piani… invece di bottiglie e pere». Le ricerche di Munari, che dagli anni ’40 esplodono in mille direzioni perché è più importante l’operare che l’opera stessa incrociano, lungo il loro percorso di maturazione, anche elementi dadaisti. Filiberto Menna, riferendo la complessità di rintracciare nell’opera di Munari un senso unitario di ricerca e sperimentazione, parla dell’equilibrio della poetica dell’artista tra i temi centrali del futurismo, ovvero la «interpretazione dell’arte come totalità e come strumento di riedificazione dell’ambiente per il tramite della macchina e della tecnica moderna», e i temi ironici e antimacchinistici propri del dadaismo. Munari affronta i problemi teorici legati all’arte con «una componente ludica che sembra derivare dalla astratta ironia metafisica di Duchamp», in particolare attraverso due filoni di indagine collegati al movimento anti-arte: la poetica del casuale e l’uso dell’ironia. La “legge del caso”, che con Duchamp raggiunge la sua massima espressione, viene filtrata e adattata da Munari: il milanese coglie dall’insegnamento duchampiano ciò che gli interessa, come spesso è accaduto anche con altri movimenti artistici, e lo adegua al suo modo di fare arte. Munari fa affidamento alla “legge del caso” nella fruizione delle Macchine inutili, introducendo «un elemento di distrazione nei confronti della funzionalità pura, in modo da porre l’accento sulla componente di una libera e gioiosa contemplazione-fruizione dell’oggetto». Ecco, dunque, che il movimento della macchina inutile dipende da agenti esterni, come il vento o la spinta da parte del fruitore. Ma è nella performance del 1969 Far vedere l’aria che la poetica del caso è particolarmente esplicita, senza dimenticare che questa giocosa operazione ha un precedente futurista: Aldo Tanchis ricorda infatti che nel 1914 Bruno Corra e Emilio Settimelli proposero di «combinare degli organismi con dei pezzi di legno, tela, carta, piume e inchiostro, i quali lasciati cadere da una torre alta 37 metri e 3 centimetri, descrivono cadendo a terra una certa linea più o meno rara». In questa azione-gioco, che Munari progetta fin nei minimi particolari l’artista fornisce misure e forme precise per i pezzetti di carta, lasciando anche la possibilità al pubblico di pensare a forme nuove ed alternative il ruolo del caso è determinante per il movimento e l’atterraggio delle strisce lasciate cadere dalla torre. La poetica del caso viene dunque adattata alle esigenze progettuali dell’artista divenendo, attraverso una puntuale programmazione, un’esperienza di «dada propositivo». In questo senso, la performance ha a che fare con l’idea di “arte” proposta dall’antropologo Alexander Alland. Egli, infatti, definisce “arte” un «gioco con una forma che produce una qualche trasformazione-rappresentazione esteticamente valida», dove per “forma” si intendono le regole del gioco dell’arte. Tornando al tema del caso, in Munari esso è certamente presente, ma è mitigato dalla costante ricerca della regola, che è utile conoscere per poterla trasgredire, ma che rimane il punto di partenza del suo lavoro. Del resto, la convivenza di caratteristiche contrapposte è un elemento importante nell’opera dell’artista milanese, per il quale l’equilibrio risiede nella coesistenza di energie contrarie, come afferma egli stesso: «La vita è un continuo equilibramento di forze contrapposte: il lavoro viene equilibrato col riposo, il giorno dalla notte, il caldo dal freddo, l’umido dal secco, l’uomo dalla donna, e via dicendo». Nel rapporto dialettico tra serietà e gioco, tra positivo e negativo, tra yin e yang esiste un elemento che permette di raggiungere tale equilibrio, forse la caratteristica più appariscente del lavoro di Munari, l’ironia. La funzione che essa svolge nelle opere del milanese è duplice: l’artista sfrutta l’umorismo per mantenere un senso di inafferrabilità nelle sue opere e nella sua stessa professione. Il senso di inafferrabilità sottolinea la volontà dell’artista «di non restar prigionieri di un’immagine qualsivoglia, intellettuale, fisica, poetica o tecnica che sia». Inoltre, se consideriamo il discorso legato all’ironia in rapporto al dadaismo, individuiamo la sua seconda caratteristica, ovvero la capacità di togliere all’oggetto creato nel caso di opere d’arte e di design il senso di sacralità che per Munari diventa un pericolo, qualcosa da cui è necessario allontanarsi. Nel dadaismo «l’arte è gioco» e l’ironia fa da fertilizzante in ogni azione artistica, che in realtà è essa stessa nulla. L’opera perde importanza, valore e significato, ma acquista dignità intellettuale attraverso il gesto desacralizzante dell’artista. Tale operazione, chiamata ready-made e definita da Argan come il processo che determina un valore ad «una cosa a cui comunemente non se ne attribuisce alcuno», dunque considerata non attraverso il procedimento operativo, ma piuttosto come «un mutamento di giudizio» , è descritta anche da Munari che spiega ironicamente «Più vicino a noi Marcel Duchamp presentò un pisciatoio come fontana. Questo oggetto che aveva sempre ricevuto getti liquidi, adesso li restituisce e diventa una fontana» . Ricorda il ready-made l’operazione artistica-gioco del Museo inventato sul luogo, dove oggetti trovati in natura e non solo, raccolti e catalogati, costituiscono la collezione di un museo personale che ognuno può realizzare in casa propria. Munari, con ogni suo progetto, ribadisce la regola per cui «una cosa può essere anche un’altra cosa». A questa regola rispondono molte altre opere del milanese, come gli Olii su tela del 1980, forse l’opera più concettuale dell’artista, con la quale egli critica e desacralizza l’arte accademica ironizzando attorno alla tecnica tradizionale di “olio su tela”: Restano l’olio e la tela. Olio su tela. La tela con i suoi colori raffinatissimi, dalla tela di canapa a quella di lino, a quella di cotone, a quella sottilissima di batista. Gli oli da quello di lino a quello di papavero, a quello di mandorle, a quello di ricino, colori appena visibili. Molto più raffinati del banale rosso e verde bandiera. Olio su tela, olio puro, tela senza telaio, oli su tele. Anche le Proiezioni dirette, nate come opere originali e diventate uno dei giochi del primo laboratorio per bambini di Brera del 1977, rispondono alla regola sopracitata: queste piccole composizioni, realizzate direttamente nei telaietti per diapositive, trasformano banali materie plastiche in opere d’arte. Piccoli pezzi di plastica e carta colorata di diverse trasparenze, fili e reti metalliche, piume e foglie, assemblati in modo creativo e proiettati al muro in scala maggiore diventano espressioni artistiche, recuperando dignità e valore intellettuale. La funzione dissacratoria dell’ironia è rivolta anche all’arte contemporanea, o meglio, alla «pura arte commerciale»: l’obiettivo critico delle pungenti battute, che ritroviamo negli scritti teorici, rivolte ad artisti e/o movimenti affermati del panorama contemporaneo, «è la mancanza di educazione e informazione estetica» , di cui è responsabile la critica, che dovrebbe fare da tramite con il pubblico, ma che sempre più frequentemente tiene conto del profitto e del mercato e mantiene l’ignoranza nella gente. Se prendiamo in considerazione gli scritti teorici di Munari, vediamo che egli utilizza l’umorismo anche per discutere del suo lavoro: il riso, nato da una battuta spiritosa, muove nel lettore riflessioni che altrimenti non germinerebbero ed «è segno di equilibrio interiore». Dunque la funzione temporale dell’ironia, messa in luce da Argan e Tanchis, permette alle opere di Munari di mutare continuamente, prendendo forme nuove e comunicando sempre sensazioni diverse. L’ironia è funzionale al completamento, alla comprensione, all’equilibrio e alla demitizzazione dell’opera e contribuisce a riportare sul piano della realtà il lavoro di Munari. Infine, accenniamo ad un elemento di continuità tra Munari e i movimenti artistici di cui abbiamo parlato fino ad ora, ovvero il “libro d’artista”. Questo tema che certamente richiederebbe un approfondimento ben più ampio di quello che qui proponiamo ha a che fare con l’esperienza del milanese all’interno, o meglio ai confini, delle avanguardie ed è molto importante nella revisione della sua opera, soprattutto tenendo conto delle direzioni che Munari prenderà con il lavoro di editoria per l’infanzia. Il periodo che va dalla fine degli anni Trenta fino alla conclusione della guerra evidenzia una svolta negli interessi del milanese, che si rivolgono in modo significativo verso la grafica. In questo periodo l’artista, che vive a Milano città molto attiva in ambito editoriale ha la possibilità di conoscere il lavoro di autori a lui contemporanei. Attraverso le riviste dell’epoca il giovane Munari entra in contatto con l’attività di molti artisti che utilizzano il libro d’arte per diffondere il loro lavoro, poiché come dice la storica Maura Picciau: L’appropriazione del libro da parte delle avanguardie artistiche è strettamente connessa alla volontà di allargare il proprio pubblico, di uscire, grazie al medium più comune, dal chiuso delle gallerie d’arte. Il libro come tramite comunicativo rapido, economico e democratico. E la fruizione, consapevolmente dinamica, di un libro d’artista, si avvicina all’idea di performance, di esperienza estetica dell’autore e del lettore/fruitore dilatata nel tempo e nello spazio. Il libro diventa un nuovo codice comunicativo, «luogo di confronto con le altre discipline», e come tale è fonte di profondo interesse da parte di Munari che, muovendo dall’esperienza futurista del “libro d’arte” attraverso il lavoro di Marinetti e d’Albisola, ma anche dal dadaismo e da artisti come Hannah Höch o esponenti della Bauhaus quali Oskar Sclemmer o Moholy-Nagy, giunge alla realizzazione dei libri illeggibili, probabilmente la conclusione più radicale della ricerca sull’astrazione. L’esperto di storia dell’editoria Giorgio Maffei non manca di sottolineare come Munari «nella piena maturità dell’astrattismo concretista, dà l’ultima spallata al ruolo informativo del libro eliminandone la sua peculiare caratteristica, la leggibilità, aprendo così la via ad una sua definitiva deflagrazione» . Il libro, con Munari, diventa nuovo linguaggio espressivo, luogo di «equilibrio compositivo e cromatico, di sequenza formale logica» e, come sottolinea Menna, «si trasforma in oggetto inutile, in un libro illeggibile, ma nello stesso tempo si presenta come un modello per libri in grado di offrire la possibilità di letture sempre nuove e ricche di imprevisti». Come abbiamo visto, Bruno Munari sperimenta ogni avanguardia e movimento artistico con cui entra in contatto, dal futurismo, all’astrattismo, al surrealismo, al dadaismo: il suo animo curioso mette alla prova ogni tecnica possibile, ogni riferimento estetico, percorre tutte le direzioni che incontra, per ridurre le innumerevoli esperienze entro la propria visione del mondo e il proprio fare artistico. Per questo motivo è difficile tracciare un profilo chiaro dell’artista ed è impossibile costringerlo in categorie cronologiche o stilistiche: egli è futurista, astrattista, surrealista, dadaista e, allo stesso tempo, non è nulla di tutto ciò. Il comune denominatore della poetica di Munari, l’elemento che tiene insieme tutte le forme d’espressione del milanese, è, come vedremo, l’amore per il progetto, una costante del suo modo di fare arte, design e didattica. Se noi ripercorriamo la storia intellettuale di Bruno Munari, possiamo notare come, dal secondo dopoguerra, egli diriga gli sforzi artistici, intellettuali e progettuali verso un sano e più diretto rapporto con il pubblico. Nel corso di questo processo l’artista si avvicina al mondo dell’infanzia attraverso i primi libri per bambini, nati, come abbiamo visto, da un esigenza personale, la nascita del figlio Alberto. Nello stesso periodo il milanese entra in contatto con l’editoria e la grafica che in Italia, negli anni che seguono il conflitto mondiale, tiene il passo rispetto alle esperienze europee e americane. A tale proposito, Meneguzzo chiarisce che «l’aggiornamento era già un dovere per chi aveva a che fare con l’industria editoriale e pubblicitaria». Ma il dopoguerra è un periodo importante per Munari anche dal punto di vista teorico poiché, come abbiamo precedentemente accennato, egli fonda, nel 1948, il MAC (Movimento Arte Concreta), assieme agli amici artisti Atanasio Soldati, Gillo Dorfles e Gianni Monnet , accomunati dal rifiuto delle tendenze post-cubiste e realiste. Questa esperienza, «non molto ricca dal punto di vista della mera produzione di oggetti d’arte», è però fondamentale per il lavoro di Munari perché sposta l’attenzione su architettura, arredamento e design promuovendo, soprattutto nella sua seconda fase (dai primi anni Cinquanta), l’idea di integrazione e «sintesi tra le arti». Il Movimento, inizialmente orientato a promuovere un nuovo tipo di astrattismo più vicino al costruttivismo puro, si pone il problema della «vera funzione sociale dell’arte» con l’obiettivo di «migliorare non solo l’animo umano ma anche l’ambiente dove l’uomo vive»6. Lo stesso Munari mette in luce l’evidente incomprensione che intercorre tra pubblico e artisti, sottolineando come questi ultimi vivano isolati nei loro ateliers, in contrasto con un pubblico che vive in città grigie, viaggia su brutti veicoli ed è circondato da pubblicità volgari. Il desiderio dei concretisti e di Munari in particolare è dunque riavvicinare gli artisti alla vita reale e alle persone, staccandoli dalla loro arte pura e portando la loro sensibilità artistica all’industria. L’esperienza all’interno del MAC e la collaborazione con gli artisti e gli intellettuali del movimento sarà, per Munari, l’occasione di ragionare su alcune importanti questioni che riguardano l’arte del suo tempo. Tra le innovazioni teoriche del milanese, analizzeremo in particolare il nuovo ruolo dell’artista nella società contemporanea, la democratizzazione dell’arte, che con Munari torna ad essere arte di tutti, la desostantivizzazione dell’oggetto artistico, il quale, per rispondere alle esigenze della società, deve essere riportato alla vita quotidiana e, infine, la regola base della progettazione munariana, ovvero la corrispondenza tra forma, materia e funzione. Una delle prime questioni che Munari affronta muovendo dalle riflessioni nate all’interno del MAC è strettamente legata al suo lavoro d’artista: dopo le esperienze degli anni Trenta e Quaranta con il futurismo, il surrealismo, l’astrattismo e il dadaismo, Munari comprende che l’arte non è utile alla società nella misura in cui lo era un tempo. Arte come mestiere il primo dei testi didattici del milanese dedicati ad un pubblico adulto, pubblicato nel 1966 da Laterza è il risultato di questo primo e fondamentale ragionamento teorico, che porrà le basi per la concettualizzazione di una nuova figura dell’artista di epoca contemporanea. Munari spiega, con un linguaggio tanto semplice da risultare quasi disarmante, che l’artista di oggi deve rimettere in discussione il suo ruolo e il suo modo di intendere l’arte poiché ciò che produce interessa una cerchia ristretta di “addetti ai lavori” e non risponde ai bisogni o alle necessità della società contemporanea. La risposta dell’artista al problema è dunque il design, nuovo linguaggio artistico che risponde ai bisogni reali del pubblico. L’origine di questa intuizione arriva dall’esperienza del Bauhaus filtrata attraverso il MAC e le Gallerie milanesi che promuovevano l’arte delle avanguardie nella quale Walter Gropius voleva «formare un nuovo tipo di artista creatore e capace di intendere qualunque genere di bisogno». Munari, del designer, mette in primo piano il metodo di lavoro che pone al centro la forma dell’oggetto, la quale «ha un valore psicologico determinante al momento della decisione di acquisto da parte del compratore». Tale metodo di progettazione procede attraverso «la stessa naturalezza con la quale in natura si formano le cose», segue un ragionamento logico, quasi scientifico, nella misura in cui «aiuta l’oggetto a formarsi con i suoi propri mezzi» ed è definito da Meneguzzo “astilistico” lo studioso parla di «metodicità “astilistica”» poiché il fine ultimo dell’artista è «disegnare oggetti senza tempo, tanto essenziali da non poter essere modificabili». Dunque, per Munari, con il cambiare dei bisogni della società, è cambiato il modo di intendere e fare arte: un tempo la collettività necessitava di un certo tipo di comunicazione visiva poiché il basso grado di alfabetizzazione rendeva la gente incapace di assorbire informazioni se non attraverso le immagini diffuse per mezzo della pittura. Oggi è il designer «l’artista della nostra epoca» poiché egli «conosce i mezzi di stampa, le tecniche adatte, usa le forme e i colori in funzione psicologica» e «con il suo metodo di lavoro riallaccia i contatti tra arte e pubblico». Bruno Munari inventa e codifica un nuovo mestiere: l’artista, da genio-divo, diventa un operatore visuale, in grado di rispondere ai bisogni veri della società in cui vive attraverso un logico metodo di lavoro. Questa riflessione munariana sottintende un cambio di prospettiva rispetto alla visione filosofica della figura tradizionalmente intesa come genio, elaborata prima da Kant nella Critica del giudizio e ripresa successivamente da Schopenhauer. Per il filosofo tedesco «la conoscenza geniale è quella che non segue il principio di ragione» ed è dunque in assoluta antitesi rispetto all’idea del milanese di intendere il lavoro dell’artista, ovvero l’operatore visuale. Secondo Munari il designer deve procedere seguendo un metodo logico e metodico, quasi scientifico, che giustifichi le scelte formali, le quali non devono essere il risultato di una ispirazione, ma la conseguenza di un ragionamento che tenga conto di tutte le componenti dell’oggetto. Secondo la riflessione munariana il mestiere d’artista è oggi necessario tanto quanto lo era un tempo, la differenza sta soprattutto nel variare dei bisogni della società, la quale, oggi, «chiede un bel manifesto pubblicitario, una copertina di un libro, la decorazione di un negozio, i colori per la sua casa, la forma di un ferro da stiro o di una macchina per cucire». Il milanese, consapevole del fatto che ogni prodotto richiede competenze specifiche, distingue il design in quattro settori: il visual design «si occupa delle immagini che hanno la funzione di dare una comunicazione visiva»; l’industrial design riguarda «la progettazione di oggetti d’uso»; il graphic design «opera nel mondo della stampa, dei libri, dovunque occorra sistemare una parola scritta» infine il design di ricerca, certamente il più sperimentale, che si occupa di strutture plastiche e visive, mettendo alla prova le possibilità dei diversi materiali. Ma Munari non manca di sottolineare anche l’esistenza dello styling, uno degli aspetti più diffusi e facili del design, il tipo di progettazione industriale più effimero e superficiale, poiché «si limita a dare una veste di attualità o di moda a un prodotto qualunque». Naturalmente lo stilista opera in maniera diversa dal designer, limitandosi a recuperare stili e forme dell’arte pura operando per contrasti, ovvero se prima si usavano forme curve, adesso si usano forme quadrate per conferire una nuova immagine agli oggetti: «senza cambiare nulla dell’interno, si cambia il vestito, si lancia come una nuova moda e si dice, attraverso la propaganda, che la forma vecchia non usa più». Il designer, consapevole del fatto «che una scultura e una carrozzeria d’auto sono due problemi diversi» , mira all’oggettività formale nell’atto di progettazione, poiché «l’unica preoccupazione è di arrivare alla soluzione del progetto secondo quegli elementi che l’oggetto stesso, la sua destinazione ecc., suggeriscono». Tale riflessione deve però tenere conto del fatto che la risposta individuale del designer a un bisogno comune sottintende inevitabilmente delle scelte personali, le quali, in un certo qual modo, definiscono uno stile. In questo senso, dunque, è necessario ragionare attorno all’idea che anche il metodo di lavoro proposto da Munari, per quanto miri ad un risultato formale obiettivo e ambisca ad essere esso stesso privo di stile, comporta inevitabilmente una stilizzazione. Munari non si limita a separare il lavoro del designer da quello, certamente meno logico e oggettivo, dello stilista. In un articolo pubblicato su La Stampa, egli pone in evidenza le differenze tra il lavoro del designer e quello dell’artista, sottolineando i due diversi modi di operare. Munari sottolinea il fatto che entrambe le professioni sono utili alla società, ciò che è importante è che il designer non operi pensando da artista, ovvero «anteponendo forme e colori nati nell’arte pura alla progettazione di un oggetto che chiede solo di essere vero secondo la sua epoca», senza cadere nella “trappola” dello styling. Un anno dopo, a partire dal suo percorso professionale in cui è stato sia artista che designer, con la pubblicazione di Artista e designer, recupera e approfondisce la distinzione tra le due professioni e aggiunge personalmente ritengo valide entrambe le posizioni, sia quella dell’artista che quella del designer, purché l’artista sia un operatore vivente nella nostra epoca e non un ripetitore di formule passate sia pure di un recente passato, e il designer sia un vero designer e non un artista che fa dell’arte applicata. In fondo, come abbiamo visto all’inizio di questo capitolo, ciò che interessa a Munari dell’arte è che essa possa ritrovare la sua funzione all’interno della società, che sia utile e necessaria all’uomo per migliorarne la vita, sia dal punto di vista concreto, sia da quello psicologico, così come dichiarato nei bollettini del MAC da diversi intellettuali: «Io credo che quando l’arte tornerà ad essere di nuovo un mestiere, necessaria all’uomo come il pane del fornaio, allora potremo dire di aver ritrovato l’arte». E, in Arte come mestiere, Munari non dimentica di dare una personale opinione rispetto all’arte del suo tempo, la quale, purtroppo, altro non è che «lo specchio della nostra società, dove gli incompetenti sono ai posti di comando, dove l’imbroglio è normale, dove l’ipocrisia è scambiata per rispetto dell’altrui opinione, dove si fanno mille leggi e non se ne rispetta nessuna». Il percorso espositivo si apre con il grande “padre” Lucio Fontana, elemento propulsore e catalizzatore di questa stagione,riferimento imprescindibile per questa generazione, nonché fondatore dello Spazialismo, movimento al quale aderiscono artisti quali Gianni Dova, Roberto Crippa, Cesare Peverelli; parallelamente, Milano dà i natali al Movimento nucleare, creato da Enrico Baj e Sergio Dangelo. Nel settembre 1959 esce il primo numero della rivista Azimuth, la cui storia non si può scindere da quella dei suoi due fondatori, Enrico Castellani e Piero Manzoni. Più che una pubblicazione, Azimuthèun “ritrovo intellettuale”, un’esperienza radicale dall’apertura internazionale, un luogo di confronto, di dibattito, di scoperta, dalle cui pagine si assiste al superamento della pittura in senso tradizionale, alla nascita di nuovi linguaggi, alla possibilità di contaminazione con altre realtà. Dopo l’esperienza di Azimuth, la mostra documenta le sperimentazioni del Gruppo T, formato da personalità quali Gianni Colombo, Davide Boriani, Grazia Varisco, la cui ricerca si concentra sul rapporto tra tempo e spazio e l’idea di movimento nell’opera d’arte e che ha come padre putativo Bruno Munari che con le sue Macchine inutili e con i suoi Negativo-positivo– esposte a Palazzo delle Paure – aveva già introdotto importanti elementi di riflessione sia sul tema del dinamismo sia su quello della percezione. Nel panorama di questo generale rifiuto della pittura intesa nel senso tradizionale del termine, si distingue un sodalizio di artisti, nato ufficialmente nel 1962, definito come il Gruppo del Cenobio, dal nome dell’omonima galleria d’arte milanese, che vede tra i suoi protagonisti Agostino Ferrari, Ugo La Pietra, Ettore Sordini, Angelo Verga e Arturo Vermi; questi artisti, pur sposando la volontà di un superamento dell’atto pittorico classico, propongono una riflessione diversa, che salva la pittura ma attribuendole un valore espressivo-scritturale. Una parentesi è inoltre dedicata alla realtà delle Botteghe di Sesto, a Sesto San Giovanni, dove avevano sede numerosi studi d’artista, diventate in breve tempo delle importanti fucine di sperimentazione e che annovera artisti noti a livello internazionale, quali Enrico Castellani, Arturo Vermi, Turi Simeti, Antonio Scaccabarozzi, Agostino Bonalumi, ma anche autori di cui si è attualmentepersa la memoriama che hanno contribuito all’evoluzione della scena artistica milanese del tempo. In mostra si può ammirare unlibro con opere autografe e originali, realizzato per il custode dello stabile dagli artisti residenti nell’area delle Botteghe, da Castellani a Vermi, da Simeti a Scaccabarozzi.
Palazzo delle Paure Lecco
Milano Anni ’60.
Da Lucio Fontana a Piero Manzoni, da Enrico Baj a Bruno Munari.
dal 13 Luglio 2024 al 24 Novembre 2024
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Dal Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 18,00
Lunedì Chiuso