Giovanni Cardone Aprile 2024
Fino al 16 Giugno 2024 si potrà ammirare alle Scuderie del Quirinale Roma la mostra“Napoli Ottocento. Degas, Fortuny, Gemito, Mancini, Morelli, Palizzi, Sargent, Turner” a cura di Sylvain Bellenger insieme a Jean – Loup Champion, Carmine Romano e Isabella Valente. Un progetto espositivo di grande respiro e di alto rilievo scientifico organizzato dalle Scuderie del Quirinale e dal Museo e Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, la Direzione Regionale Musei Campania, l’Accademia di Belle Arti di Napoli e la Stazione Zoologica Anton Dohrn. Il progetto si inserisce a pieno titolo in una delle linee programmatiche intraprese ormai da tempo dalle Scuderie del Quirinale:il racconto sistematico delle tante, straordinarie civiltà figurative che hanno caratterizzato la storia artistica d’Italia, ricca di ‘capitali artistiche’ più di qualsiasi altro paese. Attraverso una selezione di 250 capolavori, la mostra rappresenta un omaggio al ruolo centrale di Napoli nell’ambito del dibattito europeo sull’arte. Napoli si propose come un centro di produzione artistica di assoluta centralità europea per tutto l’Ottocento, ovvero quel ‘secolo lungo’che prende le mosse dagli esiti della cultura illuminista di fine Settecento e che arriva ad estendersi fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, così strettamente connesso alla nascita dell’Italia moderna eppure ancora non abbastanza conosciuto e per questo ancora da scoprire. L’esposizione incarna, dunque, la perfetta sintesi della eccezionale vitalità artistica di una città che ha continuato ad attrarre tutti i più grandi artisti attivi in Europa o provenienti dalle più giovani scuole nordamericane, giunti per vivere l’esperienza ineludibile della scoperta di Pompei ed Ercolano ma poi folgorati dalla bellezza prorompente del paesaggio campano, dalla ricchezza del patrimonio storico e artistico di quei luoghi, dai contrasti di una città dall’incanto unico al mondo. Una panoramica ricchissima tra dipinti, sculture, arti decorative, storia e scienza: eloquenti testimonianze, malgrado i problemi e le tensioni sociali e politiche, di una tradizione artistica e culturale davvero secolare e ancora viva, inserita a pieno nella cultura europea contemporanea. In una mia ricerca storiografica e scientifica sul Gran Tour e sulla Pittura Napoletana dell’Ottocento apro il mio saggio dicendo : Posso affermare che la socialità dei forestieri a Napoli presenta un particolare interesse se esplorata nei decenni che vanno dal ritorno di re Ferdinando di Borbone sul trono di Napoli nel 1815 al crollo del Regno delle Due Sicilie nel 1861. Nel corso di quei decenni in molte aree europee i servizi al viaggio e al soggiorno vennero rapidamente affinandosi ponendo le basi della successiva maturazione del turismo, ma proprio allora Napoli era gravata dalle conseguenze delle recenti, tumultuose traversie politiche, la fuga del re in Sicilia nel 1798 e la Repubblica del 1799, il primo ritorno dei Borbone nel 1802, l’ingresso dei francesi nel regno nel 1806 e il nuovo abbandono della città da parte del re, fino alla definitiva restaurazione della monarchia del 1815 a seguito del Congresso di Vienna. Sono eventi traumatici che, da una parte interrompono e/o modificano le pratiche di viaggio e di soggiorno diffusesi nel Regno nel secondo Settecento sostanzialmente incentrate sulla villeggiatura in campagna e sul viaggio scientifico e antiquario dei grand tourist e dall’altra generano nuovi atteggiamenti e mode. A Napoli ritroviamo, infatti, un caleidoscopio di ospiti regnicoli, degli altri stati italiani e stranieri che, per riflesso delle vicende politiche, culturali ed economiche di cui hanno esperienza, hanno immaginari di loisir, di viaggio e di soggiorno molto differenti tra loro. Questo saggio cerca di comprendere se e come, nel contesto di uno Stato governato da una dinastia restaurata che pone resistenze alla circolazione delle istanze politiche e culturali più avanzate, questi flussi importanti di forestieri trovino uno spazio per realizzare il proprio immaginario di loisir e dunque di socialità.
Nel secondo Settecento è ben noto che su Napoli erano confluiti interessi di ambito scientifico e antiquario e frequentazioni intense di alto livello culturale. Gli scavi di Ercolano e di Pompei e i fenomeni naturali del Vesuvio e dei Campi Flegrei avevano attratto una fitta schiera di viaggiatori e studiosi . In accordo con l’uso del tempo, che spingeva alla ricerca di località climatiche sulle coste del Mediterraneo, i viaggi e i soggiorni di tanti forestieri avevano anche un fine terapeutico, considerato il clima mite della città. Questi scienziati, studiosi e soggiornanti in genere avevano già rapporti con Napoli, relazioni che erano poi coltivate sia nei luoghi deputati alla cultura, come le accademie, sia nei salotti privati. Sismologia, botanica, antiquaria, musica avevano dato vita a scambi nei quali cultura, politica e relazioni amicali si intrecciavano, com’è testimoniato da epistolari e memorie biografi che. D’altra parte, tra il Settecento e il ritorno dei Borbone, dopo la parentesi dell’epopea napoleonica, la capitale del Regno vive anni di crisi politica e di violenza così inaudita da interrompere gli arrivi. Negli anni più difficili la città si svuota. È solo tra il 1819 e il 1820 che i forestieri si ripresentano ai porti e alle frontiere del Regno, e nei loro resoconti di viaggio si legge chiaramente come nell’immaginario europeo si sia insinuata la percezione di Napoli come di una città rischiosa e insicura. Gli effetti economici sono evidenti: se nei mesi invernali e primaverili degli anni del secondo Settecento gli appartamenti ben arredati erano stati affittati anche a 200, 300 ducati al mese, tra il 1817 e 1818 gli appartamenti collocati nella zona frequentata dagli stranieri, vale a dire a Chiaja, al Chiatamone e a Santa Lucia, vengono offerti anche a 100, 150 ducati . Tuttavia gli arrivi sono destinati ad aumentare. Nel suo lavoro su viaggiatori e comunità straniere a Napoli nell’Ottocento Dieter Richter documenta, attingendo alle fonti di polizia, che nel 1823 gli stranieri presenti in città sono 1.143, che dieci anni dopo sono più che triplicati e che nel maggio del 1840 sono ben 8.437. La parentesi di relativa stabilità politica che il Regno vive dagli anni ’30 fi no ai rivolgimenti del 1848 procura, infatti, a Napoli oltre 6.000 arrivi di forestieri in media l’anno, mentre nei tardi anni ’50 lo stesso Richter valuta che ne entrino 11-12.000 . Questi ospiti del primo Ottocento hanno ovviamente profili diversi, e i più interessanti sono coloro che le guide di lingua inglese definiscono travellers. Si tratta di viaggiatori e, si badi, di viaggiatrici, che praticano un modo di visitare i luoghi analitico, colto e inquisitivo, solo in parte ravvisabile nel contemporaneo viaggio di diporto italiano. Non sono più giovani maschi soli, bensì intere famiglie di classe media, figli e figlie di ricchi industriali e mercanti, individui le cui rendite provengono in sostanza dal commercio e dall’industria . Ai travellers sono destinate le guide di nuova concezione, edite a partire da questi anni, tutte tese a fornire informazioni dettagliate sui servizi sul territorio nonché sugli spazi franchi frequentabili, al fine di semplificare al massimo la visita e il soggiorno. I travellers, infatti, rappresentano il bisogno di fare esperienza del viaggio scientifico e antiquario definito nel Settecento, ma anche di esplorare autonomamente nuovi spazi, che la sensibilità romantica europea ha di recente acquisito alla geografi a del viaggio, e sui quali sta affinando le proprie componenti sensitive. In questi anni Napoli e il suo golfo rappresentano proprio uno dei punti dell’area euro-mediterranea dove il sublime sta declinando verso il romantico e il pittoresco. Nei viaggiatori più colti il profilo della regione napoletana emerge per confronto con gli scenari naturali della Svizzera e, in seconda battuta, con Roma, la città dalla quale molti viaggiatori provengono. Paragonata allo splendore e alla solenne grandezza dell’architettura della città del papa, l’edilizia napoletana appare di cattivo gusto e la sua cupezza non riesce a essere riscattata dall’allegria della popolazione6. E tuttavia, mentre Roma è contornata da un deserto e da una natura che appare morta, Napoli è circondata da una vitalità eccezionale: «The air is fi re, the soil a furnace» scrive Sidney Owenson , nota come Lady Morgan, viaggiatrice irlandese colta e di spirito giacobino . Spingersi più a sud di Roma significa non solo raggiugere «the ordinary termination of the stranger’s pilgrimage to Italy», bensì tarare la propria sensibilità, in particolare visiva e uditiva, sulle infinite modulazioni della natura e dell’umanità, entrambe osservate collocandole su un piano separato e dunque spettacolare. «L’attenzione si sposta ora dalla realtà esterna all’animo di chi guarda e osserva». A partire dall’Ottocento sono i sensi a essere chiamati in gioco. Napoli è città rumorosa, musicale, chiassosa, vociante giorno e notte. La vista è chiamata a valutare la luce del cielo amplificata dallo specchio del mare, il buio dei valloni e l’azzurro abbagliante delle grotte marine. Il paesaggio è uno spettacolo al quale assistere e partecipare, e sul quale affermare l’autonomia dello sguardo turistico. Questa dinamica, che rende il viaggiatore una sorta di spettatore, fa sì che egli come tale si comporti e che possa essere sia distante e autonomo dalla scena, sia predisposto a emozionarsi e a farsi coinvolgere. Di qui il doppio registro assegnato a Napoli, percepita sia come città che contamina e dalla quale ci si attende di essere contaminati sia come eccezionale messa in scena, alla quale assistere. Come i canoni estetici del pittoresco soddisfano la propensione allo stereotipo, ma contemporaneamente accendono l’immaginario, così la domanda di sicurezza e di standard si combina col desiderio di un coinvolgimento personale, dell’imprevisto e della spontaneità. Chi arriva a Napoli e nelle località del golfo nei decenni della Restaurazione esprime una domanda di servizi che agevoli queste dinamiche, e le guide del tempo dosano molto abilmente il senso di sgomento generato dall’incognito e quello di certezza offerto dai servizi allora disponibili. Gli autori delle guide pubblicate a partire dagli anni ’30, o almeno di quelle che avranno maggiore fortuna, pur descrivendo i luoghi attraverso l’esperienza soggettiva, forniscono informazioni dettagliate sui servizi in loco, e spingono con forza verso la loro standardizzazione, suggerendo come muoversi senza ricorrere all’intermediazione di accompagnatori locali. Quanto alla socialità ecco allora che le guide per travellers cercano di rispondere ai bisogni dei propri lettori che in Inghilterra dispongono ormai di circoli, società, gabinetti di lettura e associazioni nei quali si discute liberamente, si formano opinioni, si leggono libri e giornali, si tengono conferenze e mostre, si ascoltano relazioni di viaggio e rapporti scientifici e si impegnano a individuare luoghi pubblici similari nelle città italiane. Non si tratta dunque dei luoghi della socialità comunemente intesa, come salotti e accademie, ma di spazi pubblici nei quali i travellers possano trovare accoglienza assieme a libri, giornali e informazioni, e nei quali possano comunicare e condividere una stessa cultura del viaggio. Certamente a Napoli il Teatro San Carlo rappresenta, assieme agli altri teatri della città, un’attrazione eccezionale anche per i travellers d’altronde in questi decenni il teatro è un luogo nel quale socialità e cultura sono inscindibili. Tuttavia per i travellers la socialità culturale è anche quella che nasce da incontri occasionali, ad esempio nel tempo dei trasferimenti, delle escursioni, del risposo o della contemplazione, come testimoniano resoconti ed epistolari. In ogni caso è ben noto che i forestieri a Napoli trovano un clima di serrato controllo poliziesco, che vigila la socialità persino negli ambienti privati: «Il capitolo divertimenti, sotto la dominazione borbonica, offre ben poco, giacché, allo scopo di non destare i sospetti della polizia, ognuno se ne stava rinchiuso nella propria “coterie”». In poche battute Ernesto Falcon, membro di una famiglia nizzarda trapiantata a Napoli e a Sorrento ai primi dell’Ottocento, con vasti rapporti sia con gli ambienti di corte prima francesi e poi borbonici, sia con quelli liberali, spiega perché la socialità delle famiglie straniere di profilo borghese è di fatto inesistente. È questo un dato che distingue Napoli da città come Firenze, Roma o Torino, dove le colonie straniere hanno importanti osmosi con la società locale e rappresentano un punto di riferimento per i forestieri in visita. Si pensi solo ai salotti che accolgono gli esuli politici. La ben maggiore rigidità di Napoli non può essere ascritta solo alla forza del carattere della città essa rimanda chiaramente anche alla sua vicenda politica e culturale, e a un contesto in cui tra la socialità aristocratica e quella borghese corre una distanza incolmabile, non tanto di pratiche, quanto di gusto e di interessi distanza aggravata da una circolazione della cultura modesta e lenta. Mariana Starke grande viaggiatrice, autrice di guide tra le più accreditate presso i travellers, dopo un ennesimo soggiorno sul continente tra il maggio 1817 e il giugno 1819, nel descrivere i servizi nelle città europee e italiane registra la presenza di una reading-room solo a Roma, mentre a Napoli trova una piccola biblioteca circolante e un eccellente libraio editore e cartolaio, Angelo Trani, entrambi nei pressi della commerciale e animatissima via Toledo. Solo nel 1837, probabilmente proprio in risposta a una pressione di flussi di forestieri sempre più consistente, anche a Napoli apre un luogo nel quale essi e gli inglesi in particolare, possono trovare e/o consultare libri e stampa periodica estera. L’iniziativa è di Mrs. Flora Lambert Dorant, che nel 1837 apre una British library and reading-room a Palazzo Friozzi alla Riviera di Chiaja, nella zona residenziale più frequentata dai forestieri, di fronte alla Villa Reale affacciata sul mare. Visto il regime di controllo borbonico, non è un caso che la donna sia la moglie del viceconsole inglese William Dorant. Gli ambienti diplomatici consentono, infatti, una qualche circolazione di libri, periodici e pubblicistica stranieri: l’economista Antonio Scialoja che sarà esiliato da Napoli nei mesi della repressione dei moti del 1848 e che diverrà poi senatore del Regno d’Italia riesce a ricevere e a diffondere nel Regno delle Due Sicilie «giornali ed opuscoli liberali e perciò proibiti» solo grazie ai rapporti con l’ambasciata francese. Lo stesso Scialoja denuncia che molti detenuti politici sono colpevoli solo di tenere presso di sé pubblicazioni considerate pericolose. È chiaro che in un tale contesto l’indirizzo di Mrs. Dorant sia particolarmente prezioso per i travellers, e infatti è subito segnalato dalle guide più aggiornate, come quella del Captain Jousiffe, che affianca la reading room napoletana a quella fiorentina, aperta da Giovan Pietro Vieusseux nel 1820, che nel frattempo si è ampliata tanto da essere considerata la più vasta del continente. Per tutta la prima metà dell’Ottocento, dunque, Napoli offre alimento alla continua ridefinizione dei canoni culturali, ma con la sua rigidità politica non lascia spazio e libertà ai propri ospiti di interpretare e dare concretezza alle pratiche sociali più nuove di cui essi stessi sono i maggiori portatori. Ecco allora che, pur continuando a considerare la città come la destinazione di riferimento del proprio viaggio verso il sud, i travellers cominciano a superarla, alla ricerca non tanto e non solo di altre attrazioni da consumare in escursioni giornaliere, quanto di spazi fisici e mentali più liberi. Sulle strade già battute da alcuni grand tourist del secondo Settecento, già dai primissimi anni dell’Ottocento i travellers si spingono verso l’ansa meridionale del golfo. A queste presenze isolate fanno seguito arrivi sempre più numerosi e dagli anni ’40 la spinta centrifuga da Napoli è ormai incanalata su precise direzioni, grazie anche al sensibile miglioramento dei trasporti. Il 1839 è un anno molto celebrato dalla monarchia borbonica perché vede l’apertura del primo tratto ferroviario che da Napoli conduce a Portici, dove la corte napoletana risiede in villeggiatura, animando una strada che significativamente viene chiamata «Miglio d’oro». Da Portici è agevole non solo visitare le antichità di Ercolano e di Pompei, ma anche salire al Vesuvio. Tuttavia i travellers trovano ben più interessante un’altra infrastruttura realizzata nello stesso 1839 la strada che da Castellammare conduce a Sorrento. Quest’opera è, infatti, considerata una delle migliori strade del Regno, giustamente ammirata in Europa come un’importante realizzazione dell’ingegneria italiana, e tempestivamente segnalata negli aggiornamenti delle guide. Nel 1840 Sorrento è dunque definitivamente collegata a Napoli via terra: la ferrovia Napoli-Portici viene prolungata fino a Castellammare, da dove parte l’audace strada, ricavata nella roccia e alta sul mare, che conduce alla penisola sorrentina. Nel giro di pochi anni la pubblicistica specializzata definisce una geografi a del viaggio nella provincia napoletana che va ben oltre la capitale e che è destinata a rimanere valida fino a oggi. Bastano sei giorni per visitarla tutta. «Travellers who are pressed for time can visit the environs of Naples in six days», scrive Captain Jousiffe nel 1840: il primo giorno prevede la visita agli scavi di Ercolano, la salita al Vesuvio e il pernottamento all’Hotel Royal a Castellammare, appena aperto; il secondo è dedicato alla visita degli scavi di Pompei e di lì si prosegue verso Cava, dove si pernotta; il terzo si visita la città di Salerno e i templi di Paestum e si ritorna a Cava a pernottare. Il quarto giorno si ritorna a Castellammare e ci si incammina per Sorrento, sulla nuova e bella strada appena aperta; il quinto ci si imbarca per l’isola Capri e di lì si passa all’isola d’Ischia, dove si pernotta; il sesto giorno ci si imbarca per Pozzuoli e di lì si ritorna a Napoli.


È dunque finalmente possibile spingersi comodamente un po’ più a sud di Napoli e cercare altre prospettive visive e mentali, esplorando comunità e paesaggi. E se i contorni di Napoli vengono raggiunti e visitati sia dagli artisti in escursione sia da coloro che risiedono o visitano Napoli in inverno e in primavera, a partire dagli anni ’40, con una migliore organizzazione della ricettività, queste località diventano residenza di villeggiatura estiva e sempre più spesso vengono scelte per soggiorni terapeutici. Le gerarchie spaziali sono presto definite e non hanno nulla di casuale. I primi a collocarsi a Castellammare sono i segmenti alti dell’apparato dello Stato: impiegati, diplomatici e militari che gravitano intorno alla corte, e che pur avendo un profilo più moderno, si rifanno comunque ai modelli di loisir della vecchia aristocrazia del Regno, rimasta concentrata sul Miglio d’oro di Portici. Altri segmenti borghesi, legati in gran parte al commercio internazionale, così come una certa nobiltà non completamente allineata alla dinastia e sensibile alle istanze liberali, scelgono invece Sorrento e la Penisola Sorrentina. Infine, l’avanguardia eccentrica degli artisti, in gran parte forestieri, si stacca addirittura dalla terraferma e sciama verso Capri. Questi flussi portano nei luoghi in cui si stanziano i loro bisogni, dando vita, negli spazi disponibili, a forme di socialità inedite, specifiche e coerenti con i propri profili culturali, sociali ed economici. In questa sede accenneremo ai casi di Castellammare e di Sorrento, perché entrambe, a differenza di Napoli o di Capri, che vantano una bibliografi a sterminata, non hanno ancora ricevuto la dovuta attenzione dalla storia del turismo. Come cerco di evidenziare che all’epoca del Grand Tour Napoli era una delle mete predilette non solo dai grandi viaggiatori europei ma anche tantissimi pittori alla ricerca di panorami da riprendere, ma soprattutto del sole, del mare e di una luce particolarissima che mutava, ora dopo ora, la prospettiva e la stessa natura delle cose da fissare sulla tela. Nei primi decenni dell’Ottocento la capitale borbonica esercitava una duplice attrazione sugli intellettuali e sugli artisti grazie al fascino dell’incomparabile bellezza del suo golfo ed al fascino di un’antica civiltà riportata alla luce di recente con eccezionale abbondanza di reperti. Ed a riempire di umanità quello spettacolare scenario naturale e quel vetusto emporio di arte, che continuava sorprendentemente a svelarsi giorno dopo giorno, vi era la solare esuberanza dello spirito partenopeo. Da sempre inserita come tappa fondamentale nell’itinerario neoclassico, la città magnetizzò anche l’interesse dei paesisti di ispirazione romantica da Turner a Corot e, aldilà di questi nomi famosi, tutta una pletora di francesi, tedeschi, inglesi, svizzeri ed in generale di nordici, abbacinati dalla potenza della luce. Tra questi, tolto qualche artista inclinato ad un vedutismo documentario da cartolina, tutti si attennero ad una colorata topografia di vaga ascendenza vanvitelliana ovvero ad un paesismo condito di motivi pittoreschi, che riproponevano in termini piuttosto esteriori gli attributi romantici del paesaggismo napoletano settecentesco, derivato dalla lezione di Salvator Rosa e di Micco Spadaro. Da questa folla poliglotta, intenta a rispondere ad una richiesta turistica sempre più pressante, si stacca la figura di Antonio Sminck van Pitloo, un olandese, divenuto napoletano a tutti gli effetti, che insegnò ai locali a dipingere il paesaggio dal vero. Egli fu un abile eclettico e seppe ricondurre verso le categorie del piacevole, dello scenografico e del pittoresco il paesaggio del Turner, del Constable e di Corot, quasi intendesse accordarlo ai paesaggi ellenistici delle case di Ercolano e Pompei. Una riuscita formula di alleggerimento che ebbe molta fortuna e che introdusse a Napoli, con singolare precedenza rispetto agli altri centri italiani, la nozione di importanti fatti europei, contribuendo così a liquidare i ritardatari neoclassici e ad orientare verso una più fresca scioltezza i nuovi intenti romantici. Il Pitloo riuscì a suscitare a Napoli quella particolare atmosfera stilistica, tutt’altro che priva di fascino, che i contemporanei vollero contrassegnare ironicamente con la definizione di Scuola di Posillipo e che influì profondamente sulla formazione del maggior paesista napoletano delle prima metà del secolo: Giacinto Gigante. Anche Degas, prima di dedicarsi anima e corpo ai tutù vaporosi delle ballerine, era stato in città dal 1858 al 1860, mentre nel 1874 giunse all’ombra del Vesuvio Mariano Fortuny, dallo stile leggero e brillante.
Napoli dopo l’Unità d’Italia non fu più una protagonista tra le capitali europee, ma rimase all’avanguardia con le novità artistiche che venivano dall’estero e riuscì ad imporre i suoi pittori anche a Parigi. Si configurò una vera e propria scuola basata su una pittura accattivante e disimpegnata, alla quale si convertirono anche molti artisti, in precedenza famosi per quadri impregnati di crudo verismo o dedicati ad esaltare episodi storici. Con la caduta dei Borbone e l’annessione al nuovo regno monopolizzato dai Savoia, la città si trovò a dovere interpretare un ruolo di provincia e la sua borghesia non si trovò più rappresentata in quei grossi dipinti storico patriottici che adornavano i salotti più eleganti. Il ruolo di ex capitale di un regno con nove milioni di abitanti, in gran parte analfabeti, contrastava con una città dove si stampavano ottanta periodici, vi erano più teatri che a Parigi, l’università annoverava docenti prestigiosi e la nobiltà e la borghesia, colte e cosmopolite, erano la punta di un iceberg che poggiava su una massa di povertà ed ignoranza. I principali pittori: Morelli, Michetti, Migliaro, Dalbono con decine di imitatori e seguaci, spesso anonimi ed imitatori fino al falso dello stile dei maestri, creano una formula di successo, assemblando un verismo superficiale con un’esaltazione del folclore e della tradizione, grondante di pescatori e popolane, immersi in un’atmosfera allegra e spensierata, resa con pennellate vivaci ed una tavolozza smaltata ed iridescente. Non mancano scugnizzi impertinenti ed animali da cortile, a scimmiottare un’Arcadia idilliaca, agognata ma irraggiungibile. Questa pittura sgargiante dai colori luccicanti unì i gusti della nobiltà e del popolino, piaceva agli uni e agli altri, nella stessa misura e negli stessi anni durante i quali la canzone napoletana, prorompente e retorica, raccoglieva applausi da tutte le classi sociali, in Italia ed all’estero. Sono gli anni in cui si sviluppa il mito dell’armonia perduta, l’antica illusione, fallace quanto tenace, che imprigiona da sempre Napoli, propagandata da scrittori ed intellettuali, che attraverso libri e convegni vorrebbero farci credere ad un’Arcadia resa infelice da lazzari ignoranti asserviti alle mire del potere. Questo sogno dai contorni di fiaba è raffigurato con tinte idilliache nei dipinti della Scuola di Posillipo e dell’annacquato verismo di fine Ottocento e questi sono non a caso i quadri ancora presenti a rappresentare una sorta di status symbol nelle case che contano all’ombra del Vesuvio. Ma in verita si tratta di un incubo, che annichilisce ogni speranza di palingenesi della città e la rende incapace di pensare seriamente al suo futuro, in sorprendente coincidenza con un dialetto, assurto a piena dignità di lingua, che esclude questo tempo dalla sua sintassi. L’Eden vagheggiato da artisti e narratori non è mai esistito al di fuori della rappresentazione oleografica ai limiti con l’agiografia, né mai è esistito un popolo in grado stemperare i propri interessi in una visione di bene comune. Vicevera e purtroppo a scandire la storia di Napoli è stato il percorso distaccato di due mondi paralleli: la plebe e l’aristocrazia. Nei secoli entrambi sono cambiati senza cambiare le loro traiettorie divergenti. Napoli paga lo scotto della latitanza di una borghesia imprenditoriale, che sappia investire nella produzione e sappia ridisegnare la propria cultura conservatrice e nello stesso tempo di una classe operaia e lavoratrice, che sia in grado di essere parte attiva in un programma di sviluppo dell’economia. Il risultato nefasto è una civiltà costretta a sopravvivere con l’assistenzialismo statale, con mille truffe e sotterfugi e destinata ad implodere fragorosamente se dovesse realmente realizzarsi un federalismo fiscale. Napoli è da tempo priva di centri decisionale e vede la sua ricchezza concentrata nelle tasche dei ceti professionali o redditieri, dediti per inveterata abitudine all’accumulo infruttifero e non all’investimento, che preferiscono il tranquillo buono postale, che sopperisce agli sperperi di uno Stato inadempiente e parassitario, ai titoli azionari, che fungono da volano delle industrie. Ma soprattutto negli ultimi decenni una smisurata quantità di ricchezza è stata accumulata dalla criminalità organizzata, il cui potere è così notevolmente aumentato, al punto da dettare regole ed essere parte in causa in tutte le più importanti decisioni. Eppure Napoli è stata sempre l’unica città che ha visto convivere, fianco a fianco, nello stesso quartiere e nello stesso palazzo, ricco e povero, signore e plebeo e questa vicinanza urbanistica avrebbe potuto costituire un propellente capace di sprigionare quella carica di energia vitale necessaria al cambiamento. Ma ciò è avvenuto unicamente nella musica, nel teatro e nell’arte, mai nell’economia e nel sociale e per questo che Napoli ed i napoletani continuano a vivere costretti in un opprimente presente senza saper ipotizzare un decente futuro. La pittura di paesaggio conosce, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, un importante sviluppo, imponendosi come genere autonomo e superando la precedente idea di mera pittura di svago e di decorazione. A Napoli, a partire dalla metà degli anni Dieci dell’Ottocento, grazie alla presenza dei pittori stranieri e a una forte scuola locale, si genera una vera e propria rivoluzione. Il paesaggio viene, infatti, dipinto esclusivamente dal vero, superando i confini del solo studio. Il plein air, consapevole e totale,non è più destinato alla fase di mezzo per giungere ai grandi quadri di composizione, ma diviene la vera chiave di svolta, che infine avrebbe condotto al più maturo realismo. Anche l’impegnativo «paesaggio di composizione», inclusivo di un episodio narrativo, storico o d’invenzione, si trasforma fondandosi sulla ripresa dal vero. Con la Scuola di Posillipo si superano il genere vedutistico e la conseguente riproduzione minuziosa della natura,secondo un’idea ancora illuminista di documentazione che pervade il paesaggio europeo del Grand Tour,a favore del sentimento della natura che avrebbe presto condotto alla «macchia». Ad avviare tale rinnovamento fu il pittore olandese Anton Sminck van Pitloo, che si stabilisce a Napoli nel 1816. I supporti privilegiati, per costo e maneggevolezza,sono ora i fogli di carta, in genere applicati in un secondo momento su tavolette e tele, mentre fra le tecniche praticate, oltre all’olio su tela, s’impongono la grafite, il lapis, la china, l’olio su carta, l’acquerello e la tempera, per giungere al completamento del dipinto en plein aire senza ripensamenti, in modo da carpire la mutevolezza della luce. Accanto ai soggetti riprodotti innumerevoli volte, per gli artisti è motivo di studio, e di orgoglio, fissare l’impressione d’inconsueti paesaggi, mostrando una nuova sensibilità e una modernità di visione fuori dal comune. Il 1824 rappresenta l’anno di consacrazione di Pitloo che vince la cattedra di paesaggio alla Reale Accademia di Belle Arti. È questo il periodo in cui gli artisti collaborano alle illustrazioni delle numerose guide che fioriscono in città, come il Viaggio pittorico nel Regno delle Due Sicilie, dato alle stampe fra il 1829 e il 1832. I sovrani non restano indifferenti al fascino di questa rinnovata visione, stringendo legami con alcuni di tali artisti, tra i quali don Giacinto Gigante e Salvatore Fergola. Quest’ultimo creò addirittura un genere nuovo, una sorta di «paesaggio di cronaca», ‘fotografando’ sulla tela le grandi imprese borboniche, come l’inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici, la prima d’Italia. Ma, il più importante interprete della Scuola di Posillipo è stato Giacinto Gigante, che con poche libere macchie d’acquerello o di olio riusciva a fermare l’impressione luminosa della natura. Napoli, Sorrento, le isole del golfo, i Campi Flegrei, divengono attraverso il pennello di Gigante i luoghi della nuova narrazione. I pittori stranieri giunti a Napoli per il Grand Tour – il viaggio intellettuale, quasi iniziatico, alla ricerca della luce, della natura e dell’antico – furono molti. Non si può non menzionare il gallese Thomas Jones, che ha lasciato di Napoli un’immagine fantastica in piccole inquadrature oggi a Londra e a Cardiff, i norvegesi Johan Christian Clausen Dahl e Thomas Fearnley, l’inglese William Collins, il belga Frans Vervloet, i francesi Karl Girardet e Jean-Charles-Joseph Rémond, il russo Sil’vestr Feodosievič Ščedrine tanti altri. Dopo la grande esperienza della Scuola di Posillipo, la riforma della pittura di paesaggio approdò al verismo sostenuto da Filippo Palizzi e infine alla Scuola di Resina, nata all’inizio degli anni Sessanta dal simposio di una cerchia di artisti riuniti nella casa-studio di Marco de Gregorio nella Reggia di Portici. Con lui, lavorarono Giuseppe De Nittis, Federico Rossano, Adriano Cecioni e lo scultore Raffaele Belliazzi, creando un nuovo prototipo pittorico che contemplava la pittura di «macchia». La presenza del catalano Mariano Fortuny a Portici nel 1874 condusse, infine, i napoletani a una pittura luminosissima, fatta di bagliori e di piccoli tocchi di luce, di cui è un esempio il delizioso olio di Rubens Santoro. Una delle figure più importanti fu certamente Anton Sminck Pitlo che a Napoli aggiunse una seconda «o» al cognome probabilmente per sottolineare l’origine straniera per gli artisti napoletani era il signor «Pitloo». Cominciò da ragazzo a studiare disegno e pittura nella natia Arnhem, presso la scuola del pittore acquarellista H.J. van Ameron. Pitloo poté proseguire gli studi prima a Parigi, grazie a una borsa di studio offertagli da Luigi Bonaparte, per poi concludere nel 1811 l’iter accademico a Roma, tappa obbligata di ogni grand tour dove era già presente una folta comunità di artisti connazionali. Dopo la caduta di Bonaparte, Pitloo non poté più beneficiare del sussidio e venne inviato a Napoli presso il conte Gregorio Orloff, diplomatico russo ed estimatore d’arte, che gli offrì una prima ospitalità. Nel frattempo viaggiò instancabilmente, recandosi in Sicilia, in Svizzera e nuovamente a Roma, dove conobbe Giulia Mori, sorella del noto incisore Ferdinando Mori. Si sposarono il 31 dicembre del 1818, nel quartiere Chiaia di Napoli. Egli decise di stabilirsi definitivamente nella città borbonica, in quanto vi riconobbe una committenza ideale e un fecondo stimolo per la sua arte. A Napoli, infatti, Pitloo dipinse quadri dove fornì una personalissima interpretazione del nascente gusto romantico, destinata a essere particolarmente apprezzata dalle nuove generazioni di pittori. Fu per questo motivo che nel 1820 aprì una scuola privata di pittura, attraverso la quale consolidò la propria fama collocandosi come capostipite della scuola di Posillipo. Alla scuola di Posillipo appartennero numerosi pittori, quasi tutti allievi di Pitloo, destinati a diventare fautori di una rinnovata fortuna della pittura di paesaggio: speciale menzione meritano, in tal senso, Giacinto Gigante, Salvatore Fergola, Gabriele Smargiassi, Teodoro Duclère, Achille Vianelli. Nel 1822 Pitloo vide pienamente riconosciuti i suoi meriti quando ricevette la nomina di Professore Onorario presso il Reale Istituto di Belle Arti di Napoli. A testimonianza del suo riconoscimento pittorico, nel 1824 gli venne affidata la cattedra di paesaggio presso la medesima accademia per l’apprezzamento del suo dipinto Il boschetto di Francavilla al Chiatamone, oggi appartenente alle collezioni di palazzo Zevallos. Cominciarono tempi nuovi anche per l’Accademia che troverà in Pitloo un professore attento, puntuale e tutto dedito al lavoro. Tra i suoi allievi il pittore di origine tirolese Jean Grossgasteiger. Pitloo, infine, morì il 22 giugno del 1837, stroncato prematuramente dal colera. Fu sepolto a Napoli, nel cimitero dei Protestanti. Anton Sminck van Pitloo è considerato, fra gli esponenti più sensibili e significativi della cosiddetta «Scuola di Posillipo». La novità ascrivibile a Pitloo sta nell’essersi definitivamente staccato dalla resa del dato puramente veristico ed illustrativo e, generalmente, dalla tradizionale pittura di paesaggio, da lui indirizzata verso sentieri di aggiornata modernità. La tradizione paesaggistica ottocentesca, infatti, mirava ancora a una diretta restituzione del reale, dimostrandosi così ancora condizionata dal carattere analitico e documentaristico delle vedute di Jakob Philipp Hackert. Pitloo, al contrario, abbandona lo zelo indagatore del vedutismo d’impronta classicista e approda a un’osservazione del dato naturalistico decisamente romantica, caratterizzata da una sensibile attenzione alle vibrazioni della luce e dei colori (rese quasi con occhio da impressionista) e dalla presenza di vive suggestioni personali derivanti dall’osservazione diretta dei luoghi. Altra novità introdotta da Pitloo fu l’impiego dell’innovativa tecnica della pittura a olio su carta montata su tela o cartone (la cosiddetta «carta intelata»); questo metodo, già sperimentato in Francia da Corot, fu accolto assai entusiasticamente dai posillipisti e certamente contribuì al rinnovamento in chiave romantica del paesaggismo napoletano, che sino ad allora veniva eseguita a cavalletto. Molto significativa, oltre all’esperienza francese di Corot, è stata l’influenza di William Turner, pittore dal quale prese ispirazione per una libera interpretazione della natura, certamente ha rappresentato per il Pitloo «una nuova via per approfondire il problema della luce senza turbare l’ordine stabilito dalla sua visione naturale». Anche la formazione romana ha fornito uno stimolo sostanziale al Pitloo, che risultò affascinato dagli «irreali tagli di luce e dalle sospese atmosfere dei miti meriggi respirati nella città Eterna», fenomeni atmosferici che «corroborarono la nordica visione descrittiva dell’olandese con un lirismo ottico impetrato attraverso l’aggressione sensoria del colore, avvolge, quasi una macchia corottiana». Posso affermare che Giacinto Gigante è stato un pittore e incisore italiano, conosciuto in particolare per i paesaggi e le vedute, massimo esponente della cosiddetta Scuola di Posillipo. Giacinto Gigante nacque l’11 luglio 1806, primogenito di Gaetano e di Anna Maria Fatati, in una casa della rampa di Sant’Antonio, a Posillipo, Napoli. Fu dal padre Gaetano, anch’egli pittore, che Giacinto ricevette intorno al 1818 la prima educazione artistica, eseguendo già da quell’anno paesaggi e numerosi ritratti, fra i quali un Vecchio pescatore seduto dove, oltre alla firma, troviamo scritto: «questo marinaio fu la prima figura che io feci dal vivo nel 1818». Nel 1820, insieme al pittore Achille Vianelli, Gigante iniziò a frequentare privatamente l’atelier di Jacob Wilhelm Hüber, paesaggista tedesco di stampo accademico che insegnò al giovane allievo l’utilizzo della «camera ottica», o «camera lucida»: con questo strumento, Gigante poteva ricalcare su foglio da disegno il perimetro del paesaggio che intendeva ritrarre, preventivamente tracciato su un lucido. Contestualmente all’alunnato presso Hüber, Gigante fu attivo come disegnatore di mappe nel Reale Officio Topografico. Grazie a questo mestiere, egli poté apprendere i procedimenti dell’acquaforte e della litografia: quest’ultima tecnica, introdotta nelle attività dell’Officio dal 1818, a partire dal 1829 fu particolarmente utilizzata dall’artista che se ne servì per effettuare numerose copie delle sue vedute. Il lavoro che più tenne impegnato Gigante in questi anni fu l’esecuzione della Carta topografica ed idrografica di Napoli e dintorni, grandissima opera, dove l’esigenza di documentare i territori geografici di Napoli e il loro apparato idrologico fu conciliata con la lezione tecnica ricevuta dall’Hüber. Quest’esperienza effettivamente servì molto al Gigante che, dalla seconda metà degli anni dieci applicò questa tecnica nella realizzazione di scorci urbani e monumentali del golfo di Napoli, opportunamente venduti a quei facoltosi turisti stranieri che, di passaggio a Napoli durante il loro Grand Tour, volevano conservare almeno un’immagine di quei luoghi leggendari. Nel segno di van Pitloo Partito il maestro Hüber da Napoli, nel 1821 Gigante completò il suo cursus studiorum, sotto la guida di Anton Sminck van Pitloo, pittore olandese titolare di un fiorente atelier presso il quartiere di Chiaia. Fruendo probabilmente anche del corso di paesaggio dello stesso Pitloo, insegnante presso l’Accademia di belle arti di Napoli, Gigante diede un decisivo impulso alla propria arte, a tal punto da risultare vincitore nel 1824 del premio di seconda classe del paesaggio. Sempre nel 1824 eseguì il suo primo dipinto a olio, il Lago Lucrino, caratterizzato da «un tocco grasso e denso, ora slargato, ora minuto e fitto». Se infatti Hüber servì più che altro a trasmettergli i rudimenti della pittura, Pitloo fu il vero e proprio maestro «spirituale» di Gigante, che in questo modo poté aggiornarsi sulle novità introdotte dalla cosmopolita scena artistica partenopea, animata in quell’epoca da numerosi pittori stranieri, come William Turner e Johan Christian Dahl. Caratteristiche affini ai dipinti di Gigante di quegli anni avrebbero avuto le opere degli altri allievi di Pitloo, aggregati nella cosiddetta «scuola di Posillipo», che ebbe proprio in Gigante uno dei rappresentanti più riconosciuti. Nel frattempo Gigante non trascurò affatto i piaceri amorosi, tanto che ben presto si invaghì di Eloisa Vianelli, sorella dell’amico Achille. Le nozze con Eloisa, celebrate il 1º febbraio 1831, si sarebbero rivelate molto felici e furono coronate dalla nascita di otto figlie, che si sarebbero imparentate con le famiglie di altrettanti posillipisti: Silvia e Marianna si unirono a Ferdinando e Giovanni Zezon, rispettivamente nipote e figlio del pittore Zezon; Sofia e Laura sposarono i fratelli Mariano e Francesco Fergola, figli di Salvatore; Natalia si maritò con il pittore Pasquale De Luca, mentre Elena convolò a nozze con Augusto Witting, nipote di Teodoro. Tra il 1829 e il 1832 Gigante si diede prevalentemente alla grafica. Ormai i disegni non erano più solo studi preparatori, ma autentici punti d’arrivo per l’artista, che partecipò alla redazione del Viaggio pittorico nel Regno delle Due Sicilie, contribuendovi con litografie originali con Lago Lucrino e Gli avanzi del tempio di Venere a Baia, vedute raffiguranti Pompei, Posillipo, Santa Chiara e interventi vari. In questi anni Gigante strinse anche amicizia con il russo Sil’vestr Feodosievič Ščedrin, grazie al quale entrò nell’orbita dell’ambiente dell’ambasciata russa a Napoli e della facoltosa aristocrazia partenopea, la quale apprezzò molto i suoi dipinti, come testimonia la vasta mole di opere da loro commissionate. Fu anche amico di Floriano Pietrocola e consulente per gli sfondi delle sue figure in costume tradizionale. Nel 1837, morto van Pitloo a causa di un’epidemia di colera, Giacinto Gigante consacrò la propria affermazione sociale, quale maggiore esponente della scuola di Posillipo. Nello stesso anno andò persino ad abitare nella casa del maestro, al n. 11 del vico Vasto a Chiaia, anche se già nel 1844, grazie ai ricavati delle varie committenze russe, poté acquistare una dimora personale alle falde del Vomero, e andarvi ad abitare con la numerosa famiglia. Dopo alcuni viaggi in Sicilia nel 1846, al seguito della zarina Alessandra e a Sorrento (1848) Gigante entrò in contatto con gli ambienti borbonici, ricevendo dalla corte di Ferdinando II di Napoli la commissione di alcuni disegni con vedute di Gaeta. Nel 1851, oltre a ricevere la nomina di professore onorario dell’Accademia di belle arti di Napoli, fu incaricato anche di insegnare l’arte pittorica alle principessine, al seguito delle quali, tra il 1852 e il 1855, visitò Caserta, l’Isola d’Ischia e Gaeta. Nel suo atelier si formò il pittore napoletano Giovanni Giordano Lanza. Una preziosa testimonianza artistica di questi soggiorni, per i quali Gigante fu pure insignito del titolo di cavaliere dell’Ordine di Francesco I, sono la Villa reale a Ischia, il Parco reale di Quisisana, il Casino di caccia nel parco di Caserta, e La Marinella e Napoli dalla via Posillipo. Degli anni 1860 è invece l’acquerello Cappella di San Gennaro al duomo durante il miracolo del sangue, realizzato su commissione del nuovo monarca e inviato nel 1867 all’Esposizione universale di Parigi, dove suscitò i plausi di Pasquale Villari, che con entusiastica deferenza arrivò ad affermare che «Gigante è un acquerellista di cui non si troverebbe in Italia un altro di egual merito». Giacinto Gigante morì a Napoli il 29 novembre 1876. Giacinto Gigante è considerato, al pari del maestro Anton Sminck van Pitloo, uno degli esponenti più sensibili e significativi della scuola di Posillipo. Dopo gli esordi come disegnatore cartografico Gigante si avvicinò infatti alla pittura dell’olandese van Pitloo: fu proprio seguendo la strada tracciata dal maestro che egli contribuì a rinnovare la tradizione della pittura di paesaggio, che sino ad allora risentiva dei moduli compositivi d’ascendenza documentaristica introdotti da Jakob Philipp Hackert. Gigante, al contrario, non fu deferente a una ripresa rigorosamente realistica del dato naturalistico, bensì si mostrò più attento alla componente emozionale dell’immagine, caricata di vive suggestioni personali dovute all’osservazione en plein air. Pur nel sostanziale rigore di rappresentazione, Gigante coglie il paesaggio per mezzo di estatici abbandoni e di vivide ricerche atmosferiche, lasciando così trasparire un intenso sentimento di intimismo lirico che è in pieno accordo con la categoria estetica del pittoresco. I campi visivi adottati da Gigante, in particolare, non sono mai ampi bensì abbracciano sempre prospettive ristrette a piccoli spazi, descritte con taglio quasi fotografico. I suoi quadri, inoltre, sono animati da una grande intimità, dovuta alla scelta di raffigurare paesaggi con persone che compiono azioni quotidiane, quasi banali: è in questo modo che l’acuta indagine pittorica di Gigante, riuscendo a porre eguale attenzione all’affettuosa quotidianità del soggetto e al fresco naturalismo della rappresentazione, tradisce una visione della realtà calma, contemplativa, persino malinconica. Tra i suoi soggetti preferiti, in particolare, si menzionano l’assolata campagna flegrea, la lussureggiante costiera sorrentina e le isole di Capri, Ischia e Procida, con i loro incanti cromatici. Gigante recepì stimoli cruciali specialmente dalla pittura dell’inglese William Turner, dal quale prese spunto per le modalità d’utilizzo dell’acquarello e per le sue innumerevoli potenzialità creative, esaltate specialmente in tele come Porto Salvo e nella verdeggiante natura del Paesaggio sorrentino (1850). Impulsi analoghi furono desunti dalla suadente duttilità della luce mediterranea, sapientemente plasmata nella Tempesta sul golfo di Amalfi, dove un raggio di sole riesce a squarciare le nubi e a illuminare uno spicchio di mare della costiera Amalfitana, restituendo un’impressione di piacevole dolcezza, nonostante il mare in burrasca: «La sua è una sintesi poetica di forme, colore, luce e rapporti spaziali evocatrice del ritmo della visione in una lettura sentimentale del paesaggio che ne amplifica la suggestione: ecco quindi stagliarsi sullo sfondo quella massa scura di Capo d’Orso battuto dalla pioggia quando alcuni raggi irrorano di luce le vecchie case del borgo antico ripreso dal belvedere del convento dei Cappuccini mentre fra i marosi una barca a vela tenta faticosamente di approdare a riva» (Luigi Gallo, Nunzio Giustozzi parlando della Tempesta sul golfo di Amalfi) Particolarmente innovativo è anche il Tramonto a Caserta, dove la spregiudicatezza della tecnica pittorica con cui Gigante impiega il colore prelude ai successivi indirizzi dell’arte impressionista, orientata verso rappresentazioni di puro colore. Mentre Salvatore Fergola è stato un pittore italiano, considerato uno degli esponenti più autorevoli della scuola di Posillipo. Era figlio di Luigi e di Teresa Conti. Da giovane studiò lettere e architettura, per poi accostarsi agli studi pittorici, sull’esempio del padre che, come ci riporta Maria Causa Picone, era un «pedissequo hackertiano legato ad una minuziosa micrografia che non esclude, tuttavia, una vena felice di acquerellista». Nelle sue prime esperienze pittoriche infatti, Salvatore Fergola si mostrò enormemente debitore a Jakob Philipp Hackert, sia nell’applicazione della tempera, sia nell’impostazione della veduta.Anche suo fratello Alessandro Fergola è stato pittore. Ammesso come allievo all’Ufficio Topografico di Napoli, riscosse immediato successo presso la Corte borbonica, fin dalle prime opereː questo gli frutterà nel tempo numerose committenze dai Borbone di Napoli. Nel 1819 Fergola eseguì diversi dipinti, a Napoli, per conto del duca di Calabria,per poi essere chiamato dal duca di Sicilia. Dopo aver ottenuto uno stipendio di trenta ducati mensili dai Borbone, seguì la Corte a Castellammare di Stabia, per eseguire vedute del golfo di Napoli. Successivamente si recò a Caserta, a San Leucio, a Santa Maria Capua Vetere e ad Ischia, dove si trattenne per tre mesi. Le sue peregrinazioni lo portarono nel 1823 in Sicilia, con il proposito di fare il giro dell’isola anche se, ammalatosi a Trapani, decise di far ritorno ad Ischia e poi nuovamente a Castellammare. Un visitatore in osservazione di un suo dipinto raffigurante il selvaggio e misterioso profilo delle coste di Capri, in esposizione alla mostra Salvatore Fergola. Lo splendore di un Regno a palazzo Zevallos a Napoli Dopo il 1820 frequentò la scuola privata di pittura di Anton Sminck van Pitloo e, con il maestro ed altri allievi, fu tra i componenti della cosiddetta Scuola di Posillipo. Nel 1824 seguì i reali a Foggia e alla Reale tenuta di Carditello – dove ritrasse una corsa di cavalli – per poi spingersi sino ad Arienzo, per documentare i costumi della Terra di Lavoro e a Paestum. Nel 1829 si recò in Spagna, al seguito della famiglia borbonica, in occasione delle nozze, a Madrid, della principessa Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie con il re Ferdinando VII di Spagna. Fergola ebbe l’opportunità di visitare Siviglia, Cadice, Burgos, Toledo e Barcellona. Sulla via del ritorno si trattenne qualche mese a Parigi, ospite del duca d’Orléans, Luigi Filippo di Francia e di Carolina di Borbone-Due Sicilie, duchessa di Berry: in occasione di questo soggiorno francese Fergola avrebbe recepito nuovi stimoli per il suo stile pittorico. Nonostante la popolarità, come illustratore degli avvenimenti di Corte e degli eventi più significativi del Regno, Fergola non riuscì a diventare titolare della cattedra di paesaggio dell’Accademia di belle arti di Napoli, perché nel 1838 questa cattedra venne assegnata a Gabriele Smargiassi. In questi anni lavorò instancabilmente, partecipando nel 1839 alla mostra borbonica, con Veduta della sorgente del Sarno, Interno della cattedrale di Toledo in Ispagna, Briganti sorpresi dalla gendarmeria nella foresta e tre «paesaggi di composizione», raffiguranti albe e tramonti. Nel 1841 presentò Interno gotico del chiostro di San Giovanni de’ Re a Toledo, Esterno gotico della cattedrale di Burgos, Montevergine nel giorno della festa e Inaugurazione della strada di ferro seguita in Napoli nell’ottobre del 1839. Nel 1843 espose Marina di Capri al chiaro di luna con battello in cui dorme un marinaro e Un sifone nel golfo di Procida, mentre del 1848 è Preghiera della sera. Morì nel 1874, all’età di 76 anni. Alla Galleria dell’Accademia di belle arti di Napoli si conserva il dipinto di Fergola, conosciuto con doppio titoloː Bacio di Giuda e Cristo nell’orto. Datato 1858, è un olio su tela, della dimensione di 89×70 cm e fu acquistato dall’Accademia nel 1909. Mentre Salvatore Fergola fu esponente di spicco della scuola di Posillipo, è stato un protagonista della pittura a Napoli, negli anni della Restaurazione, epoca in cui l’antica città partenopea iniziava a trasformarsi in una grande e moderna metropoli. Dopo il congresso di Vienna, infatti, nel Sud Italia venne restaurata la monarchia legittima dei Borbone, che promosse un aggiornamento tecnologico, destinato a stabilire nel Regno delle Due Sicilie numerosi primati per l’Italia.
Fergola è stato un grande interprete pittorico di questo fervore tecnologico e dipinse opere che rivelano fiducia nelle nuove istanze di progresso e modernità. Tra i dipinti di Salvatore Fergola merita una menzione speciale Inaugurazione della strada ferrata NapoliPortici, 1840, dove è rappresentata la ferrovia Napoli-Portici – con un treno che corre lungo la linea di costa il panorama del golfo di Napoli sullo sfondo e la festosa presenza del pubblico, individuato nei diversi ceti. I primi dipinti di Fergola erano ancora saldamente legati ai moduli compositivi d’ascendenza analitica, introdotti da Jakob Philipp Hackert. Nella sua prima fase artistica, infatti, Fergola eseguiva principalmente opere dal valore documentario e celebrativo, dove le caratteristiche botaniche e morfologiche del territorio effigiato erano rese con un naturalismo di matrice illuminista. Nella successiva pittura di Fergola si registra una decisiva virata, in direzione del Romanticismo. Nei dipinti appartenenti a questa fase, pur applicando un sostanziale rigore nella rappresentazione, Fergola approdava ad una visione più fantastica della realtà e lasciava trasfigurare un sentimento di intimismo lirico, di sapore romantico. Quest’approccio, certamente più congeniale alla sua volontà di esaltare le bellezze naturalistiche del golfo di Napoli, gli derivò dalla visione delle opere di Horace Vernet e di Théodore Gudin, che poté ammirare a Parigi del 1830. Un’epitome di questo nuovo indirizzo stilistico si può rintracciare nel fortunato repertorio delle marine in tempesta, dove il pittore, pur rappresentando episodi di naufragio realmente accaduti, impiega un registro fantastico che dà ampio spazio alla dimensione eroica del sublime, in pieno accordo con la sensibilità romantica. Un rilievo significativo ricopre nella mostra la figura di Edgar Degas, un artista che ha sempre rivendicato la sua appartenenza al movimento realista rifiutando l’etichetta di impressionista come qualificativo della sua pittura. Di origini napoletane per parte paterna, Degas,che parlava correntemente la lingua napoletana imparata durante la sua infanzia e giovinezza a Napoli, è considerato in questa mostra dal punto di vista della sua familiarità con l’ambiente napoletano, ipotizzando che, questa particolarità, sia un tassello di lettura in più per capire la sua differenza con la scuola francese. Proprio a Napoli dove trascorse soggiorni fondamentali per la sua formazione poté arricchire di un senso nuovo la sua particolare formula realista. Particolarmente importante, per questo, è il focus dedicato in mostra all’artista francese. Posso dire che giovanissimo Degas si affaccia alla vita l’arte in Francia sta cambiando volto . Dagli anni trenta si nota un lento ma costante processo di allontanamento dagli schemi promossi dalla scuola di Belle Arti, l’istituzione che a Parigi era il corrispondente dell’Accademia di Belle Arti in Italia, e una altrettanto costante crescita di libertà espressiva nello stile e nei soggetti. La regola classicista, in vigore anche nell’Accademia Reale di Belle Arti di Napoli, secondo cui il “bel disegno” deve costruire l’opera e certificare la precisione riproduttiva, comincia a essere sentita vuota di senso e non corrispondente alla funzione dell’arte, che ora taluni coraggiosi propongono come mezzo di rappresentazione cromatica della verosimiglianza oggettiva. Un momento di crisi istituzionale si ha in occasione del Salon l’esposizione organizzata periodicamente dalle Belle Arti del 1824, cui partecipano anche paesaggisti innovatori come l’inglese John Constable, promotore di una tecnica più rispettosa del dato naturale. All’avanguardia si collocano i pittori della scuola di Barbizon dal nome del villaggio ai margini della foresta di Fontainebleau che praticano la pittura all’aria aperta, metodo fino ad allora usato per abbozzare il lavoro. Tra il 1830 e il 1840 si afferma in Francia il positivismo, che investe i vari campi del sapere e dell’espressione artistica, introducendo in letteratura e nelle arti figurative la nuova estetica del realismo: l’arte si volge al dato reale, al fenomeno osservabile, privilegiando l’ambiente contemporaneo . I giovani pittori che aderiranno all’ Impressionismo appartengono per la maggior parte alla buona borghesia. Nati fra il 1830 e il 1841 nella capitale, o qui trasferitisi in giovane età si incontrano all’Ecole des Beaux – Arts e insieme si recano al Louvre per copiarne i capolavori. Sono di casa al Louvre soprattutto Manet, Degas e la Morisot. Prima di Barbizon e degli impressionisti, il primato indiscusso è appartenuto alla pittura di soggetto storico o mitologico sancito dall’arte ufficiale delle accademie. Tutto questo viene messo in discussione, attaccato e posto definitivamente in crisi da Gustave Courbet (“ èleve de la nature “ come ama definirsi ), con la sua fede nel realismo e la sua vocazione ideologica, di concerto con letterati quali Baudelaire, Champfleury e Proudhon. E’ ancora fresco il ricordo del Pavillon du Realism allestito dall’artista all’esterno dell’esposizione universale, in aperta polemica con opere quali “l’atelier del pittore” e “Funerale a Ornans”.Nello stesso tempo, Corot- altro grande maestro per i futuri impressionisti, tanto da spingere Pissarro a firmarsi anche “allievo di Corot “ scrive nel suo carnet: – “ Il bello dell’arte è la verità bagnata nell’impressione che abbiamo ricevuto di fronte alla natura”. Com’è Parigi nella prima metà dell’800 ? E’ una città che si avvia a diventare metropoli, governata da Napoleone III, nipote di Bonaparte, eletto prima presidente della seconda repubblica e poi, con il colpo di stato del 2 dicembre 1852, proclamato imperatore. L’anno seguente Napoleone III chiama alla prefettura della Senna il barone Georges – Eugène Haussmann, e lo incarica di trasformare in moderna metropoli la capitale che ancora ha molto del volto medievale, in più è afflitta da lacerazioni sociali, focolai di ribellioni , epidemie i moti del ’30, il colera del ’32 . Così, Haussman ha mano libera per reinventare- con l’aiuto di ingegneri, preferiti agli architetti- lo scacchiere urbanistico, attraverso la spettacolare rete dei” boulevards”: ampi viali sistemati secondo arditi giochi prospettici, spesso congiungendosi a “ V “, accompagnati dal verde degli alberi, su cui si affacciano caffè, ristoranti, negozi, eleganti appartamenti signorili le “maison rapport”, le case a più piani . L’Opèra, progettata dall’ingegnere Garnier, viene concepita come parte integrante di tale complesso; perno di tutto il sistema è l’Ile de la Citè, completamente trasformata. I “grand travaux” comprendono anche l’immensa ricostruzione fognaria. I boulevard, che mettono in comunicazione diretta il centro e la periferia, facilitano inoltre i movimenti di materiali e manodopera necessari alla nuova rete ferroviaria, gia in costruzione dal 1840.Parigi pian piano si va trasformando nella “ Ville Lumière”.Tale si presenta più tardi all’Esposizione Universale dell’89 con la prima illuminazione pubblica a gas esistente , in occasione della quale viene eretta la Tour Eiffel. Intanto dal 1876 si sta costruendo la chiesa del Sacrè-Coeur edificio al centro di tutto un quartiere spesso frequentato dagli impressionisti, Montmartre .Molto diversa risulta la situazione napoletana di inizio Ottocento, questa differenza è dovuta in parte alla situazione storico-politica di grave deficit finanziario, eterno problema del regno di Francesco I . Nel 1821 le truppe austriache stanziano a Napoli, solo nel 1827 il Re ne ottiene il ritiro. Il loro mantenimento ha inciso in modo notevole sul bilancio statale. Dopo la partenza degli austriaci la sicurezza del regno resta affidata all’esercito napoletano del quale Francesco I, per quanto ha visto nel passato, non può fare sicuro affidamento per cui tratta l’arruolamento di regimi svizzeri mercenari. Dopo i disastrosi moti del 1820 qualche fiammata di libertà si accende di tanto in tanto nel regno ma sono guizzi sporadici e isolati, subito repressi, come quello del 1828 nel comune di Bosco, in provincia di Salerno. Qui il canonico De Luca solleva la popolazione chiedendo la Costituzione ma il moto viene subito soffocato e il castigo terribile, non si fa attendere: il comune viene bruciato e 26 persone, tra le quali il canonico De Luca, vengono mandate al supplizio. Durante il regno di Francesco I di Borbone Napoli, benché politicamente statica, progredisce, sia pure di poco, nel campo industriale. Diverse aziende aumentano la loro attività ed altre, anche se non di grande struttura vengono impiantate. C’è una buona produzione di lana, seta e cotone, la crescita di fonderie, stamperie, concerie, tintorie, fabbriche di saponi, di candele, di cappelli, di mobili e altre piccole industrie. Non è un gran che per il regno di Napoli che ha bisogno di una radicale ristruttura economica per risanare le rovinose finanze, eppure nonostante la situazione non rosea Napoli può vantare due primati: la prima nave a vapore, la “ Ferdinando I”, salpata il 27 settembre 1818 per il viaggio inaugurale Napoli – Genova, la prima compagnia di navigazione del Mediterraneo, fondata nel 1823 con il nome di Società Napoletana delle Due Sicilie. Per quanto riguarda la situazione delle Arti non ci sono più i vividi ingegni del secolo precedente, perché agli esuli del 1799 si sono aggiunti quelli dei moti del 1820, si può dire solo di Anton Pitloo, pittore di origine olandese iniziatore della “scuola di Posillipo” e di Giacinto Gigante, continuatore della suddetta scuola ma prettamente napoletano, che è da annoverare tra i maggiori paesaggisti moderni. Le regie scuole del Disegno sono state migliorate nei riguardi dell’inquadramento dei docenti e nella coordinazione degli insegnamenti, arricchite di specializzazioni e rette da norme didattiche ed amministrative, codificate razionalmente, ciò a partire dal 1815-1816 circa. Dal 1820 si vagheggia una riforma e un rinnovamento delle arti senza aver nulla di fatto concretato. Nel 1822 le Regie Scuole del Disegno sono unificate sotto un’ unica denominazione, nasce così la Reale Accademia delle Arti. Analogamente nello stesso anno viene varata una riforma approvata con R.D. 2 marzo 1822, resterà in vigore, con lievi modificazioni, per circa un quarantennio. La fotografia, si afferma in pochi decenni come la più popolare tra le arti visive del secolo. Nel 1849, appena dieci anni dopo l’invenzione di Daguerre, già centomila stampe fotografiche sono state vendute nella sola Parigi, e il pessimistico commento fatto nel 1850 dal pittore accademico Paul Delaroche “ da oggi la pittura è morta “, sembra a molti un giusto pronostico. Fra le prime vittime vi sono i pittori specializzati in ritratti in miniatura, che scompaiono dalla scena artistica fino a che, all’inizio del nuovo secolo, l’eccessiva popolarità dei ritratti fotografici non è tale da riportarli nuovamente alla ribalta. Ma la fotografia ha ormai sollevato l’arte da uno dei suoi compiti più limitanti, quello della pura riproduzione. Ora che il realismo è assicurato dall’apparecchio fotografico, che non mente nel documentare persone e luoghi, i pittori possono perseguire i loro scopi personali – come fanno gli impressionisti – con una nuova libertà .E per questo utilizzano anche la stessa fotografia. Se Degas ne fa un ampio e dichiarato uso, anche Corot, Bazille, Monet e Cezanne se ne servono spesso seppure sono riluttanti ad ammetterlo. La macchina fotografica influisce a vari livelli sul modo di guardare le cose. Degas parla della sua “ magica istantaneità “, qualità avvalorata dall’introduzione nel 1880 della prima macchina istantanea della Kodak.Anche Zola ne è un particolare estimatore e ne possiede una. Il funerale a Ornans di Courbet viene criticato per la sua somiglianza a un “ dagherrotipo sbagliato “, mentre l’atelier riproduce la posa di molte foto di nudi diffuse a Parigi in quegli anni. Gli effetti determinati dalla fotografia sulla generale sensibilità visiva dell’epoca, in particolare su quella impressionista, vanno ben al di là dell’uso che ne fanno i singoli artisti. Nonostante i progressi nelle tecniche dell’incisione, fino all’avvento della fotografia e poi della mezzatinta che permette alle immagini fotografiche di essere riprodotte in serie in giornali e riviste, nessuno ha un’idea precisa dell’aspetto della gente e dei luoghi che esulano dalla diretta esperienza personale. La fotografia produce una nuova consapevolezza visiva e un certo scetticismo sulle immagini idealizzate dell’arte accademica. Chi ha visto, per esempio, le foto di nudo di Julien Villeneuve non può più dare lo stesso valore ai nudi di Bouguereau, comincia seppure riluttante a chiedere ai pittori qualcosa di quel realismo che è dichiarata intenzione degli impressionisti esprimere. Ma la fotografia da anche un più specifico contributo operativo. Prima della sua invenzione, le opere d’arte del passato o di un diverso ambito geografico sono conosciute solo attraverso incisioni di livello più o meno buono. Tutto cambia con l’avvento di ditte specializzate, come gli Alinari di Firenze , che offrono eccellenti stampe fotografiche in bianco e nero di pitture e monumenti, ampliando così notevolmente la conoscenza dell’arte. In Francia il ruolo degli Alinari viene svolto da Adolphe Braun , che ottiene l’esclusiva per riprodurre i quadri del Louvre, fotografa anche l’arte contemporanea, scegliendo generalmente fra le opere ammesse al Salon. Alla fine del secolo dispone di novemila foto di opere moderne, fra cui molte di Millet, Corot, Puvis de Chavannes, una di Manet, due di Monet e cinque di Degas . Degas prima di servirsi della fotografia per i suoi dipinti, possedendo egli stesso un apparecchio fotografico di cui va particolarmente fiero, conosce attraverso Felix Braquemond incisore ,le stampe giapponesi , introdotte dallo stesso a Parigi nel 1856. Queste gli sono di grande impulso per l’elaborazione di uno spazio figurativo non convenzionale, sganciato dalla prospettiva centrale della tradizione pittorica occidentale. Degas si serve della neonata fotografia prima attraverso il dagherrotipo poi attraverso l’istantanea . In particolare si interessa agli studi fotografici sui cavalli in corsa realizzati da Eadweard Muybridge,traendone spunti per le sue celebri composizioni dedicate agli ippodromi. Sperimenta lui stesso la fotografia,sulla quale talvolta interviene direttamente, sovrapponendo la pittura all’immagine. L’originale taglio che Degas costituisce per molti dei suoi dipinti, rivela l’intenzione di offrire un’immagine istantanea della realtà, libera da schemi razionali, siano essi estetici o narrativi. L’immagine si presenta come una visione casuale, in cui le figure e le cose si distribuiscono nello spazio senza un’ordinata composizione prospettica o simmetrica. Tale scelta è evidente in alcuni dipinti degli anni settanta, come l’Orchestra all’Opèra del 1869, dove l’inquadratura ravvicinata della scena taglia la figura all’estrema destra e addirittura le teste delle ballerine sullo sfondo. La fotografia rappresenta il terzo occhio di Degas, infatti la competenza del pittore inizia dove comincia la “ visione “. Ma ciò che vede è in diretta dipendenza da “ come si vede “, e quest’ultimo è il risultato sia di un progetto che di un fenomeno contingente. Tuttavia perfino la casualità può essere attesa e perseguita: tutto consiste nel volerla o meno assumere come dato di conoscenza del mondo, come termine che contribuisce alla sua immagine o invece ne disturba i contorni. Mettere insieme la “ totalità “ antica con la “frammentarietà” moderna è stato uno dei ruoli che Degas ha imposto al proprio lavoro. In un simile contesto non può rimanere ai margini la tecnica fotografica, che si propone alla ribalta con la forza e l’invadenza delle tecnologie più avanzate. Per di più essa amplia la visione, ne entra a far parte con la sua specificità, ne propone uno sviluppo parallelo e allo stesso tempo diverso da quello dei linguaggi tradizionali. E’ perfino inutile soffermarsi sul fatto che Degas è in ogni caso ben conscio della prassi operativa fotografica e del funzionamento dell’obiettivo. Un dipinto come Giovanna e Giulia Bellelli del 1865, è significativo proprio in rapporto a quest’ultimo argomento: Giovanna appare infatti nel “fuoco” della lente, mentre Giulia si offre ad un campo sfuocato che la trasporta in uno stato di presenza assenza, impreciso e svaporato. La nuova musa è per lui un modo di vedere e come tale va sperimentata. Non smette di “perseguitarla”, almeno fino alla metà degli anni Ottanta. Nella storia della fotografia Degas occupa una posizione centrale: non fosse altro perché, mentre gli strumenti avanzano verso un uso facile e meccanico, è il primo ad ammonire di non perdere le origini, di esaminare il mezzo nella sua specificità, di essere fotografi-fotografi e non fotografi –pittori, di lavorare sulla struttura della tecnica ricavando da lì le origini dell’opera. O meglio ancora, saprà estrarre dalla tecnica il linguaggio. Lo sguardo di Zoè Closier alle spalle di un Degas assorto in una riflessione che si prolunga fuori campo, il ritratto di Mallarmè e Renoir, Louise sognante, la danza di luce e nella luce della danseuse del corpo di ballo e le altre immagini dell’itinerario della maturità di Degas sono una riconferma che il suo “terzo occhio” è costruito per sottrarre l’effimero alla dispersione , essendo nato per veder coincidere nella specificità dei materiali e delle tecniche creative ciò che sta al di qua e al di là dello sguardo stesso. E ciò vale sia per la pittura, sia per la scultura e la fotografia . Il ruolo della fotografia nella cultura napoletana, non appare sicuramente secondario alla Francia infatti sin dalla sua comparsa sulla scena europea ci si rende conto della svolta che si sta realizzando nei percorsi formativi degli artisti europei già a partire dal 1855. In questa data Paul Nibelle critico francese scrive una recensione sulla rivista “La Lumière” a proposito dell’Esposizione Universale di Parigi che si tiene lo stesso anno. Nibelle conclude con la diagnosi di un mondo che per effetto dell’industrializzazione sta cambiando e auspica un ritorno, magari per stanchezza alle bellezze della natura che da sempre hanno ispirato l’arte. In effetti la sua diagnosi non è poi così peregrina. Ad attirare sempre più gli artisti è il ruolo di Parigi in quanto metropoli moderna, connesse a questo ruolo, tutte le diavolerie della moderna società industriale, compresi gli apparati tecnici del settore grafico, la fotografia, le novità delle arti applicate in generale e il tempio dove tutto questo si può ammirare, ossia le Esposizioni Universali. Così, si verifica tutto ciò che Nibelle ha constatato: dall’Italia partono precocemente i segnali di artisti e scienziati che desiderano aggiornarsi sui modelli francesi, mentre contemporaneamente, dalla Francia soprattutto i fotografi scendono in Italia per incamerare nel proprio repertorio quelle immagini di antica tradizione , famose fino a diventare in taluni casi stereotipi, del patrimonio artistico e paesaggistico italiano , segnatamente meridionale. Tra i fotografi di mezza Europa continua a persistere il mito dell’Italia come meta del Grand Tour e fra le tappe italiane più significative Napoli riveste un ruolo principale. Alcuni viaggiatori fotografi documentano le aree archeologiche, gli oggetti d’arte e i monumenti della città. Altri si stabiliscono a Napoli impiantandovi il loro atelier e i propri uffici commerciali. Notevole è l’interesse che manifestano nei confronti della fotografia gli artisti napoletani. Gli scambi tra arte e fotografia nel corso dell’Ottocento sono fittissimi. La fotografia dei professionisti risente di schemi visivi diffusi da incisori e pittori, viene presa ad esempio per Napoli, la famosissima immagine del golfo presa da Posillipo con la quinta laterale del pino che passa pressoché inalterata dalle incisioni del primo Ottocento ai pittori della scuola di Posillipo al repertorio fotografico di molte ditte napoletane, fino alle cartoline. Artisti che utilizzano il mezzo fotografico lasciandosene influenzare sono Celentano, Palizzi, Morelli,Cammarano. Dai loro epistolari apprendiamo che fra di loro c’è un giro vorticoso di immagini fotografiche relative alla loro produzione: sono scambi con altri artisti di foto con dediche della propria città, come ricordo affettuoso oppure al fine di ottenere un parere, un giudizio o ancora con la speranza di una mediazione mercantile. Si sono accertati scambi in tal senso con Mosè Bianchi , gli Induno e i Macchiaioli. Morelli e Celentano cercano di procurarsi foto “ a qualunque prezzo” di dipinti soprattutto stranieri per studiarli, desiderano la riproduzione della Santa Cecilia portata al sepolcro di Bouguereau, di cui ha parlato loro Vertunni e danno l’incarico a Caneva noto pittore e fotografo romano, di eseguirla. Senza dubbio l’uso più interessante che costoro fanno della fotografia è quello in relazione diretta con la loro produzione pittorica e scultorea. Non è facile accertare con sicurezza il ricorso all’immagine fotografica all’interno del processo creativo, anche per la ritrosia di molti artisti ad ammetterlo; tuttavia alcune testimonianze inequivocabili ci sono. La più antica riguarda l’uso da parte di Filippo Palizzi del cliché verre , una tecnica eliotipica a metà fra l’incisione e la fotografia , appresa in Francia nell’ambiente della scuola di Barbizon durante il suo primo viaggio nel 1855. Insieme al fratello Giuseppe stringe amicizia con Nadar, come risulta da alcune sue lettere conservate nei suoi manoscritti. Per Bernardo Celentano la fotografia costituisce una tappa nella costruzione dell’opera, con un ruolo simile a quello svolto dallo schizzo preparatorio, dallo studio di un particolare o ancora dallo studio delle luci. Nel 1870 nelle memorie dell’ormai anziano scultore Tito Angelini leggiamo una vera e propria esaltazione del mezzo fotografico. Questa memoria viene letta presso la Reale Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti, in cui rivela senza ritrosie il suo personale uso di questo ausilio ed i vantaggi che ne derivano allo scultore: “Benché l’artista parla sempre meglio dell’arte propria, che delle arti sorelle, io dirò nondimeno, come dalla fotografia traessi vantaggio, perché nella statuaria grandemente mi sono giovato, e mi giovo della fotografia, cercherò di dimostrare, come con fotografie tratte da diversi punti d’una stessa figura, o d’un medesimo ritratto, io abbia potuto raggiungere la somiglianza, per modo che meglio non avrei potuto, se ne avessi tenuto lungamente a modello il vivente originale. La fotografia dà la sicurezza del contorno, perché vi presenta quello della natura stessa. Inoltre la spontanea movenza, e quella spigliata verità dei capelli, che secondo l’età si veggono più o meno morbidi allo sguardo del ritraente, non si possono ottenere modellando dal vero, dal perché in quelle poche ore, che si concedono alle sedute, onde ritrarre il busto di una persona, l’artista è ragionevolmente più intento a rendere l’insieme, che i particolari delle pieghe, dei capelli, e di quanto infine riguarda gli accessori,che formar debbono un armonico complesso. L’artista finisce così per eseguire la cosa più difficile in arte, vale a dire i capelli,intagliandoli quasi sempre come di pratica: per modo che nella scultura di una epoca non lontana si veggono resi i capelli d’un vecchio nel modo stesso di quelli d’un giovane, e i capelli bianchi figurati come i neri, senza por mente, che il colore anche nella scultura si ravvisa per mezzo del delicato tocco dello scalpello, e per la diversità della intelligente esecuzione” . Per De Nittis la fotografia al pari di Degas, è uno stimolo ad ammodernare il taglio della composizione, per Michetti dopo essere stata alleata della pittura e soprattutto nella documentazione di eventi folklorici da lui osservati- comincia a costituire un’alternativa. Questo si verifica quando viene meno la fiducia nelle possibilità comunicative della pittura all’interno di un discorso realistico. E’ proprio la fotografia, a dispetto della sua fama di strumento mimetico per eccellenza, ad indicare la via verso una frammentazione ed un’analisi quasi ossessiva della realtà fino ai limiti dell’astrazione .Le origini della famiglia De Gas risalgono al 1500. Il nome De Gas si rintraccia in antichi documenti in “De Gast”,”De Guast”, “De Gas”; dopo la Rivoluzione Francese viene riunito in” Degas” come sempre l’ha utilizzato Edgar. La sua famiglia è originaria della bassa Langue D’oc, della città di Bagnols. I De Gas erano proprietari terrieri e signori proprio di questa città con il soprannome De Gast de Bagnols, che resterà soprattutto al ramo cadetto di questa famiglia. Questo si trasferisce agli inizi del Cinquecento nella città di Orlèans dove un antenato di Edgar , Gabriel de Gast insegna giurisprudenza all’università. Già a partire dal 1576 i De Gast solevano riunire il cognome in una sola parola Degast come risulta da un’iscrizione latina:- “Gabrielis Degast Antecessoris Aurelii commentari in Duos Tit.- De impuberum et aliis substitutionibus-De sententiis quae pro eo quod interest proferentur”. Sotto il regno di Luigi XIV, quando dallo stesso monarca è istituito l’obbligo di registrazione di tutte le famiglie nobili, i De Gas si mettono in regola. La famiglia De Gas mantiene così il suo antico ceppo nobiliare, registrato l’8 novembre 1670 presso la diocesi d’Uzès città del dipartimento di Gard, è riportata nel Catalogo dei Gentiluomini della provincia della Langue D’oc, il cui originale si trova nell’archivio di Montpellier. Altri antenati di Edgar, un canonico della cattedrale d’Uzès, Paul De Gas, un capitano del reggimento d’ Ornac,Giuseppe De Gas, fanno registrare le armi di famiglia nell’”Armorial Gènèrale” de l’annèe 1696, nel “ Règistre de la Gènèralitè de Montpellier” al foglio 537. Il simbolo araldico della famiglia De Gas è un istrice sovrapposto alle armi di famiglia al centro di uno scudo, rappresenta l’antico ordine cavalleresco dei duchi d’Orlèans. Ciò sta a dimostrare gli stretti rapporti dei De Gas con il casato degli Orlèans. Questo spiega perché nel 1730 i discendenti di Gabriel, Seigneur De St. Gervaise,lasciano la Langue D’oc per l’Orlèans. I De Gas, nobili e cavalieri si dedicano come tutti i loro concittadini alla vita sociale e culturale del tempo, non restano inoperosi, si occupano di economia e finanza dando origine ai primi istituti di credito. E’ questa nuova attività economica di bancari che li tiene lontani dalla politica del momento, sarà salutare per loro in quanto li salverà dalla grande Rivoluzione del 1789. Pietro De Gas e sua moglie Anna Hul vivono nel periodo rivoluzionario a Meung piccola città della provincia d’ Orlèans, avranno una numerosa figliolanza. Si conoscono di quei figli solo i nomi di Renè Hilaire, di Augustin, di Marie. Riescono a superare incolumi l’ “annèe terrible”. Non si conosce con esattezza la ragione per cui Renè Hilaire è a Parigi durante la Rivoluzione. E’ il capostipite della famiglia nonché nonno di Edgar, nato ad Orlèans nel 1769 è il più intelligente e attivo, dal piglio manageriale. A Parigi è in pericolo di vita per un gesto di coraggio e spavalderia giovanile durante il Terrore,raccontato da lui stesso al nipote Edgar che a sua volta lo riporterà così all’amico Paul Valèry:-“Il ventotto luglio 1904, Degas, in vena di ricordi, mi parla di suo nonno, che ha conosciuto e di cui ha fatto il ritratto a Napoli. Questo nonno durante la rivoluzione faceva aggiotaggio sulle granaglie. Un giorno, nel 1793, mentre stava lavorando alla Borsa dei grani che allora si teneva a Palazzo Reale, un amico passa alle sue spalle e gli mormora: “ Taglia la corda!… Mettiti in salvo !… Sono a casa tua !”. Non perde tempo, prende tutti gli assegnati che può procurarsi, lascia immediatamente Parigi, sfinisce due cavalli, raggiunge Bordeaux, si imbarca su una nave in partenza. La nave tocca Marsiglia. La stessa nave, secondo il racconto di Degas ( che mi guardo bene dall’interrompere ), a Marsiglia carica della pietra pomice, cosa che mi pare inverosimile. Che andasse a cercare zolfo in Sicilia ? Monsieur De Gas arriva infine a Napoli, dove si stabilisce. Era un uomo così capace e onesto che, due anni dopo il suo arrivo, riceve l’incarico di creare il Gran libro del debito pubblico della Repubblica Partenopea, recente invenzione di Cambon .
Sposa una giovane nobile di Genova, una Freppa, e mette su famiglia. Questo nonno con la minaccia del patibolo, che fugge così rapidamente dal Mercato dei grani, era stato iscritto nella lista dei sospetti per essere stato segnalato quale fidanzato di una di quelle famose “Jeunes vierges de Verdun”; molte pagarono con la vita l’accoglienza che avevano fatto, nel 1792, all’esercito prussiano entrato in Francia per ristabilire la Monarchia. Avevano ricevuto infatti con fiori e bandiere bianche queste truppe straniere, nemiche per gli uni, alleate e liberatrici per gli altri”. Dopo essersi salvato dal Tribunale rivoluzionario, Renè Hilaire De Gas , chiede protezione al governo napoletano e la ottiene subito, anche se gli stranieri di nazionalità francese non vengono visti di buon occhio dalla corte napoletana perché portatori di nuove idee rivoluzionarie sovvertitrici della monarchia. Le speranze di un giovane emigrato sono tante, ha dalla sua parte il suo essere nobile e aristocratico soprattutto nell’animo, possiede una grande capacità di adattamento alle varie situazioni, una notevole esperienza nonostante la giovane età in affari economici, una volontà di ferro che lo accompagnerà per tutta la vita. Non sono certo facili i suoi primi anni a Napoli. Ma si lega nonostante gli ostacoli profondamente a questa città che lo ha accolto a braccia aperte nel suo seno, vi si stabilisce considerandola come una sua seconda patria, anche se conserverà per sempre la cittadinanza francese e l’attaccamento alla sua terra d’origine; “ Per sentimento e – forse anche per convenienza tattica della sua vita in paese straniero, durante un’epoca in cui la società umana era in sovvertimento ovunque”. Renè Hilaire resta sempre lontano e al di fuori da ogni coinvolgimento politico, dedicandosi esclusivamente alle sue attività economiche e finanziarie. La sua è una saggezza di vita, determinata dai vari mutamenti politici e di regime che saranno frequenti anche a Napoli. Renè Hilaire nei suoi primi commerci a Napoli, conosce una famiglia genovese, quella dei Freppa. “ Facevano parte di una colonia di mercanti attivissimi della Repubblica di Genova, il cui quartiere sito verso gli approdi del mare era infatti chiamato “ Loggia di Genova”. La colonia era tanto numerosa che aveva fissato ancora un altro quartiere nel centro della città, nei pressi dell’antica piazza del Castello che si chiamava “ Genova la piccola”. Il nome indicava la grande importanza di quel raggruppamento etnico di famiglie tutte appartenenti ad un’altra “nazionalità” le quali straniere in Napoli, amavano vivere in località a sé stante, per comodità di rapporti e per darsi all’occorrenza reciproco aiuto e protezione. I Freppa invece pur essendo di nobile famiglia genovese si naturalizzarono napoletani registrandosi nelle chiese della Diocesi Arcivescovile di Napoli, in quanto da tempo avevano fissato in quella città la loro dimora.” Il membro più importante di questa famiglia è un teologo, Don Antonio Freppa , parroco della chiesa di S. Anna dei Lombardi, nei pressi del monastero di Monteoliveto. Renè Hilaire dopo il suo sbarco napoletano avvenuto nel 1793, trova lavoro presso il suo connazionale Bourguignon il quale è in rapporti di affari con Lorenzo Freppa, fratello di Don Antonio, conquistandone ben presto la fiducia e l’affetto. “ Casa Freppa era una importante casa di affari con doppia sede in Napoli e a Livorno. Ed a Livorno era nata precisamente Giovanna Aurora Teresa Freppa figlia di Lorenzo e di Rosa Aurisicchio, napoletana, che Renè Hilaire De Gas sposò poi nel 1804”. Solo la sorella Marie seguirà il fratello Renè Hilaire a Napoli, dove sposerà uno svizzero, Carlo Jean. A Parigi, per tutta la vita rimarrà il fratello Augustin, mentre il vecchio padre Pietro De Gas resterà nella sua Orlèans insieme agli altri figli. Sono sempre affettuosi i rapporti tra Renè Hilaire e Augustin, che gli farà da tramite nella divisione dell’asse ereditario paterno e sarà il suo fidato corrispondente in Francia nelle transazioni economiche e commerciali. “ Le lettere dei due fratelli si conservarono per circa un secolo e mezzo in casa De Gas a Napoli, ma dopo il bombardamento, che nell’ultima guerra colpì gravemente il palazzo De Gas in Napoli alla Calata Trinità Maggiore n. 53 se ne sono ritrovate tra le macerie ben poche. Ne trascrivo i passi più salienti, dai quali traspare uno stile pieno di spirito. Dalla lettera datata Paris le 10 Fdor An 12 di Augustin si rileva che Renè Hilaire si era recato in Francia per regolarizzare i suoi rapporti d’interesse con la famiglia d’origine prima di distaccarsene per sempre. Augustin si congratula col fratello, ancora impiegato presso il compatriota Bourguignon, negoziante in Napoli del suo prossimo cambiamento di posizione sociale, preannunziatogli dallo stesso Renè Hilaire”. Le lettere di Augustin portano la data del calendario rivoluzionario fino al 21 Frimaio dell’anno quattordicesimo, corrispondente al 12 dicembre del 1805, dal 7 gennaio 1806 riprende il calendario gregoriano ripristinato da Napoleone. Il 2 settembre del 1804 viene celebrato il matrimonio nella chiesa di S. Anna dei Lombardi , di Renè Hilaire con una giovanissima Aurora Freppa . Il Celebrante è lo zio della sposa don Antonio Freppa. In una lettera di congratulazioni per il matrimonio del fratello, Augustin annuncia anche il suo fidanzamento. La lettera è indirizzata alla “ Maison de Mr Laurent Freppa Negt Naples”. Da ciò risulta evidente la convivenza dei due novelli sposi in casa del padre di lei. Dalla loro unione nasceranno sette figli, quattro maschi e tre femmine. Una vera manna dal cielo, come è considerata agli inizi dell’Ottocento, una famiglia numerosa specificatamente meridionale. Il fratello Augustin che intrattiene con Renè Hilaire una fitta corrispondenza lo prende in giro paragonandolo ad un fittavolo di campagna:-“Te voilà, ma foi, comme un fermier, mon cher Hilaire, une demoiselle et deux garcons, le deuxième est sans doute venu malgrè la fraude”. Ma dopo il terzo figlio, seguiranno altre quattro nascite. Renè Hilaire diventa per i suoi parenti parigini “ le petit napolitain”. Alla primogenita viene dato il nome della nonna materna: Rosa. E’ battezzata dallo zio Don Antonio Freppa, nella chiesa dei Santi Giuseppe e Cristoforo. Il secondogenito Auguste , nato a Napoli nel 1807 è il padre di Edgar Degas.Anche lui risulta battezzato nella stessa chiesa. Il 22 aprile del 1809 nasce il terzogenito: Enrico. Quarto figlio è Edoardo, seguono poi Achille e altre due femmine Laurette e Fanny. Rispettivamente tutti nati a Napoli il 1805,1809, 1811, 1812,le ultime due il 1814 e il 1819. Tutta questa numerosa prole vive la sua esistenza a Napoli, moriranno nella stessa e saranno sepolti, i figli maschi nella cappella gentilizia della Famiglia Degas, che si trova tuttora nel Cimitero di Poggioreale. Viene fatta costruire da Renè Hilaire, su un suolo acquistato dal Municipio di Napoli nel 1841, per sé e per i suoi. Nello stesso anno, vi fa apporre la scritta in lettere di marmo bianco a rilievo “ Famille Degas” e il millesimo in cifre romane. Delle tre figlie , Rosa sposa il duca Giuseppe Morbilli di S. Angelo della piccola nobiltà locale, muore a Napoli il 25 marzo del 1879. E’ sepolta nella tomba del marito, nel cimitero di Poggioreale. La segnerà per tutta la vita il dolore per la perdita del giovane figlio ventenne, il duca Gustavo Morbilli, durante le barricate del 1848. Laurette sposa il 31 agosto del 1842 il barone e avvocato Gennaro Bellelli, muore nel 1897. E’ sepolta a Napoli nella tomba dei Bellelli. Fanny l’ultimogenita sposa il marchese Carafa di Cicerale, duca di Montejasi. Muore nel 1901. E’ sepolta nella tomba di famiglia del marito nella congrega dei nobili a Montecalvario. Il barone Bellelli è il protagonista del quadro “ La famiglia Bellelli” insieme alla zia Laura e alle figlie dipinto da Edgar a Firenze dove lo zio Bellelli si troverà esiliato insieme alla famiglia , per motivi politici. Zia Fanny con le sue due figlie, Elena e Camilla, sarà ritratta da Edgar nel dipinto conosciuto con il nome “La duchessa di Montejasi”. Fanny è una donna generosa, pia e caritatevole, dedita al volontariato come scrive un giornale cittadino :-“I poveri accorrevano a lei perché conoscevano il suo animo sempre pronto a lenire le miserie”. Dei quattro figli maschi , solo Auguste sposa una francese, vivrà in Francia alternando visite al padre Renè Hilaire a Napoli. A lui si associa il fratello celibe Achille fondano insieme “ Casa De Gas a Parigi”. Gli altri due fratelli fondano col padre la società “De Gas Padre e Figli”, dopo la morte del padre:-“De Gas Frères”. L’uno Edoardo Enrico rimarrà celibe, l’altro Giovanni Odoardo sposerà una nobile napoletana Candida Primicile Carafa . Auguste in Francia apprende la lingua francese, perché parla solo il napoletano. E’ apprendista in una banca di Parigi senza stipendio. Compie studi economici e commerciali in una scuola locale. Inizia la sua professione di bancario, non dimenticando mai di scrivere alla sua famiglia rimasta a Napoli. Intanto Renè Hilaire può definirsi un uomo molto ricco, ne è passato di tempo dal suo sbarco a Napoli e dalla sua prima nomina ad agente di cambio,ora possiede una vera fortuna in beni immobili, terreni, collezioni d’arte, una ricchissima biblioteca,con testi di Voltaire, Diderot, Rousseau, dipinti di Smargiassi e di Palizzi.
E’ un uomo colto e sensibile alle manifestazioni dell’arte e del pensiero umano. Il suo acquisto più importante è quello del palazzo del principe Pignatelli di Monteleone sito in Calata Trinità maggiore, n.53, nei pressi della piazza del Gesù nuovo. Questo palazzo settecentesco costruito e progettato dall’architetto napoletano Ferdinando Sanfelice diventa la residenza della famiglia Degas. Altra residenza di importanza notevole è villa San Rocco di Capodimonte, dove il nipote Edgar più volte passerà l’estate. Ritornando a palazzo Pignatelli, Renè Hilaire lo acquista nel 1832 definitivamente dopo lentezze amministrative, dal principe don Diego Pignatelli. E’ un palazzo ampio, dotato di un maestoso portale dove si alternano decori in piperno e fregi in marmo bianco: il cortile è spazioso, la scala principale tutta in piperno, le stanze sono grandi e luminose. Sulla facciata principale, al lato destro del portale, in alto vi è una lapide celebrativa in memoria di Edgar Degas, il grande artista che visse e tornò più volte in quella dimora. Una parte di questo palazzo verrà ereditata da Edgar e da sua cugina Lucie. “ Si è già notata la varietà dell’ortografia del cognome di questa famiglia anche in antichi documenti. Ma la persecuzione in Francia contro gli aristocratici durante la rivoluzione aveva consigliato tutti i componenti di casa “De Gas” di riunire ancora una volta le due particelle del loro cognome e chiamarsi “Degas”. Gli avvenimenti politici ai quali Renato Ilario aveva assistito in Napoli, nel 1798-99, gli consigliarono mantenere così riunito il suo cognome: ingenua per non dire puerile precauzione, al certo inutile e superflua, in Napoli. Non fu quindi il pittore Edgar a cambiare per primo l’ortografia del cognome. Quel che è strano è l’uso promiscuo, che della diversa ortografia del cognome fecero poi, in una o due sillabe staccate sia Renato Ilario che i suoi figli e nipoti Ilario De Gas ripristinò in due sillabe questa ortografia in due sole circostanze:- in occasione della nascita del figlio maschio Giovanni Edoardo quartogenito, mentre per tutti gli altri sei, usò il cognome con le due sillabe riunite, “Degas”; ed un’altra volta nell’acquisto di vari fondi rustici nel quale si costituì e firmò De Gas. Furono i figli di Auguste, Achille e Renè a ripristinarlo in New Orleans: “De Gas Brothers”, come si apprende dal fratello Edgar che nella sua lettera a Diha 11 nov. 1872, da New Orleans si servì della carta così ad essi intestata. Ma egli, Edgar, firmò sempre “Degas” .1 Degas nelle cui vene scorre un quarto di sangue napoletano, conserverà legami familiari stretti a Napoli , dove si recherà spesso dalla giovinezza alla maturità. Ricorda Paul Valery:-“ Durante uno di questi viaggi fu vittima di un furto in treno. Sosteneva che mentre dormiva, gli avevano fatto un’iniezione di una potente sostanza narcotica e che gli avevano sottratto il portafoglio contando su quel sonno profondo. Conservava di Napoli impressioni e ricordi su cui amava tornare. Parlava napoletano con la scioltezza e l’accento più autentici, a volte canticchiava brani di canzoni popolari, come se ne cantano laggiù agli angoli delle strade”. Ed è soprattutto a Napoli prima di ogni altro luogo in Italia, che scopre gli splendori del Rinascimento e i tesori dell’Antichità. Conoscerà ogni cosa di questa città, mosso da una curiosità insaziabile e da una ricerca inesauribile. Napoli con la sua luce è tutto, con i suoi odori e i suoi suoni, la sua gente triste e allegra, i suoi colori, i mille gesti quotidiani, non potranno renderlo insensibile. La loquacità, ma anche la povertà del ceto più umile lo colpiranno profondamente. A volte si sentirà uno di loro. Il giovane Edgar vive a Parigi con il padre in un appartamento al n. 4 di Rue Mondovì. Una stanza diviene il suo primo atelier. Conosce Soutzo, amico del padre che gli insegna la tecnica dell’aquaforte. Ha come amici dai tempi del liceo Ludovic Halévy, futuro scrittore, e Paul Valpincons, il cui padre collezionista e uomo di cultura possiede la famosa Bagnante di Ingres. Ha dissidi con il padre in quanto abbandona gli studi di Diritto. Inizia a frequentare l’atelier di Lamothe, che gli suggerisce di iscriversi all’Ecole de Beaux-Arts e gli trasmette la passione per Ingres. Degas soprassiederà a questo suggerimento prendendosi una pausa di riflessione. Ha dei problemi in famiglia che cercherà di risolvere:-“Fin dalla prima adolescenza Edgar Degas aveva mostrato una chiara, netta, predisposizione al disegno, e, giovinetto ancora, un’ avversione profonda agli studi preparatori ad una vita che dovesse dedicarsi essenzialmente ed intensamente agli affari di finanza, di cui era saturo l’ambiente di casa sua.
Malgrado tutto completò i suoi studi presso il liceo parigino “Louis le Grand” di Parigi si iscrisse pure nella Facoltà di Giurisprudenza, che però non frequentò per nulla, insistendo invece con fermezza, presso suo padre, perché gli avesse consentito di dedicarsi esclusivamente all’ Arte” . Dietro questa insistenza del figlio, il padre uomo colto e comprensivo non può che cedergli, anche nonno Hilaire da Napoli appoggerà questa decisione del nipote. “ Suo nonno il saggio Renè Hilaire intervenne ancora una volta presso suo padre e pur deridendo la sua aspirazione- da lui uomo d’affari affatto incompresa- disse con la sua autorità la parola decisiva, che segnò l’avvenire di Edgar”. Nel 1854, compie il suo primo viaggio a Napoli. Alloggerà in casa di nonno Hilaire che avrà per lui un affetto particolare. “Così, nel 1854, Edgar si trattenne più a lungo in Napoli, in casa del nonno, e frequentò anche il “Reale Istituto di Belle arti” di Napoli, che fin dal 1822 aveva riunite riordinandole- tutte le varie preesistenti scuole pubbliche di disegno e di arti napoletane”.49 “Edgar Degas apprese, infatti, a Napoli le prime nozioni di disegno e di pittura sotto la guida di maestri napoletani. Nell’epoca, fra gli altri, vi insegnavano Giuseppe Mancinelli disegno; Camillo Guerra pittura; Tito Angelini scultura; e Gabriele Smargiassi paesaggio. “Irrequieto e insoddisfatto Edgar Degas volle però ritornare a Parigi, ove si iscrisse nel 1855 all’Ecole des beaux Arts. Insofferente ancora, appena l’anno dopo, nel 1856, abbandonò la scuola di Parigi e si mise in viaggio per l’Italia : fu di nuovo a Napoli e poi a Roma ed a Firenze, per attingere dai capolavori dell’arte classica italiana insegnamento ed ispirazione”. Il Grand Tour italiano è molto importante per Degas al pari di altri artisti stranieri, anche perché il graduale abbandono delle tradizioni dell’apprendistato lo rende indispensabile per gli artisti amanti della tecnica, ansiosi di appagare il loro desiderio di espressione con una qualità formale che ne fortifichi la portata. In Degas l’istinto è troppo precocemente controllato per non condurlo a cercare prima una forma espressiva, un metodo. Fin dalla prima giovinezza si esercita a dominare una tecnica ancora primordiale. In questo periodo “Le copie fatte, seguendo i maestri sembrano non aver avuto il solo scopo di divenire più abile nel disegno o nella composizione, o di elevare il suo stile, ma di acquisire gli elementi di un mestiere che mancava sia a lui sia ai contemporanei e agli immediati predecessori”. Per questo i viaggi in Italia sono dei pellegrinaggi alle fonti. Certamente la condizione sociale della famiglia Degas e la presenza nella penisola dei suoi membri lo favoriscono notevolmente. A Napoli fin dal 1854, quando sta per giungere a casa di suo nonno, il suo occhio si risveglia dinanzi allo spettacolo della natura:- “Lasciando Civitavecchia il mare è azzurro, poi è mezzogiorno, e diventa verde mela con tocchi di indaco al lontano orizzonte: all’orizzonte una fila di barche a vela latina sembra un nugolo di gabbiani o di gavine per tono e forma il mare un po’ agitato era di un grigio verdastro, la schiuma argentea delle onde, il mare si dissolveva in un vapore il cielo era grigio. Il Castel dell’Ovo si elevava in una massa dorata. Le barche sulla sabbia erano macchie color seppia scura. Il grigio non era quello freddo della Manica ma piuttosto simile alla gola di un piccione”. Note asciutte non letterarie, prive di sensazioni ma precise e tali da individuare esattamente il luogo. Degas in alcuni rari paesaggi preferirà l’impressione immediata , ma questa si fonda su una sicura conoscenza di dati reali. Oltre alla natura che sembra incantarlo particolarmente a Napoli, non sarà così loquace per altri luoghi che visiterà in futuro. In questa città, Degas trova degli esempi che analizzerà. Ci ha lasciato un elenco di dipinti che l’hanno colpito particolarmente. “La vergine dalla lunga gamba” di Giulio Romano, “Papa Paolo III” di Tiziano, “Santa Caterina” di Correggio, “Leone X” di Andrea del Sarto, un dipinto di Claude Lorrain scelta curiosa che non s’inserisce molto logicamente nell’estetica successiva e per il quale Degas commenta:-“ Il più bello che si possa vedere, il cielo è d’argento gli alberi sono parlanti”.Amerà con trasporto l’arte antica, “ l’arte più forte e più incantevole”. Degas nei suoi carnet, non dà alcuna indicazione degli aspetti reali e anche curiosi della Napoli all’epoca dei suoi primi viaggi. Forse per pudore , disconoscimento di taluni aspetti della vita. Nessun altra età è più adatta per goderne, Napoli città favolosa e “corrotta” non offre alcun piacere a questo giovane irrigidito nella sua dignità?. Gustave Coquiot se ne stupisce:- “
A quell’epoca, 1856, nessun esercito della salvezza, nessuno scandalo aveva ridotto la brulicante prostituzione della città sudiciona. Il sesso folleggiava in piena esultanza”. Un romanziere viaggiatore, Flaubert, annota nella sua corrispondenza:-“Napoli è un soggiorno delizioso (frammento di una lettera alla madre del 1851). Le donne escono senza cappello in vettura, con dei fiori nei capelli e hanno tutte l’aria sfrontata. Ma non è che l’aria. A Chiaia (Chiaia è una grande passeggiata fiancheggiata da castagni verdi, in riva al mare, alberi a pergolato e mormorio di flutti) le venditrici di violette vi mettono a forza i mazzetti all’occhiello. Bisogna maltrattarle perché vi lascino tranquillo”. Un altro viaggiatore ottocentesco Louis Bouhilet dichiara:-“ Napoli è incantevole per il numero di donne che vi si trovano”. Tutto un quartiere è pieno di prostitute che stanno sulla porta di casa . E’ l’antica vera Suburra. Quando si passa per la strada sollevano i vestiti fino alle ascelle per avere due o tre soldi. Vi inseguono in questa posizione. E’ ciò che ho visto di più incredibile in materia di prostituzione e cinismo. Anche il sole è innamorato. Tutto è lieto e facile. I cavalli portano ciuffi di penne di pavone alle orecchie”. Tutta questa canaglia non interessa Degas che persegue il suo itinerario culturale. E un altro insigne viaggiatore Guy de Maupassant ricorda della pittoresca mobilità del popolo napoletano:- “Napoli si sveglia sotto un sole sfolgorante, Per le sue strade comincia a brulicare la popolazione che si muove, gesticola, grida, sempre eccitata e febbrile, rendendo unica questa città così gaia. Lungo i moli le donne, le ragazze, vestite di abiti rosa o verde, il cui orlo bigio è limato al contatto con i marciapiedi , il seno avvolto in sciarpe rosse, azzurre, di tutti i colori più stridenti e più inattesi, chiamano il passante per offrirgli ostriche fresche, ricci e frutti di mare, bibite di ogni sorta e arance, nespole del Giappone, ciliegie”. E ancora Flaubert, che alloggia all’ Hotel Gèneve, in via Medina, trascorre gran parte del suo tempo tra le “città morte” della zona vesuviana e il Museo Nazionale, prima di affrontare una gita a Capri durante la quale rischia di naufragare, lascia la città traboccante di entusiasmo:- “Bisogna andare a Napoli per ritemprarsi di giovinezza, per amare la vita. Lo stesso sole se n’è innamorato”. Altra la situazione storico-politica della capitale del Regno delle Due Sicilie. Siede ancora sul trono, Ferdinando II di Borbone, che dopo aver represso con il sangue i moti liberali del ’48, “Rese consapevoli i liberali rimasti dell’impossibilità di fare del Regno delle Due Sicilie uno stato retto da leggi costituzionali e democratiche, in quanto, il re “bomba” dopo il 15 maggio i liberali designavano Ferdinando II con l’appellativo di re bomba , perché invece della Costituzione aveva dato ai napoletani le bombe dei cannoni non avrebbe mai rinunziato al potere assoluto, allora questi, mutarono indirizzo politico e cominciarono a pensare al regno come una parte dell’ Italia unificata sotto lo scettro di una casa italiana regnante : quella dei Savoia. Vengono condannati dal Borbone , i patrioti Silvio Spaventa, Luigi Settembrini, Filippo Agresti, Michele Pironti e Carlo Poerio. Sono considerati pericolosi, perché fautori di questa nuova politica. I processi, le condanne, le repressioni e le persecuzioni non scoraggiano i liberali. Prende coscienza sempre più la necessità di un loro inserimento nel Movimento Nazionale Italiano capeggiato da Giuseppe Mazzini che però rifiuta ogni forma monarchica e propugna l’ordinamento repubblicano. “Nel dicembre del 1856 avvenne l’attentato contro il Borbone, del soldato Agesilao Milano che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ebbe nessuna attinenza con le attività liberali in quanto l’attentatore agì di propria iniziativa e isolatamente. Nella ricorrenza della festa dell’ Immacolata Concezione, ebbe luogo al Campo di Marte una parata militare, mentre i reggimenti sfilavano, un soldato l’Agesilao Milano uscì dalle file e vibrò un colpo al re, che a cavallo assisteva alla sfilata, con la baionetta innestata sul fucile. Il ferro scivolò sul fianco destro del sovrano senza produrre altro danno che una leggera ecchimosi perché Ferdinando era protetto da una maglia d’acciaio portata sotto la divisa. Ben più rilevante fu la spedizione di Carlo Pisacane nel giugno dell’anno dopo, il 1857, che si concluse tragicamente. Come se non si sentisse più al sicuro nella capitale, dopo l’attentato, Ferdinando preferiva la reggia di Caserta e spesso si trasferiva a Gaeta” Dunque è questo lo scenario che si schiude agli occhi del giovane Degas, durante la sua permanenza nella città partenopea.
Durante il soggiorno napoletano del 1856, la sua attività pittorica si indirizza verso i paesaggi dei dintorni, appuntati nei suoi carnet, e verso i ritratti della sua famiglia. Qui dipinge i due ritratti delle cugine, “Giulia e Giovanna Bellelli” e “ Donna sulla terrazza” che riutilizzerà per “Semiramide che costruisce Babilonia” . Negli ultimi due dipinti sono evidenti i richiami a Flandrin filtrati da Lamothe. Tra la fine del ’56 e il luglio del ’57 Edgar soggiorna a Roma per il tradizionale studio dei maestri italiani. Si sposta di frequente nei dintorni di Roma o anche in viaggi più lunghi per tutta l’ Italia. Nel luglio del ’57 Degas è a Napoli dove esegue il ritratto del nonno paterno datato 6 settembre 1857. Il segreto della sua pittura risiede sin dai suoi inizi dalla costante messa in atto dei suggerimenti degli antichi maestri senza imitarli:- creare, muovendo dai loro principi qualcosa di completamente diverso. Bisogna imparare la semplicità del profilo e la purezza della linea del primo Quattrocento; la dignità della forma, la perfezione del modellato dal Pontormo e da Andrea del Sarto. L’umanità dovunque, ma non mai senza misura:-“ Il mistero di una figura di Leonardo non doveva essere ricercato nella sua eloquenza visiva, ma proprio nella mancanza di affabilità”. Incominciano ad affascinarlo le delicate armonie cromatiche:-“ cercò fin troppo spesso la patina del colore anziché il colore puro, l’oro opaco di un’antica vernice, l’azzurro pallido e nebuloso di qualche affresco umbro. Ma a differenza di Whistler, che cercò di anticipare il giudizio dei posteri dando artificiosamente alle sue tele la patina dei secoli, Degas non accentuò mai troppo questo elemento. Non diede mai un rilievo eccessivo ad alcuna cosa, ed è caratteristico che nei suoi viaggi in Italia si sia sempre fermato prima di arrivare a Venezia”. Inizialmente Degas si dedica alla pittura di Storia. Ciò significa seguire David, Ingres e i suoi maestri e costruire qualche “macchina colossale” attorno ad un soggetto antico o biblico :-“ tentò parecchie di queste vaste composizioni, ma nonostante alcuni ammirevoli elementi e le nobili intenzioni, qualcosa in esse non funzionava. Sembra quasi che Degas intuisse, inconsciamente che nella Parigi di Napoleone III il destino della pittura storica era segnato”. Quando passerà alla ritrattistica, tutta la sua acuta osservazione e la conoscenza del disegno antico gli verranno immediatamente in aiuto:- “La serie dei piccoli autoritratti nei quali fissò senza adularli i propri lineamenti mobili e un po’ malinconici, oppure gli studi penetranti che fece della sua famiglia, mostrano un Degas non inceppato da precetti né da regole. Essi rivelano una nuova concezione del ritratto, in cui la naturalezza e il carattere sono messi in rilievo al di là del formalismo da atelier”. Degas non ha mai dipinto ritratti su commissione. Il primo requisito per la sua arte è la simpatia che si instaura fra l’artista e il modello. Da tale rapporto nasce la sua tenerezza, l’acuta capacità d’osservazione non scevra da una pignola ironia quando scopre un tratto del carattere o un tic nel comportamento, che danno maggior concretezza alla sua visione. I soggetti delle sue opere sono sempre amici e membri della sua famiglia. Sui modelli prescelti Degas esercita un dispotismo tirannico. Interrompe a metà un ritratto, quando Madame Dietz Monnin posa per lui, e gli dà dei suggerimenti:-“ Aveva incominciato a dipingere un’opera a modo proprio e si accorgeva che la stava trasformando secondo il gusto del modello. Quando una bella donna voleva posare per lui, Degas le diceva bruscamente: “ Sì, mi piacerebbe farle un ritratto, ma la costringerei a mettersi una cuffia e un grembiule come certe servette”. E’ un giovane che promette bene sin dall’inizio del suo percorso artistico, geniale, solitario e un po’ riservato. Si è distaccato presto dalla narrazione storica, ora accetta i temi semplici e reali, più tardi le danzatrici, i cavalli, le donne che s’abbigliano e le lavandaie, il non finito inerente alla visione moderna s’inscrive adesso nella struttura della materia. Degas conserverà gelosamente i suoi esperimenti giovanili, ai quali terrà molto e nonostante l’ecclettismo, si riveleranno potentemente originali nel loro stile e nelle loro implicazioni e necessari al suo compimento futuro. La giovane maestria di Degas si manifesta nel ritratto di gruppo dei Bellelli, gli zii napoletani dell’artista. Basta un accenno in questa sede perché l’opera fu interamente concepita a Firenze e finita a Parigi. “La famiglia Bellelli”, acquistata dai musei francesi prima della dispersione dello studio dell’artista, è la sintesi e il vertice del soggiorno fiorentino, riepilogo e quasi anticipazione di tutti i legami con la sua famiglia napoletana. E’ uno straordinario esempio di introspezione psicologica. La coppia in disaccordo e le figlie in apprensione svelano al di là delle apparenze e delle pose il loro fondo segreto, nella luce dell’interno dove ogni oggetto domestico, compreso il piccolo dipinto del nonno, appeso alle loro spalle e morto recentemente, hanno un proprio significato. Uno dei preziosissimi ricordi di Ernest Rouart raccolti da Paul Valery ci rivela:-“ Degas molto difficilmente s’accontentava e raramente trovava che un quadro andasse bene. Non che cercasse tranne nei lavori giovanili, l’esecuzione minuziosa, il finito, che altri hanno potuto trovare eccessivo,ma che nondimeno gli fecero creare quadri notevoli e sovente dei capolavori. Per essere soddisfatto bastava che la sua opera fosse compiuta, non nella perfezione dei particolari, ma nell’impressione complessiva che doveva dare; soprattutto nella costruzione e nella coordinazione degli elementi diversi da cui era composta, ossia nei giusti rapporti delle linee del disegno, dei valori e dei colori tra loro. Attribuiva un valore enorme alla composizione, all’arabesco generale delle linee, poi alla resa della forma e del modellato; all’accento del disegno, come diceva”. Degas dopo la sua scomparsa, lascia ai posteri, centinaia di copie. Rivelate al mondo dalla vendita del suo studio e dalla sua famiglia. La pubblicazione dei suoi Carnets mostra un’attività intensa ed eclettica. Questo ha contribuito senz’altro a mostrarlo non come un vero innovatore, bensì come il continuatore di una grande tradizione, determinandone la particolarità all’interno del gruppo impressionista. Taluni ancora oggi pericolosamente sogliono mostrarcelo come il primo tra i pittori accademici piuttosto che il più singolare degli impressionisti. La sua posizione era intransigente, stabile, fissa:-“Bisogna copiare e ricopiare i maestri, e soltanto dopo aver fornito le prove d’un buon copista vi si potrà ragionevolmente permettere di dipingere un ravanello dal vero”. In Degas non era presente l’atteggiamento di derisione che avrebbe animato il tanto ammirato Delacroix nei confronti dei “preraffaelliti” francesi quando “parlano di tutti i nomi gotici della Scuola primitiva italiana, come se fossero loro amici”. Questa sua stretta ammirazione verso la tradizione non lo ha mai condotto al passatismo servile, al freddo accademismo. Il desiderio di far rinascere lo spirito del tempo passato, di ristabilire l’antica maniera di dipingere, non l’ha mai sfiorato. Ha solo voluto trovare nei predecessori, la parola giusta , la formula appropriata. Parla dell’Italia come “L’époque la plus extraordinaire de ma vie”. La maggioranza delle copie sono datate 1856 e 1858 quando studia sia all’ Ecole , al Louvre e al museo di Napoli. Rimane estasiato alla vista dei mosaici pompeiani nel Museo di Napoli e scrive: “ Comment oublier que l’antique, l’art le plus fort, est le plus charmant? Coloristes comme Veronese, audacieux et, tojours harmonieux…Copia Durer e i ritratti di Holbein e Clouet a Parigi, in Italia nel 1858 e nel 1861, ha luogo la sua maturazione di artista. Copia ancora Raffaello, Giorgione e Tiziano, Van Dyck e Velasquez. In un suo taccuino del 1860 vi sono appuntati dei disegni tratti da… Delacroix… Signorelli, Tiziano e Roger Wan der Weyden, dei rilievi Assiri e delle miniature mongole”. “ A quel tempo gli interessi di Degas spaziavano dalle civiltà del Mediterraneo al gusto per l’esotico”. Theodore Reff riporta un elenco di copie numerate, fatte da Degas a Napoli e conservate nella Biblioteca Nazionale di Parigi. Degas, non solo al Museo, ma anche in giro per i luoghi sacri di Napoli. Sarà entrato nella chiesa del Gesù Nuovo, poco distante dal palazzo di nonno Hilaire. E’andato nella chiesa di Sant’Angelo a Nilo, eretta nella seconda metà del sec. XIV dal Card. Rinaldo Brancaccio in onore di San Michele, con annesso ospedale per i poveri: “ La maggior porta è sulla Via di Mezzocannone… La chiesa, così come vedesi oggi, fu rinnovata dal Guglielmelli; ora s’è n’è fatto un nuovo restauro. La tavola di San Michele sul maggiore altare è tra le bellissime di Marco da Siena; a sinistra è il sepolcro del card. Rinaldo fondatore, stupendo lavoro del Donatello, ( Degas, copia questo monumento) costruito per ordine del gran Duca Cosimo de Medici, esecutore del testamento del cardinale, che morì in Firenze”. Lo ritroviamo a percorrere i labirinti delle catacombe di S. Gennaro. “Intorno alle origini delle nostre catacombe, molto si è discusso, esse furono semplici sepolcreti, non mai cavi di pietra, né vie sotterranee; la prima notizia ripetersi dall’epoca della morte di S. Agrippino nostro vescovo al secolo II, quando il suo corpo fu quivi sepolto in avello gentilizio, e pè molti miracoli che da quella tomba operava il Santo, piacque a’ Napoletani di seppellirsi a lui dappresso. Sul principio del secolo IV il corpo del martire San Gennaro, fu sepolto quivi nelle cripte gentilizie. In queste tombe trovasi tracce di pitture e graffiti. Elegantissime sono le pitture tali che di nulla scapitano nel raffronto con quelle di Ercolano e Pompei, v’ha di mascheroni, ippocampi, cervi, ecc. sulla dritta di chi guarda son due rappresentanze di una donna con un uomo, e di tre donne. Sopra un adito murato laterale all’ambulacretto vedesi dipinto un santo vescovo, con due figure nell’arco Nel lucernaio è dipinta a forme colossali la Vergine col Bambino fra due Santi o Angioli e Loculi come il sepolcreto principale, adorni di rabeschi, fiori, conchiglie, uccelli, e molti nomi iscritti a lettere greche sulle pareti ad ocra rossa”. Degas continuerà a nutrirsi di opere d’arte, saranno il suo pane quotidiano. Non disdegnerà neppure la Cattedrale di San Gennaro e le sue meraviglie. Nella chiesa gotica di Santa Chiara, dall’interno allora barocco, Degas rimarrà sconvolto dalla distruzione settecentesca dei meravigliosi affreschi di Giotto e della sua bottega. Sotto gli stucchi ridondanti, rimane ben poco di quei capolavori. Si rifarà in parte gli occhi nella cappella palatina, di Castel Nuovo, unica testimonianza del periodo angioino al quale risalgono i preziosi frammenti della decorazione ad affresco negli strombi delle finestre, documento della permanenza di Giotto e del suo allievo Maso di Banco. Sarà questa la molla che lo spingerà ad Assisi. Napoli è un piccolo condensato di capolavori che alla sua curiosità sempre crescente, non può bastare. Verso la fine degli anni Cinquanta scrive all’amico Pierre Cornu:- “Sono ancora incerto, non ho uno stile mio. Spesso mi domando se sarò un pittore o uno scultore. Non ti nascondo che sono molto perplesso”. Quando Degas rientra a Parigi dopo aver viaggiato a lungo attraverso la nostra penisola, è il 1859. In quattro anni d’ Italia, la sua arte, ha compiuto una considerevole evoluzione. Suo padre Auguste, fervente critico della sua pittura, può constatare alla ricezione dei dipinti speditigli dal figlio, i progressi raggiunti da questi e gioisce nel vederlo finalmente libero da quel vuoto e triviale “disegno Flandriniano – Lamothiano e da quel colore grigio cupo”. Progressi tanto più evidenti ai suoi occhi in quanto giudica con severità la produzione dei compagni di viaggio del giovane Edgar:-“ il disegno di Tourny è corretto ma è molle, vuoto senza alcun vigore, da lontano somiglia a un disegno di una signorina, ha la stessa morbidezza”. Gli invii dall’Accademia di Roma,( frequentata da Degas e compagni, tra cui Gustave Moureau) esposti a Parigi nel 1858, “sono deplorevolmente deboli”, Lèvy fa “della pittura sfibrata, amalgama e reminiscenza del genere in voga in questi giorni”, Delaunay “imitatore di un Flandrin di non buona lega”. L’artefice dei miglioramenti di Degas è Gustave Moreau, come è stato sottolineato più volte. Questi gli permette di sbarazzarsi della pesante influenza di Flandrin e di Lamothe, di guardare altrove e in particolare Delacroix. Moreau segue un percorso parallelo: “cosciente che il disegno è la sua parte forte vuole d’ora in poi avviare i suoi sforzi sul colore dedicandosi “ a studi di valori e di toni decorativi” dove “lo studio del particolare non entrerà in nessun modo”; per fare questo moltiplica le ricerche tecniche utilizzando di volta in volta l’acquarello allo scopo di rendere “il tono compatto e l’aspetto dolce dell’affresco”, la “tempera lumeggiata con l’acquerello” per “imitare gli affreschi a olio” o anche il pastello”. E’ a Moreau che si deve l’interesse di Degas per questi procedimenti, e forse l’iniziazione al pastello. Impiegherà questa tecnica per effetti di “colorazione generale” in alcuni bozzetti della Famiglia Bellelli e di Semiramide. Degas alla ricerca di un suo personale linguaggio, volutamente , costantemente. Si guastano i suoi rapporti amicali con Moreau. Non si hanno testimonianze sui loro rapporti ulteriori, certo è che Degas non risparmierà più tardi all’ amico del Grand Tour italiano qualche parola caustica sulla sua pittura. Si allontanerà anche dal suo maestro Lamothe. Scriverà di lui di ritorno a Parigi nel 1859 :-“Lamothe è più idiota che mai” e si guasteranno i rapporti con il vecchio maestro. C’è tra i due pittori, un abisso. “L’Autoritratto di Lamothe del museo di Lione , cui Degas si ispira per i suoi primi autoritratti, riprende il celebre modello ingresco.
Decisamente Lamothe è più idiota che mai; Il maestro non evolve e l’allievo, ancora incerto cambia molto rapidamente”. Il periodo della frequentazione di Moreau, viene apertamente contestato da Auguste Degas, sente il figlio in pericolo e troppo incline a seguire i suoi pericolosi consigli, di dedicarsi allo studio di coloristi come Rubens o Delacroix. Lo mette in guardia :-“ Hai osservato bene, contemplato gli adorabili maestri dell’affresco del XV secolo, te ne sei colmato lo spirito, hai disegnato o piuttosto eseguito degli acquerelli dalle loro opere per ricordarti dei loro colori. E il Giorgione l’hai bene analizzato nei suoi mirabili toni di colori, accompagnati da un così bel disegno di grande eleganza, te ne sei imbevuto?” Degas non seguirà i consigli di suo padre. Le numerose copie eseguite in Italia, sono per la tecnica , per il formato e per gli argomenti, molto diverse. Sono semplici abbozzi dal vivo o di memoria. Copie di un’intera opera o di un frammento, disegni ma anche dipinti su tela. Sono riprese scrupolose dell’opera studiata o variazioni su di un tema antico. O per riprendere una sua frase celebre esse sono la prova di un amore, di un piacere, che Degas serberà per tutta la vita. La scienza dei maestri antichi, la vastità del loro vocabolario saranno alla base della sua incessante ricerca. E attraverso la sua ricerca cercherà di penetrare i segreti della loro tecnica, “perseguendo per impossessarsene, la parola rara e l’espressione insolita.” Nel luglio del ’59 Renè, Marguerite e Thérèse De Gas sono a Napoli. Edgar sente molto la mancanza dei fratelli e specialmente delle due sorelle che sono diventate le depositarie delle sue confidenze. Nel marzo del 1860 intraprenderà un nuovo viaggio in Italia. E’ a Napoli dal 21 marzo al 2 aprile, qui dipingerà una Veduta di Napoli, dopodiché sarà a Firenze dallo zio Bellelli al quale farà un ritratto. L’opera di Degas più di altri artisti del suo tempo, è inscindibilmente connessa alle diverse tecniche da lui stesso utilizzate. Per i dipinti fa uso del pastello come dell’acquerello. Utilizza gouaches e colori a olio. Per le sue sculture cera, bronzo con l’aggiunta di altri materiali, quali la stoffa. Le diverse scelte sono motivate dal significato stesso delle opere che nello stesso tempo contribuiscono a determinare. Mai soddisfatto del suo lavoro, Degas sperimenta i più disparati procedimenti, andando anche alla ricerca di quelli usati dagli artisti dell’antichità. Anche nel suo metodo di lavoro Degas è estremamente scrupoloso. Esegue sempre molti disegni e studi preparatori e rielabora continuamente l’idea di base del dipinto finchè non ha assunto la sua forma compiuta, che non deve lasciar spazio alla minima incertezza, alla minima imprecisione. Nonostante l’aspirazione a una qualità istantanea dell’immagine, Degas non è un pittore che esegue di getto. Negli anni ’70, sviluppa la tecnica del monotipo, suggeritagli dal pittore Lepic: consiste in un disegno eseguito coprendo completamente d’inchiostro grasso nero una lastra di rame sulla quale si lavora con una spazzola dura o con uno straccio per dosare la luce e le ombre. Successivamente la lastra viene pressata su un foglio, ottenendo un’unica stampa. Talvolta con l’inchiostro rimasto sulla lastra Degas esegue una seconda stampa che risultando più chiara della prima, viene rialzata a pastello. Lavora anche con l’acquaforte ed esegue incisioni per cui usa anche la carta giapponese. Ma la tecnica che predilige è certamente il pastello, a cui ricorrerà di preferenza nella maturità, quando la vista gli si indebolirà gravemente. Non è possibile capire Degas senza conoscere le opere composte con questa tecnica, in cui la forma viene completamente frammentata, sbriciolata, dissolta, proprio in opposizione ai risultati dell’arte fotografica e alla superficie formalmente perfetta. Sperimenterà anche tecniche miste, unendo il pastello alla tempera, al guazzo e alla pittura. Tutta la produzione pittorica degassiana è accompagnata fin dagli esordi, sostenuta da numerosi studi e bozzetti scolpiti in bronzo. Attraverso la produzione scultorea, Degas ha modo di penetrare nella struttura stessa del movimento umano o animale. Quindi la scultura è elaborata e utilizzata sia come espressione artistica valida per se stessa , sia come studio preparatorio per opere che vengono poi realizzate con tele e pennelli. Il suo esordio nella scultura avverrà tardi nel 1881, quando viene esposta la sua ballerina di quattordici anni alla sesta mostra degli impressionisti. L’esposizione della ballerina sconvolge la critica del tempo:-“La ballerina di quattordici anni è uno degli apici della scultura, pur essendolo della pittura e del disegno. In più è qualcos’altro che non ha un nome.
E’ una sorta di mummia allucinante; e nondimeno è la vita stessa. Nel tempo stesso un abbozzo e un punto d’arrivo. E’ la perfezione assoluta”. E ancora un altro giudizio:-“ Degas ha capovolto le tradizioni della scultura come ha da tempo scosso le convenzioni della pittura. Raffinata e selvaggia a un tempo , con il suo ingegnoso costume e le carni colorate che palpitano questa statuetta è il solo tentativo veramente moderno che io conosca, nella scultura”. Una delle fissazioni di Degas riguardava il problema conservativo della sua arte: -“Il lato materiale dell’arte lo preoccupava molto, e cercava il miglior mezzo o la migliore sostanza fissativa, la miglior tela o la migliore preparazione, peraltro senza mai arrivare a una soluzione definitiva. Tutta la sua vita è trascorsa in ricerche, sia in campo estetico sia in campo tecnico, per ciò che riguarda l’arte. Non si lasciava scoraggiare né dalle difficoltà né dai problemi che incontrava. Al contrario, gli piaceva affrontarli, e, forse, se non fossero esistiti, li avrebbe creati: “Felice me, che non ho trovato il mio stile, cosa che mi farebbe imbestialire!”, proclamava”. Troverà la sostanza fissativa sognata per i suoi pastelli grazie a un italiano, Chialiva. Questi gli procurerà la ricetta ancora oggi sconosciuta, che gli permetterà di consegnarli all’immortalità. “ I suoi pastelli diventarono fuochi artificiali dai mille colori, dove si dissolveva ogni precisione di forma in favore di una materia sfavillante di hachures”. La produzione Degassiana riguardante il soggetto paesistico è senz’altro la meno nota. La sua pittura è fatta di luci artificiali, di rappresentazioni di interni, di scene della vita moderna e di studi sul movimento. L’En plein air non interessa Degas che dichiara : -“Un dipinto è prima di tutto un prodotto dell’immaginazione dell’artista, non deve mai essere una copia. Se, in seguito, può aggiungere due o tre tocchi di natura, evidentemente non fa male. L’aria che si vede nei quadri dei maestri non è un’aria respirabile”. Molto interessante, in quest’ottica appare la serie dei piccoli paesaggi dipinti a Napoli e lungo il corso della penisola. I sui paesaggi saranno definiti “immaginari”. La sua tecnica sviluppata nei paesaggi arriva a vertici di lirismo raramente raggiunti nell’arte del suo tempo. Le immagini sono volutamente indefinite: Degas, non è interessato a una resa realistica della natura ma alle suggestioni interne che essa suscita. “Dai primi mesi del suo apprendistato artistico all’ultima decade della sua vita, Degas produsse paesaggi con ogni tecnica a sua disposizione e quasi in qualsiasi scala. Nei suoi primi vent’ anni, fece disegni di panorami francesi ed italiani, alternando acquarello, incisioni, olio su carta e su tela. Ammiratore dichiarato di Claude ( Lorrain), Corot e dei paesaggi di Fromentin e Delacroix, Degas fece il suo debutto professionale con un gruppo di grandiosi dipinti di storia, ognuno ambientato all’aria aperta…”. Gli influssi dell’arte napoletana nella formazione degassiana, sono rintracciabili nella riforma Palizziana- Morelliana di metà Ottocento. La riforma delle arti a Napoli interessa Degas sin dalla data del suo primo viaggio ( 1854). La sua è una mente ricettiva e sensibile al nuovo. Nell’ambiente artistico napoletano sa destreggiarsi magnificamente. E’ interessato all’arte di Filippo Palizzi :- “Filippo deve aver conosciuto a Napoli, dove spesso veniva a lavorare, il Degas. Edgar Degas ha avuto contatti frequenti e diretti con la pittura napoletana, è accertato… che nel 1854 egli era a Napoli, e probabilmente vi era da molto, se potè prendere contatto con il “Reale Istituto di Belle Arti” e i corsi di Mancinelli, per il disegno, di Camillo Guerra per la pittura, di Tito Angelini per la scultura e di Gabriele Smargiassi per il paesaggio. Se si escludono il Somarè e il Biancale, nessuno mi sembra- ha tentato di approfondire questi legami tra una delle più grandi personalità dell’arte moderna e gli artisti napoletani. Si può tuttavia affermare che tra Palizzi e Degas i rapporti dovettero essere assai frequenti e le tracce si trovano sia nelle opere del pittore francese sia in quelle del pittore abruzzese molti studi eseguiti da Filippo, per il grande quadro Caccia alla volpe della collezione Marzotto – opera datata 1850- hanno un cipiglio elegante che ritroveremo in certe opere del Degas”. Degas incontrerà di nuovo i Palizzi a Parigi in occasione dell’esposizione universale, del 1855, Giuseppe Palizzi vi espone Une vendange, della collezione Franco Russo. Un’opera concepita a Napoli in compagnia di Filippo, infatti è sorprendente la somiglianza con il naturalismo di un altro dipinto di Filippo Capre in pastura della raccolta Tommaso Leonetti di Napoli. Questi sono gli anni più fecondi non solo per Filippo e Giuseppe, ma anche per gli altri due fratelli Nicola e Francesco Paolo. Sono evidenti i contatti dei Palizzi con Degas e la pittura francese. Ciò rende Filippo più sicuro e comprende la validità del suo nuovo indirizzo artistico :-“ L’interesse che la pittura di Giuseppe offriva a Filippo è appunto nella rivelazione di questo nuovo mondo di luce e di atmosfera che, agendo sul suo spirito già predisposto, ne stimola la maturazione, gli dà sicurezza e coscienza di sé, lo rende atto a porsi alla testa del rinnovamento della pittura napoletana”. Della napoletanità di Degas ha parlato come già accennato Paul Valéry:-“ arte napoletana , perché secondo una comune idea del partenopeismo , espressiva di movimenti, mimetica e vivente ma il Valéry, enunciata un’ipotesi sostanzialmente vera sul carattere napoletano dell’arte di Degas, trascura d’analizzare la vera portata del mimetismo napoletano come costitutivo in nuce, d’essa”. Lo storico dell’arte Michele Biancale accende dubbi e perplessità sul vero significato delle parole di Valéry e continua:-“ Prima del Valéry che, come s’è visto, trova il fondamento del carattere napoletano di Degas nella mimica e nel gestire meridionali nessuno, o quasi di tutti i monografisti del pittore, pur notando la sua presenza a Napoli e in Italia nel periodo giovanile in cui le sensazioni si formano e si fissano in modo indelebile, dà seguito a tale fatto come se fosse puramente incidentale, niente affatto importante e senza sviluppo”. Soltanto il Blanche scrive:-« Ce Parisien éléve à Naples voit l’homme et la vie contemporaine avec l’oeil d’un moderne et d’un italien du Xv siécle ». Interessante il discorso, mi trova del tutto d’accordo. Degas si è sempre espresso in vernacolo napoletano lasciando i suoi contemporanei francesi stupefatti. La radice della sua arte è differente, più lontana dal terreno di cultura parigino. Quindi a voler escludere o ridurre :-“ il pariginismo dell’arte o almeno dai principi dell’arte di Degas c’è da muovere contro una barriera quasi insormontabile di giudizi ormai definiti, di opinioni generali, di nazionalismi col pennacchio, anche perché la vita parigina di Degas, l’amore per quella metropoli, la sua curiosità quasi maniaca per alcuni lati di essa ne ha fatto l’artista più rappresentativo di tipi, d’usi, di costumi. Biancale avverte che ciò avviene anche per De Nittis e per Boldini considerati i pittori della vita moderna parigina e aggiungo amici di Degas. Tra i primi biografi di Degas, Paul Lafond, dopo aver precisato “che nel 1856 l’artista era in Italia, aggiunge: “ il venait d’atteindre ses vingt- trois ans et nous savons qui il avait une partie de sa famille a Naples” ma avverte prontamente: “il connaissait deja son metier de peintre”. Biancale è scettico e continua :- “… biografi minuti e precisi come il Lafond i quali sarebbero pure tratti al riconoscimento d’un influenza italiana nella formazione di Degas, la respingono come un pericolo da scongiurare”. Oserei aggiungere che Lafond si sbaglia anche sulla data del primo viaggio di Degas a Napoli. E’ il 1854 la data esatta del suo primo viaggio nella città partenopea, ha vent’anni, e si trova riscontro di ciò in uno dei suoi primi taccuini, conservati alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Quindi in questa data, Degas non può conoscere appieno “son metier de peintre”. A Napoli come Lafond sa benissimo, Degas ritorna spesso in quanto suo nonno e gli zii lo ospitano frequentemente. Degas prima a Napoli dove va e viene di continuo, poi a Roma e nel ’57 a Firenze cosa che Lafond mostra di ignorare come pure afferma Biancale:- “ e dove dipinse La famiglia Bellelli di cui fu ospite per circa un anno, Degas dunque sarebbe stato refrattario ad influenze d’arte italiana recente e antica perché quel discepolo di seconda mano d’Ingres che è il Lamothe, che aveva sacrificato all’Olimpico la lezione appresa da Ippolyte Flandrin , gli avrebbe trasmesso l’inalterabile e insostituibile influenza di Jean Dominique, persino gli studi dal Mantenga e da Leonardo sembrano nel giudizio dei biografi quasi un impiego del tempo nei suoi ozi italiani, una forma di dilettantismo. Tutto in Degas andrebbe riportato all’iniziazione d’Ingres”. E’ Biancale ancora a scrivere:- “ Ora Degas è per temperamento un esotico a Parigi. La differenza… tra lui e Manet è assai probante. Si sente che il carattere di Degas non è di genuina lega francese. La cosa è avvertita anche dal Lafond, il quale scrive: « Le antécedents héréditaires de Degas sont pour surprendre au premier abord. Son atavisme familial le destinait assez mal, semble-t-il, a devenir le parisien par excellence qui il fut, bien que nè d’un napolitain et d’un americaine ». Codesto figlio di un napoletano e nipote di una genovese ha mescolato in sè sangui differenti, e quello della madre rincalza, se possibile, il suo carattere meridionale”. Osserva concretamente, fino in fondo, la vita moderna per riportarla sul piano dell’arte. Nessuno degli impressionisti rappresenta meglio di lui “tipi, usi, forme di vita sociale. Degas non trascurava neppure i pittori italiani che vivevano a Parigi. Per non ricordare i suoi rapporti cordiali con De Nittis, generalmente noti, con Boldini fu alcun tempo in buone relazioni, ma il Lafond ci assicura che dopo un viaggio in comune i due, separatisi alla stazione, non si rividero più. Col pittore Chialiva esperto di tecniche pittoriche discuteva a lungo di procedimenti coloristici di vernici e di fissativi per i suoi pastelli”. A questo punto sorge spontaneo il desiderio di accertare quali siano gli artisti napoletani che hanno lasciato un segno indelebile nella sua arte. Ci pensa ancora Biancale che scrive:-“ Il Russo-Cardona che mi fornì molte notizie sulla permanenza a Napoli del Degas, e la cui moglie era la cugina dell’artista ( Biancale si riferisce alla cugina Camilla Montejasi, figlia della zia Fanny e moglie dell’ingegnere Pasquale Russo-Cardona), m’assicura che questi con i parenti abitava a Pomigliano D’Arco (località poco distante da Napoli, dove probabilmente Degas soggiorna a casa di zia Fanny) e che si recava a Napoli per acquistarvi colori e per visitarvi i Musei e qualche esposizione”. A questo punto Biancale formula l’ipotesi :-“che Degas, curioso d’arte e d’artisti, conobbe la riforma naturalistica di Filippo Palizzi il quale proprio in quegli anni andava dipingendo cavalli e cavalieri e insomma quelle scene di corsa che tanto doveva in seguito dipingere Degas?…sarà forse eccessivo pensare che anche Domenico Morelli dovette richiamare la sua attenzione? Se così non fosse, mi domando perché tutti coloro che videro nella Biennale del 1934 quel quadro di Degas, che rappresenta La duchessa Montejasi con le due figlie Elena e Camilla, zia e cugine dell’artista, pensarono con singolare e umana spontaneità al Morelli e in genere a scuola napoletana il cui spirito sembra soffiare nell’opera dipinta a Pomigliano d’Arco, da Degas giovine con signore e signorine d’un alta borghesia partenopea e con i caratteri inerenti a tale casta sociale”. La novità di questo dipinto aggiunge Biancale consiste “nella disposizione di più ritratti in un ambiente domestico, ove i napoletani per solito ponevano un personaggio isolato. Erano in ciò le prime avvisaglie Goyesche operanti con notevole anticipo sul giovane pittore, prima di Manet e di Renoir che dovevano, specialmente Manet, riprendere da Goya assai più il procedimento di un dipingere piatto che non i motivi di un comporre profondo e monumentale. Degas era intentissimo alla definizione dell’ambiente e del carattere dei personaggi che vi poneva nel quadro dipinto a Pomigliano d’Arco, ambienti e caratteri sono definiti in modo supremo”. La duchessa Montejasi con le due figlie, esprime una certa libertà nella composizione rispetto all’altro La famiglia Bellelli, “ tutto è più sommario e più libero c’è minore preoccupazione di un disegno visibile e maggiore impegno di un dipingere sfrangiato e aperto. I neri hanno una grana morelliana compatta su cui si staccano i grigi e i bianchi, più materialmente freddi nel napoletano più mordenti e alitanti in Degas, il fondo a tocchi e a strie, esatto nei rapporti e, fuori dell’amorfismo dei fondi uniti, respirante e vivente è tipicamente morelliano”. Aggiungerei ulteriormente di aver trovato il dipinto della Duchessa Montejasi molto somigliante ad un dipinto di Filippo Palizzi, La Marchesa Cimino. Entrambe le nobildonne sono simili nella posa, nel gesto delle mani raccolte sul grembo, nello sguardo. Oserei dire che le due donne sembrano quasi delle sorelle. Biancale continua:-“ Se questi ebbe mai curiosità di conoscere l’indirizzo del Regio Istituto di Belle Arti di Napoli non potè che riscontrarvi un insegnamento quasi parallelo a quello che si praticava a Parigi dai discepoli dell’atelier d’Ingres. Era da poco morto a Napoli Costanzo Angelini, nel 1853, che a Roma era stato collega d’accademia… di David, dal quale aveva potuto desumere e di prima mano,quel neoclassicismo che poi Degas doveva riprendere di seconda mano, dal Lamothe. L’Angelini con esso aveva posto, un saldissimo fondamento all’insegnamento del Regio Istituto, neoclassicismo puro che il nuovo titolare della cattedra di disegno Giuseppe Mancinelli tendeva a spostare verso idealità di Cinquecento e Seicento italiani che già si disponeva a diventare romantico storico in Morelli…”. Biancale trova altri riferimenti come Caravaggio, a cui Degas potrebbe essersi ispirato per il quadro Mademoiselle Fiocre dans le ballet de la Source “ se non proprio con le intenzioni costruttive, nel senso della luce del grande maestro”. Ma chi può conoscere fino in fondo ciò che ha impressionato Degas dei maestri antichi e dei contemporanei? Quelli conosciuti a Napoli, a Roma, a Firenze? Sono d’accordo con Biancale quando afferma “ che Degas non ignorò neppure la grandezza monumentale di Piero della Francesca”. Se ne trova traccia nel dipinto Semiramis élevant les murs de Babylone “ per quel senso prospettico e metrico che le figure rivelano e per quel cavallo, vero Palladio, di così differente concezione da quello caravaggesco”. Tutto questo non può certo derivargli da Puvis de Chavannes, il quale non amava il Rinascimento italiano, “ci par di sognarecontinua Biancale- quando leggiamo nel Lafond e negli altri biografi del Degas che questo perpetua l’arte schiettamente francese di Watteau, La Tour, Chardin, Fragonard,e che il suo amore per Poussin nasce dalle qualità di luce, d’ordine, di grazia austera, seria e malinconica, qualità che sarebbero “ les revanches de l’esprit francais sur les tendances italiennes”. E chiaro che il Lafond ignora, la formazione del Seicento e Settecento francesi. Così non insisterebbe a proposito di Degas, sul carattere genuinamente francese della sua arte, e andrebbe più cauto nel qualificare tale influenza per non incorrere nell’errore di attribuire a quei maestri francesi caratteri peculiari che per giudizio unanime sono considerati di derivazione schiettamente italiana, specie in Poussin”. Biancale contesta anche la discendenza da Ingres di Degas, in quanto nel maestro di Montauban vi scorge “ solo una purezza, una fermezza disegnativa, un equilibrio compositivo, un senso di stile sintetico, una somma infine di qualità che Ingres aveva appreso dal Cinquecento italiano nel quale ritrovava un impianto classico reso più espressivo dal carattere lineare del disegno formale”. Tutto fa pensare un “Degas italiano di sangue e di formazione artisticacontinua Biancale – attento… ai valori di contenuto e a quelli formali… fuori dalle ubbie di un impressionismo che s’esaltava d’un falso Plen-air ch’egli derideva, d’una pittura pura ch’egli non giustificava, almeno in quel modo, e d’una impassibilità espressiva ch’egli non accettava”. Ma ritorniamo a Napoli, non soltanto come scrive Paul Valery, “ perché il popolo napoletano gestisce e adopera la mimica espressiva, ma per ragioni puramente artistiche profonde che toccano il più grande Degas- scrive Biancale. Ma non vi sembra tipicamente meridionale quella sua aderenza alla vita sociale, quel suo interesse per ballerine, lavandaie, stiratrici, donne equivoche, piccole borghesi, cantanti di caffè concerto, modiste e via dicendo? Chi aveva mai pensato a ciò a Parigi? E Degas diceva non senza una punta d’umorismo che per il fatto che gli altri non se n’erano accorti egli aveva potuto dipingere simili soggetti. Non se n’erano accorti? Non si trattava di richiamo occasionale, esteriore; ma di disposizione naturale a sentirli come motivi d’arte”. Degas è un acuto osservatore, questo lo porta a confondersi con la folla degli omnibus parigini per osservarla, in ciò giustifica “ la sua posizione spirituale ch’è tipicamente meridionale” afferma il Biancale. “Artisti napoletani hanno trattato motivi simili a quelli di Degas, come Toma, Dalbono, Migliaro, Mancini Giovane. So bene che il Somarè…ha stabilito alcune connessioni tra l’arte italiana e quella francese ma piegherebbe a carattere toscano macchiaiolo quello della pittura giovanile di Degas, che io interpreto come vagamente napoletana”. Sono d’accordo anche su questo punto con Biancale. Si ritrovano punti di contatto con l’arte italiana anche quando Degas comincia a dipingere cavalli da corsa e fantini. Degas, spiega Biancale non si rifà a De Nittis o a Fattori, quando più indietro nel tempo a Filippo Palizzi. I pesanti cavalli maremmani dipinti da Fattori non possono attirarlo, stagliati su terreni aspri sotto cieli tersi, statici nella loro solennità, non possono accendere in Degas il senso del movimento totale e continuo. Lo ricerca nel galoppo dei purosangue e nella danza delle ballerine, tra le quinte dei caffè concerto e sui campi da corsa. A questo senso del movimento-“ rispondeva meglio il principio palizziano d’un disegno continuo e vibrato, vivente sotto o dentro la massa cromatica e non cristallizzato esteriormente nelle partiture ad incastro. Le adunate palizziane di cavalli e di cavalieri, come nel quadro della collezione Marzotto, cavalli di razza, già studiati nei loro atti più aderenti ad un determinato movimento, cavalieri di classe, certo borbonica, in stivaloni e cilindro,rappresentativi di un’epoca dico che coteste adunate di caccia costituiscono l’antefatto delle rappresentazioni di corse di Degas”. Biancale accosta il quadro Le viol di Degas ai dipinti d’interni di Gioacchino Toma, “Per Le viol basterà rifarsi alle camere delle pitture del Toma giovane intorno al 1862, nelle quali poneva le sue orfane, o ai piedi del letto o dinanzi ai cassettoni a rimembrare persone care scomparse, e basterà notare l’onda luminosa che soffia e pulsa quasi ad un modo negli interni dei due per darsi conto d’una disposizione, in loro quasi similare”. Riportando il discorso a Paul Valéry, il quale riconosce nella mimica e nella gestualità partenopea il fondamento dell’arte degassiana e vi riconosce non solo la gestualità del napoletano, ma anche la caratterizzazione sociale e professionale del napoletano stesso. “ Non è già una specie di mimetismo rivelatore nei napoletani dei loro sentimenti, che consiste l’arte di Degas ; ma nel cogliere nelle varie attitudini, socialmente classificabili, quelle che distinguono, la ballerina dalla modista, dalla lavandaia, dal suonatore d’orchestra, dalla donna in pensione, dal fantino di corsa e via dicendo. E’ dunque un’interpretazione della mimetica professionale di costoro. Entro cui si definisce il carattere di ciascuna di queste caste umane, che va inteso il gestire napoletano di Degas; e non altrimenti. La facoltà che hanno i napoletani di esteriorizzare il loro sentimento in espressioni di volto, di braccia, di mani, li porta certo a capire un simile atteggiarsi di sentimenti, o di abitudini, in altri; e li porta alla caratterizzazione d’esse. E’ come un istinto profondo; e Degas lo ha; e lo ha da Napoli”. Ma ciò che caratterizza la napoletanità di Degas è la sua ricerca non “d’un gesto naturale ma di quello acquisito per la necessità d’un mestiere,che classifica una casta o un tipo d’umanità poiché per un meridionale, l’uomo non esiste nella sua accezione astratta ma si concreta in una professione o in un mestiere, nel senso che il meridionale non vede nell’uomo un uomo, ma un uomo in funzione della sua attività. Dal guardaportone all’Eccellenza c’è una serie di attività che il napoletano non omette di speculare, di classificare, di nominare. Dirò di più: il napoletano, per uso finisce col dimenticare i nomi delle persone che deve praticare e le rimembra con un titolo c’egli sa come distintivo d’esse. Il dottore, il professore, il notaio, l’avvocato,tengono per lui il luogo del loro stato civile”. Mi accodo a Biancale, e guardando i ritratti che ha dipinto Degas non posso non essere d’accordo con lui. “Non quelli anonimi, ma quelli cui ha inteso dare un nome: quello di de Valernes, del chitarrista Pagans, del visconte Lepic, di Desboutin ( l’assenzio ) ”. Degas supererà questa classificazione per “ tramutarsi in un vero pittore di gesti. L’enorme serie delle sue danzatrici e delle sue corse di cavalli lo riportano alla notazione elementare del gesto in che sembra esaurire tutte le sue possibilità di osservatore. Così intesa l’arte di Degas si rivela chiaramente di stacco e d’impronta italiana, e precisamente napoletana.” Sono d’accordo, in massima parte con l’enunciato di Biancale. Come sono sicura degli inizi napoletani dell’artista. Un Degas di sangue italiano, ma anche di formazione artistica. Ha sempre considerato Napoli un po’ sua, così come le altre città italiane in cui ha vissuto. Napoli è stata un po’ come il primo amore, ha rappresentato il punto di partenza della sua arte, prima ancora di altre città d’Italia. Ora non c’è più incertezza sul suo percorso artistico. Grazie alla generosità del Musée d’Orsay, dell’Art Institute di Chicago e del Cleveland Museum of Art i visitatori potranno ammirare riuniti in mostra cinque celebri capolavori del ‘Degas napoletano’, oltre all’emblematica ‘Veduta di Castel Sant’Elmo da Capodimonte’ del Fitzwilliam Museum di Cambridge, rarissimamente esposta. Seguendo lo svolgersi delle varie correnti culturali ottocentesche, la mostra dedica tre sezioni decisive alla tematica dell’immaginario storicista neo-pompeiano che reinventa temi o diffonde lo stile dei manufatti rinvenuti nelle città sepolte, dell’immaginario idealista neo-greco, intriso di evocazione ed elegia, e l’immaginario orientalista, che tanto fascino suscitò in Domenico Morelli. Il passaggio e le contaminazioni tra pittura accademica e pittura realista, intorno alla metà del secolo, sono descrittecon attenzione fino al confluire nelle arti figurative di tematiche veriste che nell’affermare il principio di realtà fino all’estremo riflettono le istanze di denuncia sociale proprie della seconda metà del secolo. Il percorso dall’accademismo al realismo trova, al culmine della sua progressione verista, un approdo a soluzioni di disfacimento dell’esattezza figurativa ottenuto con il prevalere degli aspetti materici della pittura nelle opere di Antonio Mancini. Nell’ottica di queste “contraddizioni” legate alla realtà, è la materia stessa che diviene oggetto della pittura e della scultura, annullando le differenze tra l’una e l’altra attraverso effetti violentemente materici che trovano un paragone solo nella ricerca di Medardo Rosso e che di fatto anticipano di diversi decenni quelle qualità tipiche della stagione ‘informale’del dopoguerra, in artisti come Fontana o Burri. Nel XIX Napoli è a tutti gli effetti riconosciuta anche come un’importante capitale scientifica, terza città d’Europa, dopo Londra e Parigi, sede di una delle più antiche università italiane, della prima scuola di lingue orientali in Europa (fondata nel 1732), del primo museo di mineralogia (fondato nel 1801) e di molti altri centri di studio o istituzioni per la ricerca e lo studio. È anche la città dei dibattiti positivisti, delle scienze giuridiche e matematiche, è la città dell’intensa dialettica che lega le nuove scienze a un’estetica sempre fedele alla grande tradizione realista, centrale nella definizione dell’arte napoletana dal periodo barocco riberesco e caravaggesco. All’interno del percorso espositivo si è voluto restituire al visitatore, attraverso la video installazione Affreschi Digitali dell’artista napoletano Stefano Gargiulo (Kaos Produzioni),la peculiarità della Stazione Zoologica voluta da Anton Dohrn, primo centro di studio oceanografico in Italia, dove raffigurazioni scientifiche della fauna marina si sovrappongono alle decorazioni di Hans Von Marées e Adolf Hildebrandt ancora visibili nell’attuale Biblioteca e ispirate al gusto neo-ellenico caro agli artisti tedeschi dell’epoca. Nel primo quarto del XX secolo, Antonio Mancini, all’apice della fama internazionale, consente alla materia grezza di entrare nei suoi dipinti; è la materia, prorompente, invasiva e privata di forma che si fa oggetto stesso dell’opera, sostituendosi al soggetto ritrattato. Una scelta che venne celebrata alla Biennale di Venezia del 1926, dove la Dama in rosso di Mancini venne salutata da Carlo Carrà come “un vero capolavoro di potenza plastica e di armonia cromatica”. Anche l’influenza del clima politico ed economico ha avuto un ruolo decisivo sulle forme d’arte di questo periodo storico. La profusione di progetti e programmi di trasformazione urbanistica della città, infatti, la rendono sempre più europea tanto che, alla fine del secolo, Napoli dialoga ancora direttamente con Parigi: in soli tre anni viene eretta la Galleria Umberto I, vengono costruiti i caffè, i grand hotel, i quartieri borghesi ed i lunghi viali. Il percorso “dal Sublime alla materia” diventa in mostra uno schema di lettura della storia dell’arte a Napoli nell’Ottocento. Per questa ragione, tale percorso è oggetto di un ulteriore intervento multimediale dello stesso Gargiulo che accoglie il visitatore sullo scalone d’entrata proponendo le immagini del Vesuvio in eruzione intese come sintesi dei tue termini: il sentimento del sublime che deriva dallo spettacolo della forza terribile della natura, e la brutalità materica del paesaggio lavico che si trasforma in bellezza. “Napoli Ottocento”rappresenta la sintesi di questo lungo percorso, un’occasione unica per ammirare opere di altissimo valore e per comprendere a pieno un periodo ricco di contraddizioni e di fascino. Accompagna la mostra il Catalogo Napoli Ottocento. Degas, Fortuny, Gemito, Mancini, Morelli, Palizzi, Sargent, Turner edito da Skira .
Scuderie del Quirinale Roma
Napoli Ottocento. Degas, Fortuny, Gemito, Mancini, Morelli, Palizzi, Sargent, Turner
dal 27 Marzo 2024 al 16 Giugno 2024
dal Lunedì alla Domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00




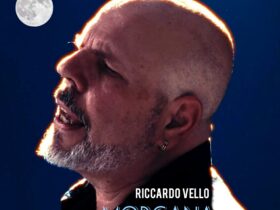






Leave a Reply