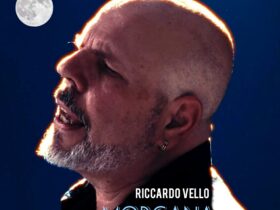Giovanni Cardone
Fino al 14 Luglio 2024 si potrà ammirare a Palazzo Buontalenti Pistoia la mostra ’60 Pop Art Italia a cura di Walter Guadagnini. L’esposizione è realizzata da Fondazione Pistoia Musei e Fondazione Caript con il sostegno di Intesa Sanpaolo, con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Pistoia, la collaborazione di Visit Pistoia e Consorzio Turistico della Città di Pistoia. La rassegna presenta 70 opere che ricostruiscono le vicende della Pop Art in Italia, attraverso i suoi maggiori esponenti, tra cui Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Mimmo Rotella, Mario Ceroli, Pino Pascali, Fabio Mauri, Jannis Kounellis, Renato Mambor, Titina Maselli, Giosetta Fioroni, Laura Grisi, Enrico Baj, Valerio Adami, Emilio Tadini, Michelangelo Pistoletto, Ugo Nespolo, Piero Gilardi, Concetto Pozzati, Roberto Barni, Umberto Buscioni, Adolfo Natalini e Gianni Ruffi. Prestigiosi i prestiti che provengono da alcune importanti istituzioni pubbliche come la Galleria d’Arte Moderna di Palermo, la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, il Mart di Trento e Rovereto, i Musei Civici Fiorentini, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e da collezioni private di statura istituzionale come quella di Intesa Sanpaolo o da gallerie e collezionisti che possiedono alcuni capolavori di questi artisti. In una mia ricerca storiografica e scientifica sul fenomeno Pop Art e che influenzò anche l’Italia apro il saggio dicendo : Quello dell’arte contemporanea è stato ed è tutt’ora un periodo connotato da numerosi cambiamenti e da forti spinte innovative. In quasi centocinquant’anni, dall’Impressionismo ai giorni nostri, si sono succedute senza soluzione di continuità numerose rivoluzioni stilistiche e formali, nonché tematiche. L’invenzione di nuove tecniche, dal collage ai videoambienti sensibili, unita a una concezione estetica mirante al definitivo superamento della tradizione, hanno mutato il modo di creare le opere d’arte. Attraverso procedimenti extra-artistici, i supporti tradizionali sono stati sostituiti da altri meno convenzionali; la tela è stata soppiantata dal cartone, la tavola dalla lastra in acciaio inox, il blocco di marmo dai materiali industriali. Questo stravolgimento delle dinamiche teoriche e pratiche ha contribuito anche alla metamorfosi della figura dell’artista che, inserendosi in un contesto di generale sovvertimento dei valori tradizionali ha cercato, in più occasioni, di rinnegare quanto prima di lui era stato realizzato. L’età contemporanea ha visto la nascita di correnti artistiche che miravano a chiudere definitivamente ogni rapporto con il passato; prima le avanguardie storiche, successivamente i movimenti neoavanguardisti, hanno portato avanti un processo di progressiva desacralizzazione dell’arte attraverso una sistematica distruzione degli impianti stilistici e formali e un radicale sovvertimento delle regole estetiche, a partire dall’iconoclastia dei futuristi e dadaisti, fino ad arrivare alla “morte dell’arte”, professata dagli esponenti dell’Arte Concettuale. Contemporaneamente, e nonostante questa apparente volontà di distruzione, si registra nello stesso periodo una tendenza a mantenere i contatti con la tradizione, a fare riferimento all’esempio dei grandi maestri. Questa esigenza di riallacciarsi al passato, che non verrà meno neanche nei momenti di più accesa contestazione avanguardista, rappresenta una costante nell’arte contemporanea, oggetto negli ultimi anni di ricerche approfondite da parte di studiosi e critici . Il recupero della tradizione pittorica italiana, che si può considerare tra i più praticati dagli artisti del XX e XXI secolo, incontra particolare fortuna negli anni Sessanta del Novecento. Nel contesto artistico internazionale del decennio, caratterizzato da un generale e progressivo allontanamento dall’arte Informale, sancito dall’affermazione della Pop Art e dal definitivo spostamento del baricentro culturale dall’Europa agli Stati Uniti, è in particolare Roma la città che dimostra una maggiore sensibilità nei confronti della pittura del passato. Proprio nella capitale, dove sin dagli anni Cinquanta si nota uno stretto contatto con l’ambiente artistico di New York , si vengono a creare le condizioni per la nascita di una particolare declinazione italiana della Pop Art basata anche sul reimpiego oggettivo dell’iconografia del passato che si concretizza nelle vicende della “Scuola di Piazza del Popolo”. Non si può parlare di un’autentica Pop Art italiana, così come non si può parlare di una francese, tedesca o spagnola. Il movimento pop, la cui storia generalmente si fa iniziare nel 1956 e terminare nel 1968, è un fenomeno prevalentemente americano, una corrente “made in USA” nonostante la sua nascita ufficiale in Inghilterra con l’Independent Group, guidato dal critico Lawrence Alloway e dagli artisti Eduardo Paolozzi e Richard Hamilton . Strettamente legata al contesto socio-economico statunitense, l’arte pop si caratterizza per il suo intento di mettere in mostra i «“miti del quotidiano” espressi dalla cultura del consumo, dei mass media e dell’euforia tecnologica» , celebrati acriticamente nella maggior parte dei casi come i totem della moderna società. I simboli dell’America capitalista e consumista di quegli anni, dalla bottiglia di Coca Cola al barattolo della Campbell Soup, ma anche le fotografie di Marylin Monroe ed Elvis Presley, sono le metafore della ricchezza economica del presente . Il termine “pop art”, diminutivo dell’inglese popular art, viene usato per la prima volta da Alloway in riferimento ai “prodotti dei media di massa”, divenendo «corrente fra l’inverno 1954-55 e il 1957, in rapporto al lavoro e alle discussioni comuni dei membri dell’Independent Group» e apparendo in più occasioni nei collage e fotomontaggi di Hamilton e Paolozzi. La Pop Art basa la sua forza artistica sulla riconoscibilità dei soggetti o degli oggetti ritratti, che vengono identificati subito dal fruitore il quale «è messo in condizione di riconoscere i volti e le cose e le scritte» . La celebrazione della società contemporanea si concretizza, a livello di rappresentazione artistica, nell’abbandono della visione intimista, tipica dell’Espressionismo astratto e in generale dell’intero movimento informale, a favore di una più oggettiva osservazione della realtà, con un recupero totale della figuratività. Contestualmente, la maggior parte dei pop-artists inizia una produzione in serie delle proprie opere, rivolgendo sempre più spesso l’attenzione verso il mondo industriale. Il passaggio da una concezione all’altra è mediato dal New Dada che costituisce un momento di transizione tra le due tendenze, espressionistaastratta e pop. Esponenti di punta sono Robert Rauschenberg e Jasper Johns, che nella prima metà degli anni Cinquanta uniscono a un’impostazione pittorica ancora legata all’Espressionismo astratto una componente oggettuale, elevando l’oggetto d’uso comune a forma d’arte e inserendo nelle loro opere elementi tipici della comunicazione di massa, quali scritte, fotografie, ritagli di giornali, manifesti8 . Sulla scia dell’assunto dadaista della coincidenza tra arte e vita9 , i due pittori introducono oggetti-simbolo della società americana, quali la bandiera a stelle e strisce o la bottiglia di Coca Cola, anticipando quelle che saranno le caratteristiche della Pop Art. La consacrazione internazionale del movimento si celebra alla XXXII edizione della Biennale di Venezia del 1964, quando gli artisti americani approdano nella città lagunare «affondando la flotta locale». A sancire l’affermazione definitiva è anche l’assegnazione a Robert Rauschenberg del Gran Premio della Giuria Internazionale. Forte è l’impatto sulla critica italiana; l’opinione pubblica e non solo gli addetti ai lavori si divide tra estimatori convinti della nuova estetica, portatrice di un rinnovamento delle tecniche artistiche atte all’«impressionamento della fantasia», come afferma Ludovico Ragghianti, e critici altrettanto scettici, come Giulio Carlo Argan, che distingue tra l’arte di Rauschenberg e Johns «con una forza di spinta tutt’altro che declinante nell’area storica dell’Informale», e quella degli altri artisti americani, ritenuta «elemento della propaganda capitalista». Al di là delle critiche e del successivo sviluppo degli studi su questa corrente artistica, è importante rilevare come l’Italia, e più in generale l’Europa, non si sia fatta trovare impreparata all’incontro con la Pop Art. Nel Vecchio Continente, infatti, a cavallo tra il decennio Cinquanta e Sessanta nascono correnti neoavanguardiste che, pur condividendo con il movimento americano alcune finalità artistiche e una comune derivazione dal Dadaismo, differiscono nelle realizzazioni. Il Nouveau Réalisme, movimento francese nato ufficialmente con la mostra intitolata Les Nouveaux Réalistes, tenutasi nel 1960 presso la Galleria Apollinaire di Milano, e seguita da un’altra esposizione l’anno successivo presso la Galerie J di Parigi (Au 40° au dessus de Dada), oppone un deciso rifiuto verso la pittura, preferendo altre tecniche come l’assemblage, il collage, il décollage. Gli artisti pop, al contrario, mantengono una certa preferenza nei confronti del linguaggio pittorico, che interagisce con la fotografia, la scultura e le installazioni. In Italia, invece, si forma già dalla fine degli anni Cinquanta un vasto movimento che, sebbene abbia notevoli punti di contatto con il New Dada e con la Pop Art americani, differisce da essi per il contesto socioculturale nel quale matura e per la scarsa inclinazione alla realizzazione artistica seriale. Per determinare quella che viene tuttora considerata, anche se in maniera molto generale, la “Pop Art italiana”, vengono coniate diverse definizioni, di cui due risultano essere più pertinenti. Maurizio Fagiolo dell’Arco, nel 1966, parla di «figurazione “novissima”», realizzata da pittori alla ricerca di un’arte che sia «fedele al mondo oggettivo e intanto pronta a registrare quanto avviene “dentro”: dalla cronaca si va alla confessione, dalla ricognizione all’ironia per rinnovare la visione del mondo» . Il critico, inoltre, indica nel rapporto con la realtà la chiave d’interpretazione di questa nuova corrente. In precedenza, nel 1963, Maurizio Calvesi aveva parlato di “reportage”, individuando nella pratica del riporto fotografico su tela la cifra stilistica qualificante per gli artisti italiani che, pur assumendo il linguaggio della Pop Art, non se ne servono per «assumere un modo di vita americano».

Calvesi arriva a parlare, per quanto riguarda il reportage, di orientamento “neometafisico”, rivendicando così una matrice europea e italiana del fenomeno artistico. Effettivamente il termine “arte reportagista” definisce nel modo migliore il carattere delle opere realizzate negli anni Sessanta da Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Cesare Tacchi, Mario Ceroli. Tale definizione si può anche adattare al tipo di ripresa della pittura italiana del passato che questi mettono in atto, un recupero oggettivo reportagista appunto basato sulla riproposizione di immagini in gran parte recuperate dal repertorio pittorico italiano con l’ausilio del medium fotografico. Questi artisti fanno parte, a vario titolo, della “Scuola di piazza del Popolo”, anche conosciuta con l’appellativo di “Giovane scuola di Roma”, per distinguerla dalla “vecchia” di Mario Mafai, Antonietta Raphaël e Scipione, nata e sviluppata negli anni Trenta del Novecento. La nascita del movimento romano si fa risalire al 1960 con la mostra dei 5 pittori, allestita presso la galleria romana di Gian Tomaso Liverani, La Salita. La collettiva, cui partecipano i pittori Franco Angeli, Tano Festa e Mario Schifano, insieme agli scultori Giuseppe Uncini e Francesco Lo Savio, è presentata dal critico francese Pierre Restany, che in quell’occasione afferma: «L’épicentre est à Rome e non pas à Milan», sancendo l’affermazione della capitale a discapito della metropoli lombarda. Il gruppo si allarga nel 1963, in occasione di un’altra esposizione, 13 pittori a Roma, tenutasi presso la galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis, gallerista di spicco, con Liverani e Fabio Sargentini, nell’ambiente romano . Al trio Angeli-Festa-Schifano si aggiunge una decina di artisti tra cui Mimmo Rotella, già protagonista del Nouveau Réalisme, Umberto Bignardi, Giosetta Fioroni, Jannis Kounellis, Renato Mambor, Fabio Mauri, Gastone Novelli, Achille Perilli, Peter Saul, Cesare Tacchi, Cy Twombly. In questa occasione si manifestano più chiaramente le affinità con il movimento pop americano, anche se molti dei partecipanti negheranno in più di un’occasione ogni diretta influenza, affermando con forza la propria autonomia rispetto alle influenze artistiche giunte da oltreoceano. L’artista più rappresentativo della Pop Art Italiana è senza dubbio Mario Schifano è difficile mettere insieme Duchamp e la Tv questo lo cerco di evidenziare nella terza edizione del testo “forme estetiche e società di massa”, Abruzzese parla di come fosse stato fondamentale scegliere un collage di Duchamp da mettere in copertina. Parlare di televisione indagando tra gli aspetti tecnici non è la giusta soluzione per spiegare l’interazione che ha avuto l’arte, nel mezzo. Capire invece chi ci ha insegnato a guardarla, aprendo le menti a nuove soluzioni del “vederla”, è invece fondamentale nel momento in cui si decide di indagare sull’ impatto che ha avuto l’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione. Jean Clair , affrontando l’opera “il grande vetro” conclude con il dare dell’ illusionista a Duchamp, che ha saputo creare immagini su immagini, illudendo il grande pubblico con un’opera che si è modificata nel tempo, sia nel contenuto sia nei significati. Questo tipo di visione risulta illuminante quando si parla di cambiamento delle ottiche visive, e di approccio diverso nei confronti di un mondo sempre più subordinato al rapporto teconologia-uomo. Vale la pena ricordare il secondo titolo, o denominazione che Duchamp dà a quest’opera: “La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche”; su questa frase molti critici si sono interrogati, incentivando altrettante nuove critiche e nuove visioni, ed aggiungerei, inconsapevolmente nuove dimensioni nel tempo, mettendo in moto una macchina che forse nemmeno Duchamp immaginava di accendere. Gli aspetti critici del tempo dedicavano il gesto artistico ad un’interpretazione tecnologica dove, appunto la sposa-macchina, diventava funzione biiettiva dello scapolo. Surclassando le critiche più o meno sbagliate incentrate sulla seconda definizione dell’opera e ponendosi di fronte a quest’opera con uno sguardo per quanto possibile “ingenuo”, il “grande vetro” diventa un elemento costituente necessario per affrontare e comprendere la futura “visione” televisiva. Le esperienze risulteranno similari dal momento in cui si elegge una sinestesia tra le due esperienze, continuazione, mutazione, stupore, illusione, emozioni create in momenti diversi, ma fruibili solo in un determinato spazio, riconducibile all’ istante in cui lo spettatore ha un confronto diretto con il “vetro”, esso sia opera o televisione. Rispondendo alla domanda chi ci ha insegnato a guardare la televisione? Si può rispondere Duchamp; lui di fatto ha saputo dare vita all’ottica del futuro contenuto televisivo, che modifica nel tempo, lo riempie di carica allusiva, terminandolo con la rottura in una tanto effimera quanto fondamentale esistenza della stessa. Probabilmente Duchamp non ha mai avuto un’idea precisa di ciò che stava realizzando con “il grande vetro”, ma quasi divertito dalla critica, ha saputo creare all’interno della stessa un tempo che andando oltre a quello produttivo (otto anni di lavoro), si dilatava in un discorso critico-allusivo, non appartenente al canale semantico iniziale, ma in grado di generare delle immagini. Queste immagini critico-allusive troveranno delle corrispondenze analoghe alle immagine affrontate dall’ingenuità di un pubblico televisivo negli anni sessanta. L’immagine televisiva infatti tende ad estendersi e modificarsi in continuazione, relazionandosi dall’approccio dello spettatore televisivo che modifica “passivamente” la propria visione, dipendente e funzionale alla sua cultura. Le analogie continuano pensando a come lo spettatore agisce tra le programmazioni tv, di certo si potrebbe pensare alle opzioni offerte dal telecomando, ma in quanto al caso va ricordato che stiamo parlando del primo spettatore televisivo, che come in relazione al “grande vetro” rotto, ha continuato a relazionarsi con l’opera mantenendo nel suo immaginario un contenuto mutato nella forma, e di conseguenza cambiandone la visione interpretativa nel significato.

Questo processo viene giustificato dallo stesso Duchamp che spiega l’immagine come un contenitore di altre immagini che a loro volta creano più visioni dell’oggetto contenuto nel vetro; per dirla alla Clair, introducendo successive allusioni ad allucinazioni che verranno impachettate poi da una critica incapace di rispondere all’atto non “programmatico” dell’artista, di un messaggio mutante. La direzione utilizzata da Duchamp, nella ricerca dimensionale, sta proprio nello stravolgimento del significato dell’immagine, si pensi all’operazione svolta staccando un orinatoio dal muro, messo in un contesto espositivo chiamandolo “fontana”. Un operazione tanto semplice quanto diretta, che tra le provocazioni, “precipita” nell’ approccio visuale, e si “semplifica” quarta dimensione. La decontestualizzazione dell’oggetto ne incentiva la trasmigrazione di significato che muta, non nella visione, ma nell’allusione intrinseca del ricevente. Guardando un orinatoio il ricevente viene portato a considerarlo fontana, dove, il fenomeno in una differente visione, (processo utilizzato poi nell’arte concettuale), accende nel ricevente l’allusività dei pensieri associativi, che appartenendo al subconscio riflettono sulle analogie esistenti e coesistenti tra i due oggetti in questione, nello specifico: un orinatoio e una fontana. Gli stampi contenuti tra le lastre di vetro, mutano nel significato del discorso, grazie alla critica, divenendo linguaggio scrittorio, quindi provocando un’ estensione e una separazione del senso più neutro della visione come l’ intende Panofsky , in una ricerca dimensionale. Nel 1954, “il grande vetro” viene destinato al Philadelphia Museum of Art , (qui la denominazione dell’opera comincia a mutare), Duchamp infatti, ordina di non denominare l’opera come «quadro», ma «macchina agricola», «mondo in giallo» o «ritardo in vetro». Nelle raccolte di appunti la “scatola verde” e nel la “scatola bianca” Duchamp, (anche se in forma disorganica, oscura e allusiva) tenta di risolvere la questione con il solo incentivo nella critica ad erronee interpretazioni. La prima visione critica arriva da Andrè Breton 1935 che, con estrema lucidità, definiva “trofeo di caccia favolosa, terre vergini, ai confini dell’erotismo, della speculazione filosofica, dello spirito di competizione sportiva, degli ultimi dati delle scienze de lirismo e dell’umor” riconducendo il tutto ad una interpretazione dalla connotazione surrealista, forse la più vicina rispetto a quella che ne è seguirà con Robert Label del “mito dell’amore sterile” , o a tutte quelle che destinavano l’interpretazione dell’opera nella “macchina”, creandone a sua volta altre immagini collocabili in un simbolismo che va all’infuori dell’intenzione “duchampiana”, e che appartenendo esclusivamente alla fetta di critica più o meno contemporanea non risolve la questione. Se si affronta la polemica in termini di cultura visiva ci troviamo davanti ad un momento formativo-culturale che nella realizzazione ha mutato il proprio spazio. Se contrapponiamo quest’ottica ad una relazione sociale-culturale con l’avvento del mezzo televisivo, comprendiamo come il fenomeno abbia potuto pianificare la strada ad un approccio visivo-dimensionale trasmigrato all’esperienza del magma mediatico e consumistico che avverrà con la successiva analisi della visione televisiva. La vista dunque, nella critica, diventa “visione”, con la risultante identica a quella che sopporterà il futuro spettatore televisivo, che in maniera cosciente naturalizzerà l’atto visivo in un linguaggio inconscio che parte da un mutamento proposto da una scrittura critica e programmata, dove il messaggio apparentemente personale ricadrà in una dimensione globale opposta alla materia. Il riflesso posteriore a questo fenomeno “educativo” è indubbiamente identificabile nell’ italiano Manzoni. L’artista ha saputo vivere con maturità il processo creativo iniziato con Duchamp. La produzione “manzoniana” infatti non ne trae solo spunto, ma ne fortifica in modo particolare l’approccio visuale dell’opera. L’esigenza di una nuova dimensione, che dall’ informale guarda verso lo spazio, sottolineata maggiormente da Fontana, cerca comunque nelle idee, forme sognatrici ed immaginarie, con la ricerca di nuove superfici e spazialità che partono dalla pittura per estendersi nella scultura. La sperimentazione è un processo fondamentale dell’approccio alla nuova pittura proposta da Manzoni, componente madre dell’educazione visiva. Innegabilmente il sapore di sperimentazione si sente anche quando si guardano i brevi filmati nei quali si immortalava tra le sue performance con espressioni televisive più che cinematografiche. Esattamente Manzoni, non sottraendo ironia alla propria operazione artistica nemmeno di fronte alla cinepresa, investiga tendendo (probabilmente volutamente) a far vivere momenti di realtà nella performance. L’ideologia televisiva -pertanto- è già presente, l’approccio che Piero Manzoni ha con l’obbiettivo infatti non è un approccio cinematografico, ma prettamente televisivo, la voglia di realizzare il filmato infatti parte dalla volontà di filmare l’attimo, un momento reale con la risultante più di “reality” che documentaria. Ma in questo caso in che senso l’azione di Manzoni può chiarire l’approccio artistico al mezzo televisivo? In che senso cioè una performance, un oggetto, un quadro, una scultura, che si pone come “messaggio” nel quadro comunicativo, può consentire una descrizione più totalizzante senza effettivamente piegare il fattore visuale ad un semplice discorso, generalmente riservato a comunicazioni verbali? Umberto Eco in un articolo della rivista La Biennale di Venezia n 60 afferma che chi si occupava di arti visive o visuali come si usava chiamarle negli anni sessanta, tendeva nell’approccio ad un’inflazione terminologica e tematica mutuata da una ricerca linguistica con un abuso del termine “semantica”, la sottolineatura ricade appunto nell’uso del sostantivo semantica. Quando il termine semantica si insedia nei significati di un segno, non rimanderà ad alcun significato catalogabile, dal momento in cui impiegato come tale da chi analizza il linguaggio televisivo, molto spesso, ricadere in una concezione soggettiva dei segni con attribuzioni diverse in “vocabolari” soggettivi. L’equivoco potrebbe sparire se si intende affrontare una ricerca di tipo semiologico: il che significa l’affrontare i fenomeni di carattere diverso intendendoli come sistemi di segni, con particolare riguardo alla scrittura dei “ significati”, senza necessariamente pronunciarsi con giudizi definitivi sui “significati”. Ad esempio, sempre nell’articolo preso in esame, Umberto Eco proponendo alcuni esempi di analisi semiologica, spiega il perché una macchina o una sequenza sonora possono connotare facilmente determinati significati: e ciò non toglie che essi non ne “denotino” alcuno. Esistono quindi sistemi di significati dotati di capacità connotative e sforniti in partenza di capacità denotative sulle quali si esercita più facilmente una ricerca semantica. Coscientemente dall’antichità un enunciato può essere visto sotto un aspetto “programmatico”, “sintattico” o “ semantico”. E’ dunque possibile esaminare una forma, o un fenomeno, come “ messaggio” e studiarne le strutture comunicative, senza individuare in partenza una ricerca comunicativa o uno studio sulle denotazioni. Forse per questa via sarà possibile chiarire il problema affrontato in precedenza con l’introduzione di Duchamp e successivamente in Manzoni dell’evoluzione delle arti visive in relazione all’avvento del mezzo televisivo. Il fatto artistico nell’operazione visuale esercitata da Manzoni sta infatti nella consapevolezza intuitiva, del gesto. Consumato il gesto, resta l’opera che è il “documento dell’avvenimento di un fatto artistico”; viene esercitata quindi, la volontà di indagare nelle zone “vergini ed autentiche dell’arte”, come lui stesso affermava; l’arte è infine “ scoperta (inventio) in continuo divenire storico di zone autentiche vergini”, scoperta da cui “nasce la chiara coscienza dello sviluppo storico dell’opera d’ arte” e creazione di un’opera che “ è la nostra libertà”. Di quelle libertà dunque si sta parlando? Quella dell’invenzione di “immagini vergini” e giustificate, solo da se stesse; la cui validità è determinata esclusivamente dalla “quantità di gioia di vita che contengono”, cardini questi dell’opera di Manzoni. Quindi esisteva veramente la consapevolezza di voler imporre una ricerca di nuove immagini, immagini “vergini”, immagini virtuali che possono risultare reali solo con una “novità” di produzione, incentivata dalla scoperta di nuove possibilità visive. La proposta di Duchamp si incarna ed evolve in quella di Manzoni, indubbiamente influenzato dalla prima esposizione di Yves Klein in Italia, nella quale l’artista francese proponeva, alla galleria Appolinarie di Guido le Noci, a Milano, undici monocromi con lo stesso colore e lo stesso formato ma con prezzi diversi perché intrisi di diversa “sensibilità pittorica”. La critica è concorde nell’affermare che questi gesti hanno influito per la creazione del “nuovo” immaginario manzoniano, incentivandone la virtualità dell’opera visiva. Il guardare quindi si fa diverso, diventa concreata l’idea di poter applicare ad immagini uguali significati diversi, e valenze di diversi livelli di significante. L’analisi del messaggio proposto dagli artisti del periodo, non presuppone più un semplice codice comune all’emettitore e al ricettore; invero un “ricettore” comune di questo periodo, si trova di fronte alle opere di Duchamp, Manzoni, Klein e non ne può comprendere fino in fondo il significato. Rispetto al codice fondato su precise convenzioni sociali, il messaggio lanciato poteva assomigliare ad un significato ambiguo; ma in questo caso altamente informativo nella misura in cui si oppone alle regole del codice imposto dall’artista. Infatti, con Klein la dimensione del dipinto è il termine unico per quantificarne la maggiore o minore “sensibilità artistica”. Con Manzoni non ci si limita semplicemente ad un canale univoco dell’istruzione all’opera. Il codice infatti non stabilisce solo la corrispondenza tra i significanti e significati, ma anche regole si combinazione delle varie tracce. Un messaggio che comunque, per essere compreso, esige che gli elementi costruttivi si pongano come un sistema di differenze sullo sfondo di una base di comparazione. Il termine di paragone per una assimilazione di questo processo evolutivo nell’approccio al significato si può estrapolare facendo riferimento alla musica, affermando che la coerenza anteriore a Manzoni esiste nella musica tonale. Nella musica atonale, e meglio ancora nella musica elettronica, questo non avviene. Non esiste più, in altre parole, un codice di riferimento. Si può parlare ancora di comunicazione quindi? Nell’articolo preso in esame, Umberto Eco sottolineava come fosse di fondamentale importanza l’esistenza di un vocabolario, se non esiste un vocabolario non c’è comunicazione.

Spiega poi la natura del messaggio con l’esempio della considerazione di Levi-Strauss in merito alla pittura astratta, egli rispondeva: essa è “natura” “non cultura”, perché in essa non sussiste alcun rapporto tra i segni ed il mondo originario, afferma che la pittura astratta non può essere “letta” in riferimento ad un codice, quindi, per questo, non può essere un fenomeno di ordine linguistico tantomeno visuale; semplificando: non comunica, ma riesce a dare solo sensazioni più o meno gradevoli, ritenendo che un atto comunicativo debba avere le caratteristiche di una comunicazione linguistica, e che questa sia in simbiosi con la trasmissione di significati, cioè alla funzione semantica del discorso. Ostacolando, quindi, l’idea che il codice a cui riferire il messaggio visuale non possa essere polivalente ma univoco e destinato agli oggetti naturali. C’è da dire che Levi- Strauss tiene presente il caso della musica, e se da un lato afferma che la musica seriale ha un suo codice, per un altro ricorda che si tratta di codice prosodico, privo di opposizione di significati, e quindi un codice “espressivo” e non”semantico” Non si capisce però il perché un codice semantico debba essere solo espressivo (categoria soppressa dalla teoria della comunicazione) e non possa prevedere opposizioni di qualche altro tipo. Sempre Umberto Eco afferma in merito all’analisi sulla comunicazione di Levi-Strauss quest’antitesi: può essere un codice sintattico come quello di architettura: che coordina secondo leggi precise elementi di un edificio, fa nascere il ritmo rigoroso del medesimo da opposizione tra elementi, e dalla loro articolazione reciproca fa scaturire una scrittura, che ci comunica molte cose rispetto all’edificio stesso, alla sua funzione; e ci apre un sistema di connotazioni, di significati accessori legati alle strutture sintattiche dell’opera. L’approccio di Manzoni alla ribellione di un vocabolario ben preciso si evince già nel 1951 con l’adesione al primo manifesto nucleare, nel voler combattere ogni adesione a qualunque sorta di accademismo. Si può dunque affiancare l’accademismo al vocabolario finito, con la volontà di non appartenenza “all’ingranaggio della forma geometrica”. Vale la pena citare testualmente alcune parole del manifesto contro lo stile del 1957: “Da allora abbiamo proseguito nella sperimentazione di ogni possibile risorsa tecnica, dall’automatismo “tachiste” o oggettivo a quello soggettivo, al grafismo, all’action painting, al gesso, al calligrafismo, alle emulsioni, flottages, polimaterismo, sino alle acque pesanti di Baj e bertini del 1957. Alle sperimentazioni tecniche si accompagnarono, per vicendevoli suggestioni, nuovi linguaggi: dagli spazi immaginari”. Per la creazione di nuove espressività visive nel linguaggio comunicativo diviene fondamento il rapporto con lo spazio, e la spazialità. La dimensione abbandona sempre più il vocabolario artistico appartenente ad una liturgia critica nella semantica delle opere cercando nuove estensioni acquisibili nell’adozione di mezzi nuovi, finalizzati alla creazione di nuovi “spazi immaginari”. Parlando di contributi dati da Duchamp e da Manzoni alla cultura visiva non si può rinunciare all’ incastonarli del discorso a cui fa riferimento Mcluhan ossia, all’era elettrica dell’ottocento. Affermando che l’intero mondo delle arti si indirizzava verso le qualità iconiche del rapporto tra tatto e sensazione (o sinestesia come si diceva all’ora), ecco come prima Duchamp, e poi Manzoni risultano i figli di questo rapporto, e genitori della relazione sensazione ed evoluzione tecnologica. Tutti e due infatti si realizzarono nella sperimentazione focalizzando la ricerca nella ricerca dimensionale, approfondita da Fontana che comunque farà spesso riferimento alla poetica e alla filosofia manzoniana, tra le celebri citazioni di Lucio Fontana come non citare “la linea di Manzoni è filosofia pura oggi non c’è filosofo che abbia un’idea così perfetta” dove si evince un concentrato filosofico intriso di ricerca spaziale. Con la nuova “istruzione” visuale sorgevano nella concezione dell’arte coeva, problemi forse ancora presenti oggi: il primo dei quali era che quasi tutte le opere d’arte contemporanea cercavano un codice individuale nell’opera.
Lo stesso la precedeva, ne sostituiva il riferimento esterno, ma era anche contenuto nell’opera. Questo codice non poteva essere individuabile senza un aiuto esterno e quindi un’enunciazione di poetica, facendo passare il codice originale, (padrone nell’astrattismo), in secondo piano rispetto ad un’esigenza ancora evidente di codice che favorisce un’esperienza rivolta a sostenere ed a potenziare tutte le capacità e le attitudini individuali. Umberto Eco spiega: “ in un quadro informale, in una composizione seriale, in certi tipi di poesia “nuovissima”, l’opera instaura un codice è anzi una discussione su questo codice, è la poetica di se stessa perché è la fondazione delle regole inedite su cui si regge; ma di trasformato non può comunicare se a chi conosca già queste regole. Di qui l’abbondanza di esplicazioni preliminari che l’artista è costretto a dare nella sua opera presentazioni di catalogo, spiegazioni sulla serie musicale impiegata e dei principi matematici su cui si regge, note a piè di pagina nella poesia. L’opera aspira a tal punto alla propria di convenzioni vigenti, che fonda un proprio sistema di comunicazione: ma che non comunica a pieno se non appoggiandosi a sistemi complementari di comunicazione linguistica. (L’enunciazione della poetica), usati come metalinguaggio rispetto alla lingua-codice instaurata nell’opera”. Con Duchamp e dopo Manzoni le varie tendenze del post informale, dalla nuova figurazione all’assemblage, la pop art e sue espressioni affine, lavorano di nuovo sullo sfondo di codici precisi e convenzionali evolvendo però nella concezione visiva, con uno stimolo al nuovo sguardo nella ricerca verginale dell’immagine. Già in Duchamp e, come spiegato prima, con l’intervento critico riferito all’opera “il grande vetro”, è la provocazione a fare da padrona nella inchiesta della ricostruzione della struttura artistica, dando luogo alle basi di strutture comunicative che l’artista trova già preformate: la ruota di bicicletta, il cesso, diventeranno poi, l’insegna della coca-cola e la moda femminile. Si tratta di un linguaggio che, solo ai fruitori abituati a quei segni “parla”. Ribadisce Umberto Eco “…gli occhiali di Arman , le bottiglie di Rauschenberg, la bandiera di Johns, sono segni che nell’ambito di codici specifici acquistano significati precisi. Anche qui l’artista che li utilizza li fa divenire segni di un altro linguaggio, li riferisce a un sistema di riferimenti diversi e in fin dei conti istituisce nell’opera, un nuovo codice che l’interprete dovrà scoprire, l’invenzione di un codice inedito opera per opera al massimo serie di opere per serie dello stesso autore rimane una delle costanti dell’opera contemporanea ma l’istituzione di questo nuovo codice si attua dialetticamente nei confronti di un sistema di codici preesistenti e riconoscibile. Il fumetto di Lichtenstein è segno perciso in riferimento al sistema di convenzioni linguistiche del fumetto, in rapporto ai codici emotivi, etici, ideologici del pubblico dei fumetti; poi (ma solo poi) il pittore lo preleva dal contesto originario e lo immette in un nuovo contesto; gli conferisce un’altra rete di significati, lo riferisce ad altre intenzioni (Calvesi ha visto nel fumetto ingrandito la proposta di una nuova spazialità). Il pittore, insomma, opera quella che Levi Strauss, a proposito di “ready made”, chiamava una “fissione semantica”. Ma l’operazione che l’artista fa , acquista senso solo se si commisura ai codici di partenza, offesi e richiamati alla mente, contestati e riconfermati. E questo vale per molte operazioni delle ultime correnti, in modi diversi, dagli alberi di Schifano alle finestre di Festa, dai divani di Tacchi ai compensati di Ceroli, dalle strips si Perilli ai collages di Guerreschi, dagli ectoplasmi di Vacchi alle foro di Pistoletto, dalle architetture di del Pezzo al quotidiano “autre” di Cremonini, dagli alfabeti di Carmi agli schemi cinematografici di Mauri, citando alla rinfusa, per abbozzare una tipologia a titolo esemplificativo.” Si capisce quindi, come il post Duchamp sia in termini artistici, che in termini comunicativi, abbia saputo insediare nell’immaginario sociale nuovi concetti ideologici talmente forti da influenzarne non solo gli artisti, ma l’intera società contemporanea. In termini comunicazionali si traduce un contesto che proprio su tali termini deve essere approfondito, dove l’atmosfera deve essere di maggiore aderenza alle condizioni base della comunicazione non solo critica, dove le scuola delle esperienze apportata da Duchamp raggiunge i limiti estremi della rarefazione e della sfida, ma educa in termini visivi, ed è capace di creare illusioni e nuove immagini. Mario Schifano inizia la sua carriera tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. La sua ricerca è inizialmente caratterizzata da una pittura monocroma, densa, con evidenti riferimenti al suo lavoro di restauratore di opere antiche nel museo d’arte etrusca e archeologica, dove il padre lo aveva indirizzato. È la densità dei neri dei vasi antichi che ispira il giovane artista per alcune delle sue più significative pitture di questo periodo nelle quali, fin da subito, affiorano l’interesse per l’inquadratura, lo schermo, il particolare. La sua prima mostra importante alla “Salita” con Franco Angeli, Tano Festa, Francesco Lo Savio e Giuseppe Uncini, nel 1958 non funzionerà da incipit per un duraturo percorso vicino ai gruppi artistici di quella Roma cinematografica che lo accolse. Il destino, e forse anche la predisposizione al lavoro in solitudine di Mario, gli fecero abbandonare rapidamente l’ottica monocroma, tanto amata dal suo primo contatto interessante, Ileana Sonnabend. La Sonnabend, un contatto bruciato precocemente da Mario per via di una necessità espressiva che stava mutando e che sentiva il monocromo sempre più stretto, Mario rispetto agli altri artisti incanalava sempre più il suo guardare ad una società che mutava, utilizzando uno “sguardo pop” per vedere quella romanità tanto amata quanto odiata. L’introduzione allo “ sguardo pop romano” ci viene data da Unicini che dice: “la Pop Art arrivò a Roma quando un giorno finì dentro al bar Rosati una rivista con le immagini di Rauschenberg, di Jasper Johons, un giornale mai visto, con le fotografie a tutta pagina, colorate. Era un incanto, uno sbalordimento. Ce la passavamo tra di noi come un tesoro”. Facendo il lupo solitario, Schifano, esaurirà velocemente la stagione dei Monocromi (1960-1962); in un’intervista Arturo Quintavalle alla domanda sul perché Mario avesse rotto con Ileana e di conseguenza con l’ondata monocroma, risponde: Ileana ruppe con Schifano perché lui stava tentando di uscire dal monocromo e Ileana invece pensava che dovesse restare in quella ricerca quasi sospesa; in quel momento in cui la pittura era pittura di attesa. Tra queste parole colpisce la frase “momento in cui la pittura fosse pittura di attesa” con questa frase Quintavalle centra in pieno il momento che Mario stava affrontando, un momento di attesa, lo stesso momento che stavano vivendo tutti gli italiani nel ‘60, in particolare Roma, quasi una fase di preparazione ad un processo di complessi cambiamenti. Cambiamento delle visioni, cambiamento propositivo ad un nuovo guardare; la visione monocroma non bastava più, dopo le proposte enucleate in primis da Manzoni con gli strascichi di Kelin, si assiste ad un’evoluzione visiva che quasi per inerzia seguiva il rapido cambiamento tecnologico. Tra l’eco di una Roma dove le mostre della Galleria d’arte moderna con la Bucarelli, avevano mostrato Pollock e Rothko, ci si preparava ad essere diversi, tra gli odori di un fascismo ancora troppo presente e tra una presenza americana in crescita. Nuovi turbamenti ottici si scontrano anche con il pittore Mario, che in una professionalità artistica rispecchiante gli insegnamenti paterni, trovano nell’artigianalità pittorica le fughe che per anni avevano insidiato un immaginario a tinta unita. Continuando ad utilizzare un media antichissimo, come la pittura, Mario inizia ad adottare un nuovo schema visivo, facendo emergere sempre più frequentemente quel riquadro a forma di schermo, tra le tele. Il pop a Roma si faceva già sentire da anni, come accennato in precedenza, c’era già negli ultimi anni ’50 con un Uncini che parlava di riviste patinate piene di pop art che circolavano nei bar, e soprattutto al bar Rosati. Dell’America gli artisti sapevano già tutto. Incredibilmente molti erano i parallelismi che si potevano notare tra la Roma di quel periodo e l’America, le immagini che giungevano erano le stesse con le fasi che ripercorrevano il momento delle innovazioni. I cartelloni pubblicitari si uniformavano, la scritta Coca-Cola appariva ovunque e diventava sempre più una costante reale oltre che nell’immaginario comune in un’ idea di società che, per assurdo in un capitalismo diffuso amava sempre più l’idea marxista. Andy Wharrol in “a e b e viceversa” introduce ancor di più l’argomento, parlando di un insediamento antiborghese nella borghesia di questa bevanda: sia il presidente che il comune operaio se volevano bere una Coca-Cola dovevano spendere la stessa cifra, non c’era distinzione di ceto sociale, era un chiaro segnale che la società si stava uniformando diventando sempre più massa. Le prospettive visive stavano cambiando, delegate ad una comunicazione sempre più filtrata da uno schermo. Mcluhan analizzava come il monocolo della macchina fotografia tenda a trasformare le persone in cose e la fotografia estenda la visione a molteplici immagini, dove ad esempio la figura umana fotografata diventa una sorta di merce prodotta in serie. Mario lo fa, capisce che quadrare un quadrante è il fondamento della nuova visione prospettica. La squadratura introduce la dimensione, (quando guardo vedo schermato), il mio filtro è l’ occhio, la mia mente è lo schermo riflettente, il quadro è l’esito della proiezione del subconscio. Si quadra per tradurre il quadro esistenziale. Giuseppe Uncini nel libro dedicato a Mario Schifano di Luca Ronchi, parla dell’inizio alla così detta quadratura delle tele. Sembra che la motivazione in quella quadratura dipenda principalmente dal battesimo alla fotografia di Mario. Secondo Uncini la prospettiva di Mario comincia a cambiare nel momento in cui lui decide di vedere il mondo dal mirino fotografico, un’operazione di filtraggio meccanico dovuto ad uno schermo. Con questo processo Schifano inizia ad immortalare la realtà che in quella luce di cambiamento dà motivazione all’ indagine del periodo nel quale si trovava. Si crea dunque una analogia con la costruzione cinematografica e della realtà filmica, si intrappolano immagini che vanno a costituire i fotogrammi della vita non solo di Schifano, ma di una società italiana in continuo mutamento che si relazionava al mondo in maniera completamente subordinata alla tecnologia e all’artificio del mezzo, ormai protesi dell’individuo moderno. In questo processo non bastava più l’iride, serviva un nuovo filtro ottico (anche meccanico) per dar luce alla mente. Nelle visioni del momento l’uomo ha esteso il suo sistema nervoso centrale attraverso la tecnologia elettrica dove “il campo di battaglia, nella guerra come negli affari è diventato il processo per la creazione e la frantumazione delle immagini”. Arturo Carlo Quintavalle, invece, sostiene che quello schermo, in particolare in Botticelli (1962) vada guardato con deviazioni cinematografiche, rispetto a quanto dichiarato da Uncini. Indubbiamente il processo evolutivo nell’opera pittorica di Mario è partito dallo stesso processo che ha visto la fotografia essere l’avventrice di quello che è stato il fenomeno del cinematografo. Le immagini proposte da Schifano si sono orientate successivamente nella direzione televisiva, più che cinematografica, mediate operazioni avvenute con le polaroid o alla Nikon, sempre più presenti ed utilizzate nell’evoluzione artistica. Per Quintavalle la questione è da indirizzare in una visione spaziale, dove la ricerca di una nuova spazialità induce ad invadere spazzi limitrofi alla visione comune, dove la giustificazione arriva in quelle invasioni pittoriche che vanno oltre lo schermo tra la ricerca informale accantonata. Tra una critica che lo interpretava sempre più in termini psicoanalitici, il caso Botticelli effettivamente presenta, anche nelle proporzioni di uno schermo più cinematografico che televisivo, uno schermo che più che vuoto sembra alludere ad immagini possibili. L’immagine proposta in questi lavori appare come recintata da una specie di schermo dai bordi arrotondati. Bordi che rappresentano un confine tra due dimensioni contenute in una singola spazialità. La peculiarità del lavoro di Schifano è anche insita in una tecnica denudata dalle sue intenzioni: applicare il nastro adesivo per delimitare le aree e poi permettere di intervenire al loro interno, dove tra i colori sfibrati collocherà le immagini che assomiglieranno ad edifici nei paesaggi anemici databili 1963, non riportano a nulla di reale, ma rimangono comunque immagini di una memoria. Tra le pitture del sessantatre come Particolare di paesaggio, Cielo, La strada, H Blast: There may never be another, si possono trovare delle connotazioni comuni che aiutano a comprendere meglio il messaggio che queste tele lasciano. Innanzitutto l’immagine a cui si fa riferimento è contenuta in uno schermo delimitato da un bordo bianco, molto spesso nella zona inferiore si interrompe con del colore facendo terminare il limite tra schermo e supporto, invadendo quest’ultimo. La distinzione netta tra la zona inferiore e superiore viene dunque segnata da un dialogo tra le due parti divise, tra la superiore nei confronti di quella inferiore, ma anche viceversa, confrontandosi con due paesaggi in uno. Le relazioni tra questi paesaggi si interpretano con uno confronto diretto tra immagini speculari del cielo e della terra. Nella parte alta l’azzurro ed il blu si uniscono e scandiscono in maniera precisa lo stereotipo del cielo, aiutandoci ad una rapida identificazione, lasciando costruire agli spazi bianchi architetture fantastiche con il negativo del supporto a vista. La parte inferiore dell’opera vede dominare il bruno ed il giallo, con trapelata rapidità di realizzazione, che sembrano aggirare con rapidità la sagoma rettangolare al centro. Indicando tra le molte cose, una nullità costruttiva, potenziata da un cielo sovrastante che cerca un collegamento alla terra grazie a un supporto in tela. Presumibilmente la consacrazione definitiva di Mario al mondo dell’arte avvenne grazie ad Emilio Villa, il critico e poeta, che forse è stato il primo a comprendere il suo valore. Plinio de Martiss racconta che i due si incontrarono nel casolare di una Roma periferica, in una collettiva che ospitava oltre a Schifano, Tacchi, Mambor ed un altro artista di cui non si sa il nome. In questo periodo Mario faceva un po’ di tutto, ed in quel tutto qualche monocromo. I punti di vista del momento erano molteplici e lo introducevano a nuove riflessioni, la frequentazione con Uncini lasciava trasparire voglia di cambiamento, non sono solo dal punto di vista visivo e di contenuto ma anche di forma. Leo Castelli era entusiasta di questo ragazzo che sfornava quadri in un terrazzo condiviso con le signore che stendevano i panni. La prima personale, invece, l’ha realizzata nel 1961 con Plinio de Martiis che aveva una galleria in via del Babbuino, vicino a piazza del Popolo. In questa personale vennero esposti tutti monocromi, (Mario assistette anche nella disposizione). Nell’occasione di questa mostra, di fronte a quadri prevalentemente neri grigi, parlò di “mediazioni sullo spazio”. Plinio dichiara di aver venduto tutto il giorno dopo l’inaugurazione e ciò non è riconducibile al solo fattore del basso prezzo delle opere, bensì al fatto certo che la visione di Schifano aveva colpito il pubblico. Nell’ingenuità della sua opera iniziale si concentravano i lavori che altri artisti avevano raggiunto in anni di ricerche, Mario trovava in una spontaneità, dovuta ad un cambio di relazioni visive, la realizzazione di opere che pur essendo monocrome profumavano di un populismo che non era mai stato raggiunto prima d’ora nell’arte contemporanea italiana. Botticelli del ’62 ne è la dimostrazione e la sintesi di questo processo dove la quadratura non sembra contenere una vernice che sta colando fuori da quel reticolo schermato. Quasi non contenga messaggi, quasi quell’immagine voglia simbolizzare la nullità, cercando di voler completare una nuova spazialità, straripante nell’oblio, contaminante lo spazio che la circonda, come quell’ invasione mentale iniziale riesca a stimolare l’immaginario impulsivo di ogni spettatore. Nelle evoluzioni di Schifano si percepisce una genuina personalità che andava costruendosi attorno alla romanità che condivideva con i vari artisti del famoso bar Rosati. Piazza del Popolo era sempre più pop, ma di un pop diverso da quello che si stava sviluppando negli Stati Uniti, quasi un pop(o)lare. Plinio de Martiis che curò la prima mostra di Schifano ci tiene a ricordare che: eravamo tutti comunisti. Allora c’era Togliatti ed eravamo veramente convinti che l’arte e la cultura potessero cambiare il mondo. In una Roma bigotta e democristiana non avevamo altra scelta. Dico sul serio, non c’era altra scelta. Tra queste parole si respirano i profumi di idee politiche, appunto, popolari le stesse idee che stavano contagiando sempre più un Pasolini che trovava nella popolarità la chiave dell’esistenza umana. Piazza del Popolo era questo a Roma, tanto da parlare di derivazioni di una “scuola” di piazza del Popolo. La creazione di questa “scuola” fittizia, idealizzata da una comune appartenenza ad un luogo. Tutto ciò non è da sottovalutare nei confronti di un Schifano che frequentava questi ambienti ricchi di pop-olarità, quanto di galleristi tanto giovani, quanto già famosi a livello internazionale, tra i quali come non citare un Leo Castelli o una Ileana Sonnabend. Da ricordare che Mario ha avuto un rapporto irrequieto con Ileana Sonnabend, stile usa e getta, tipico del suo carattere ma mediato grazie alla una sua impronta culturale di “popolano”. Mario Calvesi racconta: “Mario cominciò a seccarsi con Ileana. Poi lei aprì la galleria a Parigi e fece un programma che prevedeva una prima mostra di Rauschemberg, la seconda di Jasper Johns e la terza di Schifano. Quando Mario lo venne a sapere mi disse: «Ma guarda questa, mi mette davanti ‘sti du’ stronzi». I due stronzi erano Rauschemberg e Jasper Johns! Bisticciarono anche perché lui vendeva i quadri sottobanco fregandosene del contratto di esclusiva. Avrebbe dovuto dare tutto a lei. La Sonnabend ci teneva molto, ma lui decise di lasciarla, non andò neanche all’apertura della sua mostra nel ’63 Parigi. Fu un atto di coraggio, ma anche una pazzia, perché lui così rinunciò al mercato internazionale. ” Queste parole fanno già capire molte cose, il rapporto indeciso con i galleristi non dettato da una semplice irrequietezza, ma da una “strafottenza” diretta, da una consapevolezza costruita tra i rapporti romani del tempo, in fin dei conti chi non sarebbe stato consapevole di se stesso, se tra gli estimatori del proprio lavoro avesse avuto Moravia e Villa, le personalità che gli giravano attorno crearono in lui un egocentrismo tanto attraente quanto consapevole permettendogli di indagare ingenuamente in nuovi territori delle proiezioni esistenziali, quello che era pop mutava e si inglobava al sociale, quello che era Roma poteva dunque essere pop dopo un processo di filtraggio culturale popolare dai retrogusti europeisti. Va verificato che le opere italiane erano molto più disegnate e dipinte rispetto alle americane; a dichiarazione di De Martiis, Mario come pittore era molto più bravo dei vari Warhol e Jasper Johns. Con questi incipit Schifano seppe proporsi nell’ aprile del ’63 alla famosa mostra alla galleria Odyssia di Roma, presentando per la prima volta l’elaborata svolta da monocromo a pop art; il salto fu tanto rapido quanto intrinseco della simpatia che Mario nutriva da tempo per Andy Warhol, che a detta di Maurizio Calvesi considerava intelligente e contemporaneo. La mostra sorprese molto l’amico Giuseppe Uncini che si sentì rispondere con un «a Pè, svejate!» dopo aver chiesto delucidazioni sul motivo della svolta compiuta da Mario. La trattazione in questo momento guardava alla pop art americana dentro uno schermo, il monocromo iniziava ad includere le prime immagini che riportavano le scritte Coca-Cola, Esso e No, la stilizzazione dell’uomo vitruviano, il sole, gli incidenti e i grandi paesaggi, il monocromo si trasformava quasi pronto ad assorbire il nuovo linguaggio delle nuove immagini sempre più presenti in una quotidianità che stava cambiando. Il monocromo che diventava luogo di proiezione si dilatava e mutava, l’immagine che prima era solo luce straripante ora diventava sintesi di forme corrispondenti all’immaginario italiano. Questa predilezione per un linguaggio che si stava dirigendo verso una concezione cosmopolita del vedere, spinse Mario ad affrontare il viaggio che molti italiani decisero di intraprendere, verso il miracolo americano, in particolare con direzione New York. L’attrazione che questa città esercitava sulla personalità di Mario era analoga a quella che lui nutriva per una bella ed affascinante Anita Pallemberg. I due si frequentavano da un po’ e l’irruenza di Mario non lo fece tardare nel chiederle di accompagnarlo a New York. Anita aveva i contatti giusti e Mario lo sapeva, fu così che nel dicembre del ‘63 decisero di prendere la nave a Napoli e partire, era da poco stato ucciso Kennedy. In questa nuova città Mario non trovò grandi soddisfazioni, si intercorsero in questo momento le rotture di rapporto dapprima con Ileana Sonnabend e poi con Leo Castelli, oltre all’appoggio del poeta Frank O’Hara non si costruì altro, va comunque ricordato che O’Hara era una persona legata la mondo dell’arte. Tra questa conoscenza si sviluppava la voglia di vivere il mito americano internamente, insomma Mario a New York non vendeva quadri ma faceva solo vita sociale. È qui che Mario inizia anche il suo rapporto con le droghe, tipico dell’ambiente ma anche del periodo. Non si sapeva bene che danni procurassero, ma rispondevano benissimo alle esigenze che dovevano competere con un universo costruito di immagini sovrapposte, in un creando di ambiguità miscelando vita reale ed una virtualità sempre più presente. Nel rientro romano lo spirito pop di Schifano risulta fortificato da una presenza costante di immagini tra le tele che parlano quasi in un linguaggio pubblicitario. Nell’esecuzione di questi lavori si fortifica la presenza di immagini italiane per una Pop Art europea, come dice Luca Ronchi, opere come Leonardo, gli omaggi a Giacomo Balla, i Paesaggi anemici, il Futurismo rivisitato diventano i paradigmi di un “modo italiano” di pensare il nuovo paesaggio urbanizzato, senza rinunciare alla tradizione linguistica volutamente ridotta a stereotipo. Gli anni che vanno dal ’64 al ’71 saranno gli anni in cui Mario cercherà di sintetizzare in modo unico e personale i vari stimoli nelle arti, con una capacità degna di essere affiancata ad un’America non troppo lontana. Accelerando incredibilmente Mario cerca soddisfazioni tra quella dimensione, che la sola pittura non era in grado di dargli. Infatti in questo periodo, in un trend artistico internazionale inizia a fare cinema, costituisce un gruppo pop-rock le così dette stelle di Mario Schifano, e con un lavoro che si unisce ad un’esistenza tanto confusionaria quanto intensa, trasforma la propria vita in una performance, vivendo il proprio personaggio naturalmente con una simbiosi tra personaggio e persona. A testimonianza di questa appartenenza ad una virtualità della realtà sarà un non schierarsi politicamente in nessuna fazione, ma rispondendo semplicemente con ciò che lo aveva reso famoso, ossia con un pittorico “Compagni compagni” o con l’intera parete per la sala da pranzo di Gianni Agnelli con la rappresentazione di una manifestazione dal titolo Festa cinese. Il passaggio del decennio colpirà Schifano in una rivoluzione più semantica che politica, in un lungo periodo di ripensamento sul ruolo della e sulla pittura stessa. (In questa fase transitiva Mario riesce a pensare di buttarsi nel mondo del cinema con una credibilità tale che Carlo Ponti gli commissiona un film di ambiente americano). In tale periodo italiano Schifano affronta un lavoro molto produttivo, suggerito anche da una situazione favorevole che era riuscito a crearsi attorno. A testimonianza di molti Mario era riuscito, pur rimanendo un pittore, a crearsi una così detta “immagine”, era molto apprezzato dai suoi amici che tentavano di emularlo e lo guardavano come un avventore delle mode. Non c’è da sorprendersi se l’arte di Schifano in questo momento sembra sempre di più un arte che emula le tele della Pop Art americana, in fin dei conti il periodo era quello, le cose di cui valeva la pena guardare e rielaborare avevano inevitabilmente un sapore americano. Uno specchio della società sempre più uniforme, ma specchio anche nella voglia di assomigliare sempre più a quella cultura che arrivava da oltre oceano affascinando molto i giovani (e non solo giovani) italiani. Questo era il tempo dove si stava generando il circuito che in seguito verrà chiamato art-system, la fusione semantica tra le immagini patinate e la vita reale. Questo sistema diveniva sempre più la bisettrice tra reale e virtuale della vita di ogni artista, segnando e ritagliando quei connotati, fino ad allora rilegati in un avanguardistico valore di interesse delle arti figurative. Logicamente c’era chi è stato più predisposto nel farsi tagliare da questa bisettrice, a mio avviso Mario Schifano (ingenuamente) porgerà i polsi a tale lama dalla forma simbolica e non sintomatica, rovina e la fortuna della sua esistenza. Abbracciare le droghe in questo momento, significava dimostrare coerenza alla visione contemporanea del mondo. Una generazione che si trovava davanti ad miscuglio di esperienze tecnologiche e comunicative in un arco di tempo molto ristretto, rispondeva con fascino ad una ambiguità tra reale ed dell’immaginario. la realtà, forse, non bastava più e necessitava di essere integrata da una dose costante di “psichedellia” apportata anche dalle droghe. Esse divenivano così ammortizzatori dello sbalzo tra visioni reali e irreali, in una legittimazione giustificata dalla difficoltà di scissione tra dimensioni. La pittura per Schifano stava diventando sempre più uno sfogo diviso tra sensazioni ed immagini che popolavano la mente confusionaria di un ragazzo di Roma. Le idee erano molte ma si susseguivano con impressionante velocità, e il controllo risultava sempre più difficile ed articolato. Per Mario questo continuo stato “limbico” tra queste due fazioni risultava essere vincente sensibilizzandolo sempre più nei confronti di un nuova fenomenologia tecnologica che partendo dalla fotografia e sfiorando il cinema è finita per decretare come miglior mezzo la comunicativo la televisione. Ciò che caratterizzerà la dimensione di ricerca apparterrà sempre più a quella “realtà fittizia” professata da Mcluhan il quale affermava che tutti i media hanno come primo fine quello di mettere nella nostra vita percezioni artificiali e valori arbitrari. La scrittura pittorica accennata in questo percorso risulta una soluzione di ricerca in bilico tra immagine scrittoria comunicativa, ed immagine polisindeto visiva, chiara in particolar modo nelle opere che hanno proposto un percorso interessante nella mostra curata da Quintavalle, nel catalogo di questa mostra si costruisce un percorso molto utile per comprendere l’opera intrapresa da schifano nel 1963. In particolare nella parte di dipinti che precedono queste la costruzione dei paesaggi “anemici” , tentando di raggruppare in esse molte opere che riguardano il paesaggio. La materia pittorica legata sempre ad un espressionismo astratto si lega ad una scrittura che ha come oggetto il paesaggio, proposto in due livelli a due tonalità, il bianco in alto il verde sotto. In questo periodo infatti Schifano dona la chiave di lettura per introdurre i lavori successivi, nei suoi disegni generalmente compresi nelle dimensioni tra 70 x 100 cm, grafite e smalto sopra la carta, disegna uno schema compositivo con particolari di paesaggio e di flora, alternata a dense note di colore, spesso debordate con forme apparentemente prefissate, come in un taglio di pellicola da 35 mm,o in alternativa dall’intreccio di alcuni casi verticali e orizzontali che disegnano delle quadrature. Nei dipinti come Con anima del 1963 coincide l’idea della bipartizione con una separazione netta della zona inferiore con quella superiore, sempre rimanendo all’interno della famosa quadratura con i bordi arrotondati, quasi caleidoscopiche. L’idea di Schifano sembra dunque essere un’idea precisa nella rappresentazione di possibili paesaggi, già scanditi in sui disegni su carta del ’63. Considerando quindi ciascun riquadro dagli angoli arrotondati come un’immagine di una serie appartenente ad una memoria e non ad una realtà. L’immagine fotografica, tanto amata da Uncini, oppure lo schermo riferito da Quintavalle risulta un limite dello spazio possibile, e come affermando in un’espressione di Arturo Quintivalle che non si avrà mai un tranche de vie, anzi la tranche de passage, tra la cornice che chiude uno spazio di rappresentazione come fosse una finestra sul mondo, ma con il limite trovato nel quadro dal telaio o dal supporto entro cui viene dipinto uno schermo. La visione di Mario, più o meno consapevole, si propone come una scansione e filtro del rapporto con il mondo a cui apparteneva, come un Jasper Johns, voleva scollare il colore e tenero differenziato come possibile eventualità; delimitandone lo spazio internamente al supporto che ospitava la sua idea, distinguendolo e limitandolo in una quadratura che alludendo ad un fotogramma rimaneva senza immagine, in una grafia continua tratta da un’esperienza ormai appartenente ad una memoria. La pittura offre una sperimentazione eterogenea, dipingere è una possibile scelta tra le molte strade, comunque mediate da immagini ed immaginari già presenti, riprodotti, questo è il senso della brodaglia attorno allo schermo. Successivamente il paesaggio proposto in questi anni abbandonerà l’anemia, mutando, snellendosi e diventando impressione, non certo rappresentazione. I processi di rielaborazione fotografica in Schifano, corrispondono nettamente a quelle esigenze scrittorie comuni a ciò che avveniva in un canovaccio teatrale, la fotografia infatti faceva esistere già un linguaggio, un segno; nella sua rielaborazione pittorica, in fine subiva un processo di riscrittura, una sovrapposizione di linguaggi, che a tra tratti ammutinava l’esistente per regalare un nuovo immaginario ad una soluzione parallela agli eventi della contemporaneità. La pluralità dei materiali utilizzati sembra dunque andare di pari passo a quella scrittura che si riferisce al significato (l’immagine mentale che noi abbiamo di quella parola) non significante (la sequenza di fonemi o grafemi di una parola ) dell’opera, proponendosi semplicemente come una pittura nuova. Nelle evoluzione pittorica di Schifano non si più non partire da lo stravolgimento che è avvenuto nella proposta dell’opera futurismo rivisitato a colori, questo è il titolo di un’opera tra le più note appartenente al periodo tra il 1965 ed 1967. Per comprendere le immagini di questa ricerca bisogna senza dubbio fare riferimento alla fotografia del 1912 dove Marinetti si fa immortalare a Parigi con Russolo, Carrà, Boccioni e Severini, rispettivamente due a sinistra e due a desta rispetto alla figura divisoria del teorico poeta a capo del movimento. La foto è molto nota ed inflazionata nella cultura “popolare artistica” essa però viene utilizzata da Schifano in maniera quasi opposta a questa “popolarità” acquisita. Il processo intrapreso nell’utilizzo e nella rielaborazione di questa foto parte dalla semplice constatazione che le figure di Marinetti, Russolo, Carrà, Boccioni e Severini vengono ridotte a sagoma, diventando dei cartonati dove i volti sono evaporati scomparendo e lasciando solo i pastrani, le bombolette e un bastone. Il processo è quasi di pulitura di ogni dettaglio, con una eliminazione e sostituzione completa dello sfondo originario che non esistendoci lascia il ritaglio di cinque personaggi isolati da ogni contesto. Se si prendono in considerazione altre immagini di questa serie che propone la scritta “futurismo riv. a colori” che fluttuando a mezza altezza vuol dire proporre delle alternative interpretative dell’opera che possono ritrovare diverse soluzioni, come un futirismo rivisitato del ’66 formato da 18 perspex sovrapposti, che spartiscono completamente il sistema e lo trasformano in un grande puzzle compositivo, dove i personaggi, tra le trasparenze acquistano colori che vanno dal rosso al giallo, dal viola al nero; in questo le scritte che si intersecano tra le figure lasciano scomparire l’ultima figura che quasi in maniera mistica si nasconde dietro i pannelli di colore scuro. Sempre nel ‘66 si può collocare un altro futurismo rivisitato, che propone la rappresentazione delle cinque sagome in maniera quasi sdoppiata, da una parte in una soluzione di bianco e nero dall’alta come dipinto colorato. Operando in questa maniera sembra operare in maniera quasi dilatante, con un processo che non va semplicemente interpretato come semplice sdoppiamento, ma come momento di transizione. Mutazione tra mezzo fotografico e mezzo pittorico, oppure mutazione tra bianco e nero a colore? Sembra quasi un avvento tra quello che avverrà nel ‘72 con la prima trasmissione a colori. Molte sono ancora le soluzioni proposte tra i vari “futurismi rivisitati” che finiranno per esaurirsi nel 1967, le sagome sono sempre le stesse, mutano di dimensione e con un’operazione artigiana vengono utilizzate e riutilizzate per realizzare più tele. Il pittore in questo caso diventerà più grafico che pittorico con una ripetizione fotografica continua. Le figure si spostano, ma anche la celebre indicazione scrittoria emigra da una parte all’altra del supporto, un lavoro istintivo che trova il suo apice nella momento in cui decide di lievitare sopra la testa di Marinetti, con un ricordo da insegna pubblicitaria. I ricordi sono quelli pop ma in una dimensione che muta in continuazione e sembra cercare un nuovo linguaggio tra i diversi media. Una composizione che muta non solo nell’operazione pittorica ma anche nella rielaborazione della figura dall’originario bianco e nero, acquista note colorate in un secondo momento con l’applicazione di panelli di perspex. Questa operazione è molto interessante perché riporta sempre a quel linguaggio fotografico adottato inizialmente da Mario. Ricorda molto quelle foto che si fanno utilizzando dei filtri sull’obbiettivo della macchina fotografica, ma allo stesso tempo serve come contributo ulteriore in quella creazione tra spazialità e dimensione che già avveniva inscatolando i dipinti tra riquadri. Su questo molti critici si sono interrogati tralasciando il fatto che quei pannelli in perspex non siano altro che altri schermi. Schermi su schermi generano dubbi sulla condizione di dimensione, dimensioni sopra a dimensioni che si distinguono e finiscono per mutare il contenuto visivo. Che cosa accomuna tutta questa serie di dipinti la serie di dipinti? La rappresentazione del tempo e del movimento credo sia materia comune in tutti, la durata bergsonian che si è palesata nei futuristi, in Mario si vanifica a discapito della costruzione dell’opera. Se esiste un dialogo tra la fotografia di Etienne-Jules Marey e la comprensione dei lavori di ricerca dei futuristi come Boccioni, Balla o Russolo non mi sembra scontato, ma questo termine di indagine non può valere per Schifano. Il movimento che Mario ottiene nella moltiplicazione delle sagome dei futuristi non può essere inteso come penalizzante. L’indagine che si intende perseguire nel suo lavoro gravita attorno a dei personaggi appaiono in un blocco univoco che si sposta in una dimensione immaginata. Schifano con questa rappresentazione decide di affondare le proprie radici in una cultura che gli apparteneva e lo identificava, rappresentando la sola avanguardia italiana che ha auto un ampio consenso internazionale. La scelta del tema del futurismo non risulta di facile comprensione, nei confronti delle scelte che Mario affronterà in seguito, molti le indirizzeranno verso il dada, verso il costruttivismo o verso il surrealismo. Si deve tener conto però delle considerazione che emergevano a quei tempi con un Maurizio Calvesi o di Maurizio Fagiolo e molti altri, sulle origini del primo futurismo come avanguardia rivoluzionari, si pubblicavano anche, a cura di Maria Drudi Gambillo e Teresa Fiori, gli archivi del futurismo, testi molto famosi per che si intendesse occupare di futurismo in relazione ad una storia completa del movimento. Schifano riducendo dunque a sagome le figure, propone una lettura di esse quasi “naїve” di quella foto futurista parigina, che su indicazione di Arturo Carlo Quintavalle, si collega al dipinto io sono infantile (1965) che fa dell’immagine illustrata di Winnie the Pooh da E. H. Shepard l’impronta di riconoscimento. Il bambino che scende le scale nella medesima opera è stato riconosciuto come il nudo che scende le scale si Marcel Duchamp, proponendo però molti altri elementi, il giocattolo rovesciato in alto a destra, le scansioni nere quadrate, la ringhiera in fondo a sinistra; Mario sembra proporre un linguaggio che in questo dipinto risulta come artefice del tempo che è passato. Qintavalle incanala l’interpretazione di questo dipinto ad una necessità di “gioco” intrapresa da Schifano, che si realizza in queste immagini dilatate in uno spazio memonico proiettato nella tela, definendo questo processo come una regressione infantile che secondo lui aiuta a comprendere anche il processo iniziato con il futurismo rivisitato. A mio avviso, pare che questa soluzione interpretativa sia troppo rapida e scontata ed emani olezzi di una critica didattica e consona. Ritengo sia giusto mettere quest’opera nel filone dei grandi cartonati, come lo sono stati quelli utilizzati nella rivisitazione futurista, ma se inclusi in un filone preferisco delegarlo al filone grafico. Il filone tanto amato da Mario al ritorno da quel viaggio americano che lo aveva segnato. Segnato anche nello stile, uno stile che abbandonata la monocromia iniziale, e che rispecchiava sempre più quel linguaggio intravisto tra i numerosissimi cartelloni pubblicitari. Indubbiamente l’impatto di un infantilismo diffuso in quest’opera è rintracciabile se si pensa al rapporto che avrà in futuro con il figlio, ma deve essere considerato un una soluzione di ludico-esecutiva. La fortuna in queste operazioni si trova anche nelle realtà della vita di Mario e non solo in una memoria. L’immagine dunque è sempre relazionata ad una volontà giocosa in una relazione di mezzi espressivi, ma soprattutto tecniche espressive. La prova diretta di questo rapporto giocoso arriverà con la nascita del figlio Marco Giuseppe, dopo i momenti bui soprattutto nel periodo degli anni 80 tra i vari scandali delle droghe e quant’altro sembra “regredire” in questa dimensione. Ritornando alle opere, Schifano vuole proporre come un gioco, non tanto come regressioni di infanzia, piuttosto attuazione di un’infanzia presente e viva nelle proprie pitture, mai abbastanza mature. Questa pittura si realizza in un’ottica di lettura mutata dai viaggi americani; Mario nel ’65 è già stato a New York varie volte, ha avuto i famosi contatti con le gallerie di Ileana Sonnabend, conosce forse poca letteratura americana di quel periodo, ma allo stesso tempo è impregnato di quelle immagini proposte dalle “fotografie” dal tipico gusto pop. Non so se si possa canalizzare completamente le motivazioni dei vari critici in quello che è stata la “beat generation”, ma dai viaggi statunitensi dove Schifano porta a casa numerose fotografie con soggetti gli stereotipi che ora consideriamo emblemi americani. Il viaggio americano è il simbolo di questi processi, di sicuro quello emerso tra le proposizioni nelle produzione di un film che non verrà mai realizzato. ( Iniziatori nella carriera artistica di Mario, come regista contano comunque un fotografo come Robert Frank e scrittori come Jack Kerauac oppure come William Burroughs o poeti come Allen Ginsberg.) Interessante l’interpretazione che da Quintavalle da questo periodo, interpellando Burroughs che bel suo romanzo Junkey (che Schifano molto probabilmente non ha mai letto), offre una chiave di lettura per comprendere l’opera a partire dal futurismo rivisitato. Citarla è d’obbligo: agli inizi del capitolo XIII, Burroughs descrive l’abbandono raro all’interno di quella ossessiva ricerca della droga che anima l’intero romanzo. Lo scrittore americano descrive il momento, della regressione mentale del drogato nel momento in cui la droga non fa più effetto; come un dormiveglia eccolo recuperare sensazioni perdute, suoni e profumi e una visione sospesa, distaccata, che descrive come l’incanto della fanciullezza, ma ecco il passo:”una mattina d’aprile mi destai in preda a un po’ di malessere. Giacevo sul letto contemplando le ombre sul soffitto imbiancato a calce; ricordavo giorni lontani, quando stavo a letto accanto a mia madre, contemplando le luci della strada muoversi sul soffitto e giù per le pareti. Provavo una nostalgia acuta dei fischi dei treni, degli accordi di un pianoforte nella via di qualche città, delle fragole secche bruciate. Un blando malessere per assenza di droga mi riconduceva invariabilmente all’incanto della fanciullezza. “non fallisce mai”, mi dissi, proprio come una puntura. Mi domando se tutti gli intossicati si procurino droga per questa sensazione meravigliosa. Il rapporto tra Schifano e la droga non più essere sottovalutato, c’è chi lo definisce importante, chi parla di essenzialità, ma bisogna identificarlo anche in termini di regressione. Forse sono fenomeni paralleli nella vita di Mario, come la riduzione a schema delle tante figure diventate solo forme, forme che fluttuano nello spazio di un immaginario, dai Paesaggi anemici fino ad arrivare al Futurismo rivisitato, dove un intero movimento viene sintetizzato in visioni psichedeliche. Nella Milano del 1968 allo Studio Marconi viene presentata una mostra che prosegue a livello formale anche nei lavori dell’anno successivo. La mostra fu intitolata “compagni compagni”, sicuramente traendo spunto dalle varie scritte che apparivano in alcuni dei disegni, ma non in tutti, poiché le scritte che campeggiavano nelle superfici si potevano leggere anche frasi: “sulla giusta soluzione delle contraddizioni in seno alla società”. Precedentemente ad un’analisi delle opere di questo filone vale proporre una ricostruzione delle pendenze politiche di Schifano, anche per sgombrare un esegesi troppo raffinata in questo campo. Va chiarito che Schifano non è mai stato legato ad un partito politico, però l’ambiente frequentato e gli amici che patteggiavano per i gruppi extraparlamentari di estrema sinistra, lo affascinavano e lo facevano pendere per un trend romano indirizzato verso un accenno di comunismo. Vive gli anni della rivoluzione culturale della Cina di Mao Tse Tung, sono gli anni del così detto Libretto rosso, anni in cui si tendeva ad una certa mitizzazione dell’area politica di Schifano, che decide di uscire dalle serie come Oasi del 1969 o di Tuttestelle, proponendo un racconto diverso, ma sull’ idea edificante dei lavori precedenti, usando dunque le sagome per le figure e per le scritte, utilizzando oltre al pennello l’aerografo. L’analisi dei disegni, dunque la ricerca per raggiungere questa ricca serie di dipinti, mi sembra molto indicativo in un contesto etnografico Schifano infatti parte da un disegno preparatorio ricco di dettagli, generalmente chiaroscurato, un disegno non ancora ben definito all’inizio, non si capisce quante siano le figure che intende collocare nel futuro dipinto e soprattutto dove voglia collocarle. In alcuni casi si intravede la volontà di ricreare uno spazio interno, un pavimento, le tre sagome nere con inserti rossi, in altri si scorge uno spazio occupato da una strada, due figure di schiena, un altro paio di figure che camminano, il tutto immerso in un bianco e nero come se si fosse davanti ad una fotografia fortemente contrastata e stampata su tela, questo si annulla quando si alza lo sguardo e si vedono le scritte in rosso a “dripping” o dipinte in cui si legge la scritta “compagni”. Proseguendo nel catalogo sembra farci capire come il progetto sia cambiato, avviandosi verso una soluzione che risulterà vincente e prescelta: in due grandi pezzi, uno un disegno a grafite con smalto nero e collage di carta, l’altro un disegno a grafite e ancora smalto rosso su carta. In queste ultime ricerche vediamo come Mario sperimenta un “tentativo” in più direzioni rispetto a quella che risulterà la prescelta nella moltiplicazione delle immagini. Così nel primo pezzo si vedono a sinistra segnature a matita sulle due figure che abiteranno l’ opera, con sagome di una dimensione che raggiungerà anche i tre metri di altezza, che reggeranno chi una falce e chi un martello. Nell’altro dipinto si vedono le forti pennellate rosse e giallo-arancio, al di sotto a matita le sagome di tre forme, due di esse con la falce ed una con il martello, mentre dietro un’altra corporatura e in posizione nascosta di essa ne viene un’altra di cui si intravede solo una gamba; più in su di queste figure coesiste un accenno di palma, che irrobustisce quella ossessione antecedente sule palme e sull’oasi, che caratterizza schifano per un lungo periodo; più in alto ancora in lettere a ricalcatura delle sagome di carta, l’ espressione già riportata “Sulla giusta soluzione delle contraddizioni in seno alla società”. Se adesso si parla di analisi dell’opera si scopre realmente come operava schifano; per prima cosa tenendo conto del supporto. L’opera di ricerca in questo periodo accomuna figure scure su fondo giallo sovrastate dalla scritta rossa in alto col testo già riportato, tra tocchi di rosso nelle tre figure. Il particolare da notare sono i bordi arrotondati dei lavori, come se si fosse davanti uno schermo di proiezione, non a un’ opera dipinta. Schifano ha apportato diverse varianti a questa “immagine po(p)litica” che per più opere viene anche ripetuta. Vale la pena di citare quanto ha scrive Quintavalle di questa ricerca: “Prima di tutto Schifano, anche in questo caso, utilizza la fotografia che gli servirà per schematizzare le tre figure e, dopo essere stato incerto su di una eventuale resa realistica dei personaggi, decide per l’utilizzo delle sagome, della pittura a spray, con la conseguente eliminazione di ogni dettaglio e l’isolamento sospeso dalle figure in uno spazio non fisico ma mentale. Anche la scritta che sovrasta le sagome è un ovvio riferimento ai modelli di lettura in chiave marxista, ma a ben riflettere queste immagini paiono proporre anche altro. Per schifano la composizione del ciclo è analoga, nella gestazione e nello sviluppo, ad altri, come per esempio quello di “paesaggi anemici” degli anni sessanta, o come quello del “futurismo rivisitato”. Anche in quel caso le figure sono sospese nello spazio, senza più alcun riferimento a una dimensione reale ma, semmai, solo mnemonica. Schifano usa delle immagini che sarebbe sbagliato leggere in termini metonimici, descrittivi e realistici; infatti per giungere a questo livello di distacco introduce uno schema fisso, elimina lo spazio attorno, ripete sempre la scritta, varia il colore utilizzando anche il perspex che sovrappone le singole immagini. L’idea che le figure i quadrati della serie possano essere visti in sequenza distinti solo dalle variazioni di colore, emerge chiaramente, ma si deve cogliere anche un riferimento a manifesti opposti sulle strade. Non devono essere stati manifesti dalle figure di rivoluzionari marxisti con falce e martello a ispirare Schifano ma, probabilmente, manifesti pubblicitari per i quali la ripetizione è funzionale all’impatto del messaggio.” Come primo punto di analisi a queste dichiarazione, mi sembra opportuno soffermarmi sulla derivazione dell’opera di Schifano che Quintavalle da in merito alla fotografia. Parla infatti di un processo di “schematizzazione” della fotografia dei futuristi, dovuto all’incerta resa del dettaglio che Schifano avrebbe ottenuto lavorando sui personaggi. Penso che questo soluzione non sia stata scelta come soluzione ad un problema di definizione del particolare per Mario, credo che lui non abbia tentato una risoluzione minore per evitare una “resa incerta”; sono convinto piuttosto che lui sia fin dal principio influenzato da quello che vedeva offerto dalla grafica pubblicitaria, di tutto quel mondo appartenente alle cartellonistica pubblicitaria, (e non si dimentichino i “cartoni animati” del carosello, non si può far finta che Schifano non gli avesse mai visti). Più che di “resa incerta” si deve considerare quello che vedeva ogni giorno l’artista, il trend delle grafiche era molto minimalista in questo periodo di uscita dagli anni ‘60, si pensi anche il principio dell’arte povera e a tutte le correnti minimaliste che hanno segnato quei momenti, si pensi anche al passato monocromatico di Schifano, il monocromatismo deve essere visto come una sintesi di un’operazione antecedentemente pittorica e figurativa. Questa essenzialità può essere delegata a necessità primaria in quella ricerca di lavoro svolto riguardante sia “compagni compagni” sia “futurismo rivisitato”; partendo da una immediatezza che si trova nella rapidità esecutiva della sagoma, si riconosce un principio funzionale che Schifano intendeva affidargli, le varie sagome prefabbricate infatti verranno duplicate e saranno utili ad una riproduzione seriale. Altro aspetto in contrasto a questa tesi è sicuramente l’aspetto seriale dell’opera di Schifano, quando parlo di politica faccio anche riferimento a questo oltre che al gioco di parole che sta tra rappresentazione e il momento storico. La politica di Schifano è un processo di congiunzione tra una pendenza di estrema sinistra, ed un amore per le cose tanto belle quanto costose, due cose che generalmente faticano a stare assieme, ma che in un concetto di politica possono coesistere. Più dipinti faccio, più guadagno, e di conseguenza più cose posso acquistare: questo è il ragionamento a cui bisogna fare riferimento parlando di Mario; inutile citare il fatto delle Jaguar in questo contesto, ma credo che un rimando può essere d’aiuto. Secondo punto poco chiaro in questa dichiarazione è sempre il rimando non fisico ma mentale a cui fa rifermento Quintavalle, che parla di una memoria, parlando di un’azione appartenente ad un (iper)cosciente che si fa avanti ogni volta che Schifano fa un’opera. Parlando prima di riferimento mentale e poi di ricostruzione spaziale mnemonica forse Quintavalle intendeva altro, ma in questo contesto ritengo sia doveroso definirne meglio i parametri. Non credo che Schifano faccia riferimento ad una memoria tanto lontana quando dipinge queste opere, infatti risultano coerenti a quel tessuto sociale che lo circondava, non credo, inoltre che si possa eleggere la soluzione della memoria ad una motivazione operativa, soprattutto se quello che vediamo nelle tele coincide con ciò che stava accadendo in Italia, il fatto di rivisitare il futurismo, la vedo più come un’operazione semplice di chi vuole prendere una emblema artistico italiano e stravolgerlo con una reminescenza pop. La tecnica, lo stile, è l’emblema che lo caratterizzerà negli anni successivi, il sapore pop è molto forte, quindi più che di memoria credo si debba parlare di abbracciare (più o meno) le correnti artistiche del momento. Schifano non fa altro che prendere in esame delle soluzioni che anche altri artisti adottano, ne modifica il contenuto aggiungendone dei particolari, più o meno tecnici, e con la sua dote di originalità riesce a farne momento caratterizzante per interi cicli. Quando capisce che il risultato gli piace, lo esegue in una ripetizione più o meno indefinita. Il soggetto rimane, si modificano le tecniche di realizzazione. La dimensione cercata è sicuramente una nuova, non esistente ma non finalizzata a delle memorie, piuttosto incentrata in visioni che rispecchiano gli ambienti di romani passando per quelle riviste specializzate che circolavano nel caffè Rosati. Alto punto labile della questione è quello che indica l’utilizzo di uno schema fisso per ovviare alla fine le questione della memoria. Affermando questo Quintavalle sembra contraddirsi ulteriormente, a rimostranza, se prima parlava di ricostruzione di un immaginario per merito della memoria ora sembra ritrarre quello che ha detto delegando la questione a una soluzione di schema fisso idealizzato. A mia interpretazione lo schema fisso esiste in relazione ad una spazialità che non esiste, nel senso che quelle figure che in realtà sono sagome, risultano fluttuare in una collocazione spaziale ideale più che idealizzante. Attirano su di se l’attenzione poiché esse sono il soggetto che farà da canale nella scelta interpretativa che Schifano intende utilizzare nell’opera singola. Semplificando: se Mario decide di rappresentare dei manifestanti o dei futuristi il passo che compie è praticamente lo stesso, a livello di realizzazione, ma non più essere affidato nello stesso carattere semantico. Le parole cambiano e di conseguenza più che di uno schema si può parlare più di stile. Sentendosi padrone del proprio stile, Schifano, decide di riproporlo, e riprodurlo più volte, quasi in maniera ossessiva più che in termini di ricerca estetica dello schema. Incontestabile il fatto che dietro ad un’ opera pittorica corrisponda comunque una necessità compositiva che invita al facile giudizio estetico. Ritornando a parlare di po(p)litica si può incanalare il discorso nelle parole citate prima di Calvesi, dove queste operazioni artistiche seguivano il trend pop, con la voglia di cogliere un momento di particolare subbuglio politico legato ad un’Italia che voleva cambiare a tutti i costi, e che sentiva nell’ondata sessantottina la stessa novità legata alla diffusione delle notizie proiettate dal tubo catodico, “compagno” di vita. L’ottica pop di Schifano incarna quindi tutta l’essenza di quei movimenti che erano appunto movimenti di massa, mentre nel termine popolare si addensava tutta quella riscossa popolare rappresentata da una politica di moda. Nel ‘62 Warhol eleggeva Marilyn Monroe come soggetto perfetto nella sua ottica pop, due anni dopo Schifano utilizzava Marinetti e compagnia bella come emblema dell’italianità, il processo utilizzato dai due è identico, ed ancora Warhol dipingeva Mao Tse Tung e Schifano dipingeva i “compagni”. La seconda fase produttiva di Schifano viene generalmente rilegata ad una sorta di periodo di “crisi” e di disincanto dall’essenzialità dell’arte. In questo momento per Mario sembra prevalere una consapevolezza: il mezzo pittorico non riesce a soddisfare nell’interezza la necessità espressiva e soprattutto un linguaggio chiesto in questo momento. La realtà dei fatti, vista con distacco a distanza di anni rende molto chiara la questione, i mezzi di comunicazione stavano diventando sempre più i protagonisti nella quotidianità non solo di Mario ma della collettività. Facendo riferimento alla riproducibilità tecnica a cui fa riferimento Benjamin ricorrendo a Paul Valéry, si potrebbe dire che in questo caso la pittura per Mario perde l’ordine sacrale, autarchico, dell’opera d’arte. L’ interpretazione “benjaminiana” si muove verso una sorta di “liberazione” da diserzione dagli aspetti più rigidi dello spettacolo. Lo avevano già fatto altri artisti, ma questo è un caso da evidenziare in relazione alla “popolarità” del’ opera di Schifano; sembra, di fatto, essere un artista che da un momento all’atro viene sopraffatto da tutti quei mezzi di comunicazione che prima sembravano coesistere nella sua attività di artista. Per dirla con le parole di Abruzzese, negli anni sessanta era in atto un processo di “liberalizzazione” dell’immagine e del discorso, un forte processo di “spettacolarizzazione” che investe il quotidiano indebolendo i vecchi formati “rigidi” della messa in scena teatrale. E’ proprio in questo principio che sta l’atto di passaggio che va dalla pittura alla multimedialità, dirigendosi da quello che è stato per anni il passo successivo del disegno, la pittura, all’ utilizzo della protesi tecnologica. La fotografia poi il video e poi il cinema sono tutti elementi risultati necessari quanto confusionari nella ricerca artistica di Schifano, entrano in maniera invadente nella quotidianità, distorcendone la visione reale, in un processo che probabilmente nemmeno Mario immaginava quando nel 1954 iniziava a fare le prime opere. Con la stessa tendenza che prima figurativa, poi monocromatica e poi spostatasi verso il “Paesaggio anemico”, con una sorta di azzeramento della superfici in ferro cemento, riassume la sua mutevole e rapida ricerca artistica. Una libertà estrema, quasi anarchica dell’opera seguiva un po’ la pop art americana e se tra le assonanze con Jasper Johns riusciva a rimanere in sintonia con il suo tempo, nella relazione con Warhol c’è l’assonanza sul tema della comunicazione. L’arte contemporanea nella società di massa deve sviluppare comunicazione, entrare nell’immaginario collettivo, agganciare l’attenzione di un pubblico che è sempre più sedotto dalla televisione e dalla “società” dello spettacolo; ecco che l’arte anche in Mario diventa multimediale, si impossessa di strumenti capaci di diffondere la propria immagine, molto di più di quanto possa fare l’unicum, di un prodotto artigianale dell’artista che fino a questo momento era stata la pittura. Achille Bonnito Oliva, in un’ intervista in relazione alla mostra curata da lui stesso alla galleria d’arte moderna di Roma nel 2008, dice: Mario ha sempre lavorato sulla “pelle” della pittura e come si sa la pelle ogni riferimento ai serpenti è puramente ludico, la vitalità di Mario, anche il suo vitalismo, il suo erotismo, il suo attaccamento alla vita, lo portava anche ad essere presente nella conoscenza dei nuovi artisti, nove generazioni che l’hanno molto amato. Queste parole lasciano desumere quanto la pittura pur accantonata a sprazzi risulterà appunto “incarnata” nella pelle di Schifano, in una produzione artistica che mai riuscirà ad abbandonare quel mezzo. La peculiarità di riuscir a far coesistere i numerosi mezzi risulta fatale nel momento in cui quello schermo tanto decantato e blasonato dalla critica dal periodo monocromo prima, poi interrotto dall’insediamento di squarci pubblicitari, non riesce più ad essere amministrato e gestito da Schifano. Sembra avvenga l’opposto, ossia che lo schermo si impossessi di Mario, quasi cadendogli addosso, facendolo immergere nel mondo cinematografico, dando luce al solo galleggiare di un’esigenza indirizzata ad una produzione cinematografica. A questo processo si è susseguito un oscuramento del riflettore pittorico che pur rimanendo presente sembra non soddisfare a pieno la carriera artistica di Mario. La pluralità del mezzi, prima divisa tra le tele e la fotografia ora sembra in balia di un nuovo connubio di nuovi mezzi, che investono il cinema in primis e coinvolge in seconda battuta anche la musica. I riferimenti sono semplici, la prima commissione del film, tra l’altro coerentemente, mai realizzato, finanziato da Carlo Ponti, per finire con la costituzione del gruppo musicale “le stelle di Mario Schifano” che non riuscì mai a decollare in quello star system a cui tanto voleva appartenere. Nasce in questo clima la nuova ossessione, quella del cinema, del cinema d’artista che già a priori non aveva un’idea ben precisa, ma da relazionare come fase evolutiva rispetto al mezzo fotografico. Dopo il viaggio con Nancy Ruspoli, per girare il film documentario che avrebbe dovuto avere il titolo di “Laboratorio umano”, nato appunto dalla fascinazione per il mezzo cinematografico iniziava a pensare ad una produzione più seria. Anche qui però il dato rilevante fu l’insoddisfazione nel conoscere i tempi lunghi delle dinamiche cinematografiche. Tornato dal viaggio però non riesce realmente a rinunciare alla pittura, inizia i famosi “paesaggi tv” dove trapianta su tela le figurazioni televisive con la preparazione dell’emulsione fotografica. I primi soggetti ad appartenere a questa corrente sono le fotografie fate in America. Esse vengono rielaborate con un insieme di tecniche che comunque richiamano ad una pittura tradizionale, trovano nella rielaborazione fotografica un punto di partenza per rivisitare un lavoro di costruzione grafica antecedente. I lavori a cui si fa riferimento sono quelli presenti nel catalogo America America, come Pentagono, Era Nucleare, Medal of Honor, la Nasa, le sale di trapianto a Huston, Alamo Gordo dall’Archivio di Los Alamos, senza contare all’ingente quantitativo di fotografie che quotidianamente e ininterrottamente trasmettevano i canali televisivi. Da queste immagini sembra dunque trasparire un interesse che prima, Mario, non riusciva a riconoscere ed ad identificare come arte. Non è la programmazione televisiva il centro dell’interesse, ma l’immediatezza dell’immagine che si sviluppa con il mezzo televisivo. Dopo questa produzione americana infatti il rapporto con la macchina fotografica inizierà ad essere più maturo e cosciente, diventando vera e propria protesi nel filtro della vista di Schifano. Volendo affidarci brevemente alla psicanalisi non si può fare a meno di una riconduzione “freudiana”. Il mondo del subconscio per Mario non sembra fare altro che coincidere con un’esigenza di un nuovo vedere collettivo. L’indirizzo adottato da Mario non è altro che uno specchio dell’esposizione immaginaria della società che lo circondava, il nuovo entusiasmo per il mezzo era dovuto ad una fonte di ispirazione del quotidiano. Nelle memorie di Arturo Carlo Quintavalle si rintracciano elementi importanti di questa nuova ricerca; alla risposta sul perché intervenire sulla fotografia con la pittura fino a volte stravolgere l’immagine iniziale si risponde: “il riferimento era a Andy Warhol, “l’incidente” oppure la “Sedia elettrica”, ma Schifano usava le immagini del televisore in modo diverso; fra l’altro erano le opere più recenti, quelle ricavate da scatti fotografici alla TV, Mario prima di tutto usava dialogare con qualche opera d’arte del passato, ma non lavorava sul dipinto ma sullo scatto che aveva fatto sul dipinto ripreso da una trasmissione TV, da un documentario. Così aveva scelto Carrà oppure de Chirico, ma non solo loro; utilizzava come “basi” anche i film d’azione oppure pellicole di anni Trenta magari dei gialli, e questi frammenti della memoria erano come un caleidoscopio di immagini tutte contemporanee, anche quelle che scattava ad opere d’arte del passato. Mario continuamente scomponeva e ricomponeva le immagini che passavano per la Tv perché voleva esprimere una dissociazione, una diversità, la possibilità delle figure di trasformarsi di senso sia modificandone la forma con lo scatto che non sempre era in asse, ma a volte scorciato da lato, da sopra sia intervenendo sul colore.” La sua fortuna nell’opera, pur indirizzata alla fotografia ed al video in questo momento, è stata di mantenere una volontà espressiva attaccata alla pittura mutandola nel linguaggio esecutivo. Lo schermo ora è emerso, diventa il soggetto, abbandonando definitivamente la “visione” di Schifano che per anni è stata l’esternare di una proiezione mentale. La creatività di Mario sta dunque tra l’immediatezza e l’incoscienza di un processo che riflette il grande cambiamento comunicativo che stava avvenendo. Schifano in questo processo trova nella continua voglia sperimentale la stessa fortuna che ha l’uomo che si trova nel posto giusto al momento giusto, aggiungendoci una controtendenza che non lo legava fino in fondo a nessun movimento artistico. Lo schermo inizialmente vuoto ora veniva dipinto dalle immagini delle trasmissioni televisive, il nuovo mezzo insinuava un nuovo modo di vedere il mondo, Mario procedendo per scomposizioni trovava la giusta distanza dal mezzo, operando in una suddivisione di immagini che reinterpretate servivano a sua volta a ricomposizioni filologiche contemporanee con il suo modo di dipingere. Il genio in Schifano sta nel far ricadere nell’artigianalità del mezzo pittorico la modalità di approccio comunicativo della televisione, che come dice Goffredo Parise ripercorre una intelligenza artistica che riesce a rimanere in bilico tra l’apparenza e l’essenza della pittura. Mentre su Michelangelo Pistoletto posso dire che inizia ad indagare sulla dialettica tra riprodotto e il riflesso, concentrandosi sullo sfondo dei suoi dipinti dall’autoritratto su una superficie oro, argento e rame, passa all’acrilico e alla vernice plastica su tela. Il 1961 è l’anno di svolta che lo porta al primo Quadro specchiante stendendo uno strato di vernice trasparente su una tela nera nota il suo stesso riflesso, e che non avrebbe più avuto bisogno di uno specchio per osservarsi. Da quel momento si dedica alle superfici specchianti e nel 1962 ne mette a punto la tecnica. I Quadri specchianti vengono esposti per la prima volta nella personale di Pistoletto alla Galleria Galatea nell’aprile del 1963, a cui sono subito seguiti riconoscimenti a livello internazionale: già nel corso degli anni Sessanta espone presso prestigiose gallerie europee e americane. Tuttavia, nonostante il successo ottenuto, l’artista continua ad interrogarsi sull’incontro tra prospettive opposte: la realtà davanti e dietro la superficie specchiante. Nel 1964 presenta I Plexiglass, sette lavori in plexiglass e fotografia, che vogliono trasporre nello spazio fisico la nuova dimensione aperta dai Quadri specchianti, contingente e dinamica. L’uomo non può entrare fisicamente nella realtà del quadro, è necessario estrarre l’oggetto dalla bidimensionalità, passando così alla tridimensionalità. Pistoletto di fatto apre con I Plexiglass il dibattito sulla “concettualità dell’arte” . Ad esempio, il primo della serie è Il muro, una semplice lastra di plexiglass appoggiata alla parete. Con questa azione l’artista induce l’osservatore a soffermarsi su una precisa porzione di parete, dove il plexiglass è solo uno strumento per trasformare il muro da presenza statica e anonima a vero e proprio soggetto dell’opera. La seconda opera della serie, Scala doppia appoggiata al muro dà l’illusione di essere un oggetto concreto; tuttavia, avvicinandosi all’opera l’osservatore si accorge che si tratta della fotografia di una scala riportata su due lastre di plexiglass appoggiate al muro. Gli anni 1965 e 1966 sono dedicati ad una diversa ricerca artistica, gli Oggetti in meno, con cui Pistoletto rompe il dogma per cui lo stile di un artista debba essere riconoscibile, come fosse un marchio di fabbrica. Gli oggetti esposti si basano sul principio delle differenze, sembrano infatti appartenere a una collezione collettiva e non ad una personale di un unico artista. Gli Oggetti in meno racchiudono una forte teatralità: il modo in cui gli oggetti si dispongono e occupano lo spazio sembra alludere alle performances degli attori sul palco scenico, trasformando l’opera in una riflessione sulle possibilità che ha l’arte nella società contemporanea. Inoltre, gli Oggetti in meno anticipano la nascita del movimento dell’Arte Povera, di cui Pistoletto sarà sostenitore e protagonista. Questa definizione viene data nel 1967 dallo stesso critico per indicare le ricerche che usano in modo diversificato materiali non legati alla tradizione dell’arte, come legno, carta, brandelli di stoffa, gesso, pietre e paglia oppure altri elementi come la terra, l’acqua e il fuoco. Si tratta di processi creativi che mirano a riscoprire quelle forze profonde dell’immaginazione che rimangono inespresse, attraverso un viaggio alle origini della facoltà percettive. Con il termine “povera dell’arte” si intende dunque recuperare il valore primario dei materiali, vissuti nel rapporto diretto con la vita quotidiana e percepiti nella loro forma originaria, fuori dall’uso e del significato assunto nella società dei consumi. In occasione della prima mostra Arte Povera – IM Spazio, organizzata da Masnata e Trentalance presso la loro Galleria “La Bertesca” a Genova nel 1967, tra il 27 settembre e il 20 ottobre, curata da Celant, compare per la prima volta, a sorpresa, la dicitura “Arte Povera” poiché, come ricorda Pistoletto: «È solo nel catalogo che si è scoperta l’espressione “Arte Povera”, di cui nessuno sapeva nulla prima dell’apertura della mostra stessa». Un termine strano, che lasciava e lascia tutt’ora perplessi alcuni degli artisti che ne fanno parte come Pistoletto, che confida a Giovanni Lista: «Devi chiedere il perché di questa parola “povertà” a Germano Celant. Ho sempre avuto dei problemi in proposito. Personalmente, non so nulla di cosa volesse dire». Le connotazioni che può assumere sono spesso ambigue, come fa notare sempre l’artista biellese: «Mi ha sempre causato una strana sensazione perché da giovane, facendo del restauro con mio padre, avevo avuto l’occasione di restaurare mobili definiti di “Arte Povera”, sistema decorativo veneziano del XVIII secolo. Non era pittura, ma una sua imitazione. Così, quando sentivo questa parola, avevo sempre paura di questa idea contenuta nella parola “povera”. Oltretutto, temevo la connotazione politica, non la politica in sé, ma la connotazione del “politico” ripresa a quell’epoca». Talvolta possono addirittura compromettere la corretta comprensione del lavoro di questi artisti, come quando l’aggettivo è associato a una miseria di intenti e mezzi che non rientrava nelle idee e nelle inclinazioni del gruppo. Ma con il termine “povero” Celant si riferiva a ben altro, a una concezione del termine che esula dall’uso comune e che si rifà al progetto e alla scuola del teatro povero di Jerzy Grotowski, in cui il regista e l’attore rifiutano tutti quegli elementi superflui una ricchezza di sovrastrutture espressive con cui il teatro si è sempre soffocato e che ostacolano il vero incontro dell’interprete con se stesso e con i suoi impulsi, per avviare una ricerca personale volta a rimetterlo in contatto “con gli strati intimi del proprio essere” e che si traduce, sul piano della recitazione, in un gesto puro e semplice, “essenza di un’espressione integrale”. Nel primo saggio critico dedicato all’Arte Povera, redatto in occasione della prima mostra genovese, scrive Celant: «Eliminano dalla ricerca tutto ciò che può sembrare riflessione e rappresentazione mimetica, abitudine linguistica, per approdare a un tipo di arte che ci piace chiamare povera. Il teatro elimina la sovrastruttura scritto-parlata, realizza il silenzio fonico e la parlata gestuale. Le situazioni umane elementari diventano segni, nasce l’esigenza di una vera semiologia basata sul linguaggio dell’azione». Questa eliminazione delle convenzioni iconografiche parassitarie per ridursi alla semplicità del segno in Grotowski si presenta come unico modo per conferire a quell’incontro che è il teatro la pregnanza di un’esperienza diretta e povera di artifici tecnici, basata su gesti autonomi e dotati di una sostanza propria e che si pongono lungo quel filo che collega l’attore allo spettatore. Si rimane all’interno della pratica teatrale, Grotowski si oppone solamente a un certo modo di fare teatro. Al contrario in Celant la depurazione del linguaggio si pone come atteggiamento in aperta opposizione non solo nei confronti del modo di fare arte ma anche rispetto alle dinamiche culturali e del sistema dell’arte allora in atto: il rifiuto delle costruzioni stilistiche e la nascita di una “decultura” all’insegna dell’“insignificante visuale” e delle azioni vengono sbandierati come i comandamenti fondanti un nuovo movimento anticulturale non tanto perché si senta il bisogno di un effettivo rinnovamento delle forme ma per creare una “nuova semiologia” che non può essere addomesticata dal sistema mercantile dell’arte. Eppure nella critica militante di Celant non si riesce a rintracciare un manifesto degli ideali politici definiti in maniera chiara, la cui mancanza riduce il tutto a un contrasto superficiale, genericamente “anti”. Tra l’altro, il rifiuto della sostanza fonica e del testo che Celant riconduce a Grotowski non è presente nella teorizzazione del regista polacco. In primo luogo, il suono e la voce sono considerati, al pari del gesto e dei movimenti, segni ed espressione dell’essere. In seconda battuta il testo, se da un lato non deve essere “la fonte creatrice del teatro”, dall’altro però è lo “stimolo del processo creativo” e avvia il processo di presa di coscienza personale. Questo perché in Grotowski il testo non deve essere interpretato o rielaborato, ma essere l’innesco di una creazione teatrale in cui le parole in sé perdono d’importanza e diventa fondamentale solamente ciò che si può ricavare da esse, ciò che gli dà vita e le trasforma in “Verbo”. Molti altri sono gli elementi prelevati dalle tesi di Per un teatro povero: intanto non può non saltare agli occhi la medesima contrapposizione a un’arte ricca, che opera una cleptomania del sistema, dei linguaggi codificati e artificiali. C’è poi da sottolineare come la simultaneità di idea e immagine che concretizza le opere artepoveriste non sia nulla di diverso dalla contemporaneità di impulso e azione che negli attori si traduce in impulsi visivi. Allo stesso modo, l’artista che «diventa il linguaggio di se stesso e lo è, con il suo corpo e i suoi gesti», si colloca sullo stesso orizzonte dell’attore che ricerca “il proprio linguaggio psico-analitico personale di suoni e gesti”. Inoltre Celant tenta di liberare la nuova arte dal giogo della sua stessa storia applicandovi le conclusioni di Grotowski, elaborate esclusivamente per il teatro, come se l’arte potesse trovare la soluzione dei suoi problemi solamente al di fuori delle sue possibilità d’azione, in un ambito ad alto livello di specificità e con una storia altrettanto corposa e ingombrante alle spalle. Con ciò non si vuole dire che le invasioni di campo, i prelievi di stratagemmi e tecniche tra un’arte e l’altra siano impossibili o sbagliati, anzi, sono proprio ciò che anima, vivifica e rinnova i diversi linguaggi, i quali tuttavia per evolversi in nuove forme dovranno ragionare sugli elementi costitutivi che li differenziano a livello essenziale dagli altri e gli conferiscono quelle caratteristiche proprie che li rendono ciò che sono e nient’altro. La ricerca di Michelangelo Pistoletto è in sintonia con l’Arte Povera questo lo si evince dall’opera: La Venere degli stracci è l’opera emblema dell’Arte Povera. Pistoletto fa dialogare il tempo passato (la Venere) e il presente (gli stracci), l’ordine e il disordine, ciò che è Bello per antonomasia, e ciò che è ormai vecchio, rovinato, da buttare. L’opera è diventata poi icona di riciclo: come il re Mida trasformava in oro tutto ciò che toccava, così la Venere degli stracci, trasfondendo la sua bellezza etera a una massa indistinta di rifiuti, dona loro nuovo splendore. Nello stesso anno Pistoletto decide di uscire dai canonici spazi espositivi e dedicarsi ad un progetto che includesse artisti di ogni genere. Invitato ad esporre con una sala personale alla XXXIV Biennale di Venezia, pubblica in aprile il Manifesto della collaborazione . L’artista decide infatti di collaborare con pittori, musicisti, attori e cineasti, in un ampio progetto di performances che tra il ‘68 e il ‘70 danno vita agli spettacoli Lo Zoo, concepiti come partecipazioni creative, una proposta alternativa alla comunicazione tramite oggetti. Successivamente Pistoletto dedica l’anno a cavallo tra l’ottobre del 1975 e il settembre del 1976 a Le Stanze, la prima di tre opere dalla dimensione temporale di un anno denominati “continenti di tempo” seguiranno Anno Bianco nel 1989 e Tartaruga felice nel 1992. Il progetto prevede dodici mostre, una al mese, allestite nei tre ambienti della Galleria Stein di Torino, collegati da altrettante porte delle dimensioni simili ai quadri specchianti . Con Le Stanze, Pistoletto identifica “nello specchio esposto il fenomeno dell’unicità, dell’unità e quindi della singolarità”, ovvero il fatto che lo specchio può riflettere e quindi raddoppiare tutto, tranne se stesso. Con Le Stanze l’artista anticipa al pubblico la sua successiva ricerca artistica, basata per l’appunto sulla divisione e dello specchio. Nel 1978 in occasione della mostra Divisione e moltiplicazione dello specchio. L’arte assume la religione Pistoletto presenta le due linee principali lungo le quali si svilupperà il suo lavoro futuro. La prima nasce dalla constatazione che lo specchio può riflettere qualunque cosa, tranne se stesso. Tuttavia, tagliando lo specchio in due parti e spostando lungo l’asse della divisione una delle due metà verso l’altra, lo specchio si auto riflette e si moltiplica, aprendo una prospettiva che si moltiplica all’infinito. La ricerca dell’artista sul concetto di divisione e moltiplicazione, tuttavia, non è unicamente artistica, bensì anche sociale: la suddivisione non è altro che condivisione, un’alternativa all’accumulazione e potenziale soluzione all’esclusione del diverso dalla società, di cui ogni individuo deve essere compartecipe. Pistoletto attraverso la sua arte intende stimolare lo spettatore ad essere cittadino responsabile in una società e equa. La seconda linea, L’arte assume la religione, riconosce una maggiore autonomia dell’arte rispetto al secolo precedente, in cui era prevalentemente uno strumento per la rappresentazione politica o religiosa. L’arte assume la religione vuole dare centralità all’arte e riavvicinarsi alla gente. Questa ricerca viene approfondita successivamente dall’artista con Progetto Arte (1994) e la Fondazione Pistoletto Cittadellarte (1998). Nel 1993 inizia una nuova fase di lavoro chiamata Il Segno Arte, che si svilupperà in due direzioni: una serie di opere realizzate dall’artista e l’invito aperto a ciascuno di realizzare il proprio Segno Arte. Il Segno Arte di Pistoletto è una figura geometrica formata dall’intersezione di due triangoli, definizione di un nuovo equilibrio tra le proporzioni del corpo umano. Pistoletto parte dalle misure del proprio corpo, così come Leonardo Da Vinci per L’Uomo Vitruviano , per definire una figura che idealmente rappresenta un uomo con le braccia alzate e le gambe divaricate . Pistoletto di fatto riconsidera le radici rinascimentali de L’Uomo Vitruviano, presentando con Il Segno Arte quella che lui chiama re-birth, una rinascita del corpo umano riletto in chiave contemporanea. L’artista sente la necessità di guardare alla persona come elemento singolo che allo stesso tempo è parte di un universo: per definire Il Segno Arte, Pistoletto si interroga su cosa sia la “vita”, che egli figura nell’ombelico; da questo punto, l’artista sviluppa le linee che definiscono la sagoma de Il Segno Arte, in cui ha poi inserito L’uomo Vitruviano . Fin dai suoi esordi come pittore, Pistoletto si interroga sulla presenza di sé nel mondo, al punto che inizialmente predilige l’autoritratto come mezzo figurativo. In un primo momento dipinge volti che occupano tutta la tela, per poi decidere di ridurre il soggetto dipinto a dimensioni naturali . In questo stesso momento l’artista inizia a interrogarsi sul rapporto tra soggetto e sfondo. Per dipingersi, Pistoletto usa uno specchio, ed istintivamente tenta di riprodurre l’immagine riflessa direttamente sulla tela. I primi tentativi prevedono l’utilizzo di pittura argento, oro e rame per creare uno sfondo riflettente , tuttavia questa tecnica non soddisfa l’artista. In un secondo momento stende uno sfondo nero, con sopra mezzo dito di vernice, e qui si accorge del suo riflesso nel lucido dello sfondo. La ricerca artistica di Pistoletto si concentra ora sulla scelta dei materiali e sulla messa a punto della tecnica, a cui arriva nel 1961 dopo svariati tentativi: riporto fotografico di figure a grandezza naturale su carta velina applicata su lastra di acciaio inox lucidata a specchio, velina che dal 1971 sarà sostituita da un processo serigrafico di riproduzione dell’immagine fotografica . I Quadri specchianti diventano a questo punto le fondamenta della produzione artistica di Pistoletto. Già dal primo esempio l’artista si rende conto dell’impossibilità di fissare qualcosa come definitivo o assoluto, poiché l’inclusione dello spettatore e della dimensione reale del tempo attraverso la superficie specchiante rendono l’opera in continuo mutamento . Da questo momento il tema del tempo e della transitorietà spazio-temporale diventano centrali per comprendere il lavoro dell’artista, il quale, superando i virtuosismi tecnici, riesce a creare un’opera dove la presenza dello spettatore è necessaria perché essa sia completa. Con i Quadri specchianti si entra direttamente in una realtà quadridimensionale , dove il rapporto tra la figura applicata in primo piano e lo sfondo specchiante non è altro che il rapporto tra ciò che rimane sempre uguale e ciò che può cambiare, tra ciò che non può ricevere nulla e ciò che può ricevere tutto, perché specchia. L’osservatore, muovendosi davanti alla superficie specchiante, modifica la realtà raffigurata: l’istante dell’opera coincide con quello dello spettatore, ed è quindi possibile entrare e uscire dal quadro, spostarsi a destra e sinistra, interagire con la figura applicata, avendo così la sensazione di essere protagonisti di un nuovo mondo, perché nei quadri specchianti la realtà entra a far parte dell’opera. Obbligando lo spettatore a diventare parte dell’opera, i Quadri specchianti diventano così una metafora dell’uomo contemporaneo, che viene posto davanti a scene di vita quotidiana: una ragazza che cammina, una donna nuda mentre fa il bagno, due persone che chiacchierano. Tuttavia, sebbene il soggetto delle immagini riprodotte sulla lastra specchiante rimane l’uomo nella sua quotidianità, nel corso degli anni le figure rappresentate passano da esse prevalentemente singole a coppie, spesso giovani che si abbracciano, si baciano o si guardano intensamente negli occhi. Inoltre, includendo l’uomo contemporaneo nell’opera, introduce temi esistenziali per l’uomo stesso, come il trascorrere del tempo insieme all’anonimità con cui viene vissuto il presente . Con i Quadri specchianti Pistoletto riapre e approfondisce in due direzioni il dibattito sulla prospettiva. È importante ricordare che proprio lo studio prospettico de La Flagellazione di Piero Della Francesca ha stimolato l’interesse pittorico dell’artista chelo ha portato ai Quadri specchianti, mettendolo davanti a un impegno che diventa da quel momento di primaria importanza: partendo dalla modernità, scoprire con l’arte una nuova apertura per la società, proprio come il Rinascimento aveva fatto con il Medioevo . Da una parte viene infatti ribaltata la prospettiva rinascimentale, che nelle superfici riflettenti non è più lineare e chiusa, ma infinita. Dall’altra, crea una nuova prospettiva, contemporanea. Già Duchamp con Le Grand Verre: La mariée mise a nu par ses célibataires même permette allo spettatore di osservare oltre al quadro: l’artista sceglie il vetro come supporto, un espediente per evitare chiudersi nella tradizione della tela. Anche Duchamp sperimenta tecniche inusuali alla ricerca di una nuova dimensione, in questo caso data dalla trasparenza dello spazio. Lo spettatore viene gettato al di là dell’opera. Tuttavia, i Quadri Specchianti superano la prospettiva di Duchamp. Nelle opere di Pistoletto il nostro sguardo viene bloccato da una superficie specchiante che ci obbliga a guardare non tanto oltre quanto indietro, portandoci a rivolgere la nostra attenzione ad una realtà che, in fondo, è il mondo stesso a cui noi apparteniamo. La prospettiva cambia perché cambia il ruolo dello spettatore, non più semplice fruitore, ma protagonista . Il progetto del Terzo Paradiso “nasce dall’esperienza di una vita che ormai da decenni si è dedicata alla trasformazione responsabile della società attraverso la funzione generativa dell’arte”. I temi affrontati riguardano l’ambiente, la politica, l’economia, l’educazione, la spiritualità, in generale la sopravvivenza dell’uomo sulla Terra, attraverso i quali l’artista intende aprire nuove prospettive che possano ispirare un cambiamento sociale responsabile . L’artista sottolinea come gli avvenimenti politici di quegli anni, come la dichiarazione di guerra all’Iraq da parte di Bush e Blair, suscitassero in lui un profondo turbamento. Pistoletto in quel momento ha sentito la necessità di prendere parte, con la sua Arte, al coro di persone che scendeva in piazza per dire “Basta!”. Pistoletto sorprende il pubblico con la formulazione del teorema della “Trinamica”, la dinamica del numero tre, secondo cui 1 + 1 = 3. La “Trinamica”, spiega l’artista, è la formula della creazione: l’incontro di due polarità crea infatti una terza realtà, che è sintesi delle prime due. La “Trinamica” è, per Pistoletto, la scienza delle relazioni e degli equilibri . Il simbolo concepito dall’artista è una rivisitazione di quello matematico dell’infinito , una linea continua che passa da formare due a tre cerchi allineati . I due cerchi esterni, tendenzialmente più piccoli, sono le polarità iniziali; il cerchio centrale è la creazione del nuovo elemento. Pistoletto utilizza poi il simbolo della “Trinamica” come simbolo del Terzo Paradiso, dove il primo cerchio rappresenta il passato più remoto, era in cui l’uomo viveva in armonia con la natura il secondo, invece, rappresenta la fase più recente del passato, quando l’uomo si è allontanato dalla natura, avviando il processo che ci ha portati al mondo artificiale in cui viviamo . Il punto di unione tra i due cerchi rappresenta il presente, che secondo Pistoletto soffre una pressione troppo forte determinata dagli squilibri creatisi tra mondo naturale e mondo artificiale. Proprio nel punto di unione dei due cerchi l’artista crea il Terzo Paradiso, il futuro dell’umanità. Sorge spontaneo chiedersi perché l’artista abbia scelto di chiamare questo spazio “Paradiso” e non semplicemente mondo, per esempio. Tuttavia, non bisogna pensare al Paradiso di impostazione cristiana, luogo ultraterreno dove i giusti godranno di ogni beatitudine, bensì cercare l’etimologia della parola nel persiano antico (poi anche nel greco), dove il paradiso indica il “giardino protetto”, luogo di serenità, protetto dall’aridità del deserto circostante. In questo contesto l’uomo, partecipe di una società responsabile, deve rendersi sempre più consapevole del suo ruolo di “giardiniere”, e quindi artefice dell’ambiente che lo circonda . Pistoletto non esita ad utilizzare metafore per spiegare al lettore/spettatore l’importanza del ruolo del cittadino responsabile. Per esempio, ricorda che in un giardino la materia organica si riproduce in maniera autonoma senza creare scorie di smaltimento. Dal Novecento in poi, l’idea moderna di benessere e di consumismo ha portato ad una costante insoddisfazione delle persone; questo meccanismo ha innescato a sua volta un eccessivo sfruttamento del nostro pianeta. Attraverso il Terzo Paradiso, Pistoletto diventa protagonista di progetti per il risanamento ambientale, con i quali aspira a generare cambiamenti di portata globale nella compartecipazione di tutti. Pistoletto approfondisce la sua teoria della Moltiplicazione e divisione dello specchio del 1978, inserendola ora nel contesto sociale ed economico del Terzo paradiso. Il passaggio dal mondo naturale al mondo artificiale avviene nel momento in cui l’uomo, interagendo con l’ambiente intorno a sé, si rende consapevole del cambiamento che sta apportando. Inizialmente questo processo ha avuto un effetto positivo sull’uomo, portandolo ad una qualità di vita più elevata; tuttavia, nel tempo, l’unione del concetto di potere e di artificio si è fatta culturalmente sempre più stretta, fino ad arrivare all’epoca moderna in cui gli sviluppi scientifici e tecnologici hanno portato a forti squilibri globali, basti pensare al fenomeno del colonialismo dell’Ottocento, o all’attuale situazione dell’Africa o del Sud America rispetto ad Europa e Nord America. I paesi che nell’epoca moderna non hanno vissuto la parabola di crescita sono stati soggiogati e vengono tuttora sfruttati dai paesi che la hanno sperimentata . Pistoletto spiega come le teorie darwiniane abbiano giustificato il colonialismo e l’estremo liberalismo del Novecento, spingendo verso una sempre maggiore divisione tra paesi poveri e paesi ricchi. Attualmente però la scienza e il mercato, spiega l’artista, stanno riponendo maggior fiducia negli scritti di Lamarck, secondo cui: “Il cambiamento è il risultato non solo di un macroadattamento alle condizioni ambientali, ma anche di una microdinamica individuale atta a superare le difficoltà presenti nel proprio ecosistema.” Oggigiorno, sembra che il libero arbitrio del singolo stia acquisendo maggiore importanza, e proprio in questo frangente si inserisce il pensiero di Pistoletto, secondo cui l’individuo non è impotente davanti ai grandi sistemi, ma può produrre una trasformazione nella collettività a partire dalla propria dimensione individuale. Pistoletto trova risposta nel suo lavoro di Divisione e moltiplicazione dello specchio. Lo specchio da solo è niente, perciò gli attribuisce il valore numerico dello zero; successivamente divide a metà lo specchio, così che possa riflettere se stesso, e gli attribuisce il valore numerico del due. Grazie alla divisione, sostiene Pistoletto, avviene la moltiplicazione, esattamente come in natura avviene tra le cellule, le quali dividendosi si moltiplicano inizialmente per due, avviando poi un processo di rigenerazione fino alla formazione di un corpo. L’artista fonda così le basi della legge sociale che chiama “condivisione”, la quale dovrebbe portare alla diffusione di benessere e ricchezza per l’intera comunità. Secondo Pistoletto questa teoria è applicabile non solo a livello sociale, ma anche economico. Assumendo infatti la moltiplicazione come principio di economia sociale, ci si svincola dal capitalismo che ha generato gli squilibri sociali in cui viviamo, dall’accumulazione quindi di beni da parte del singolo, andando a favorire il benessere della collettività . Rompendo lo specchio in tanti pezzi si evince come la linea che unisce le forme diverse, (le singole persone) in un’unica visione (la società) è proprio la linea di condivisione . Pistoletto insiste sull’importanza dell’intera collettività per raggiungere l’obiettivo di una trasformazione globale, a partire proprio dagli intellettuali che, grazie al loro lavoro, possono stimolare il senso di responsabilità dei singoli cittadini. L’impegno intellettuale deve trasformarsi in uno sforzo competitivo finalizzato alla creazione di nuovi valori, rendendo la competizione condivisione. Pistoletto passa poi dalla teoria alla pratica, spiegando come l’educazione sia il primo passo verso questa trasformazione sociale responsabile: proprio dedicandosi alla formazione dei bambini si mette in atto una trasformazione di sé. L’orientamento del singolo all’interno della comunità si sviluppa nei primi quindici anni di vita, perciò il concepimento di una nuova società è possibile a partire dai più piccoli . Ancora una volta Pistoletto non manca di utilizzare metafore per instaurare un dialogo diretto con il lettore. In questo caso sceglie il computer, strumento con cui tutti hanno ormai familiarità. Infatti, come il computer funziona grazie ad un sistema operativo ed a programmi che raccolgono e rielaborano i dati inseriti, così succede anche con l’apprendimento: un bambino raccoglie le informazioni dalla realtà che lo circonda, le rielabora e le assimila. Successivamente l’artista si sofferma sull’evoluzione del computer negli ultimi decenni: da ingombrante macchinario, lento e dalle prestazioni limitate è diventato uno strumento di dimensioni ridotte, veloce e performante. L’uomo è, allo stesso tempo, il computer e il suo fruitore: come il sistema operativo del PC si è evoluto fino a raggiungere le prestazioni che conosciamo oggi, così il sistema cerebrale offre la possibilità di estendere le facoltà mentali oltre i limiti che possono sembrare insuperabili . Inoltre, è importante non sottovalutare la potenza creativa dei bambini, la cui fantasia è sempre alla ricerca possibili novità. Il problema principale dei metodi educativi più largamente utilizzati è quello di non riuscire a svincolarsi dalla tradizionale lezione frontale, che Pistoletto chiama “banco e lavagna”. Non è ancora stato introdotto un metodo educativo post-meccanico e postindustriale, sebbene la realtà, anche lavorativa, sia mutata notevolmente. Le opere all’interno coprono pressoché l’intera carriera di Pistoletto, dagli anni Sessanta con i quadri specchianti, Metrocubo di Infinito, Venere degli Stracci, Orchestra di stracci, gli anni Settanta con L’Etrusco e la serie delle Porte Segno Arte insieme ad Autoritratto di Stelle fino a lavori più recenti. Negli anni Novanta i Libri, nel Duemila i quadri specchianti oltre ai progetti legati alla formula della creazione, Love Difference – Mar Mediterraneo, al Terzo Paradiso. Nel percorso, le quattro grandi installazioni site specific prodotte da DART – Chiostro del Bramante, completano il percorso riproponendo e attualizzando lavori particolarmente significativi, come Grande sfera di giornali (1966 – 2023), costruita all’interno della sala fino a occupare le dimensioni massime consentite dallo spazio; Labirinto (1969 – 2023) che costituisce una via sinuosa e indirizza verso le altre sale espositive alterando la percezione dell’architettura, l’annuncio programmatico Love Difference–neon (2005 – 2023), installazione luminosa composta da venti scritte al neon e presentata per la prima volta in occasione della Biennale di Venezia, dove l’artista ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera, oltre a una versione del Terzo Paradiso, realizzata in polistirene e PVC colorato a vent’anni di distanza dalla prima ideazione nel 2003, che occupa gli spazi esterni. I 29 Uffizi sono tra loro comunicanti e interconnessi attraverso una serie di porte, ciascuna recante sull’architrave l’indicazione dell’attività specifica. La forma delle porte riprende il Segno Arte. Concepito dall’artista nel 1976, il Segno Arte è dato dall’intersezione di due triangoli, inscrivendo idealmente un corpo umano con braccia alzate e gambe divaricate. Il primo concetto di una architettura nell’architettura risale a Porte – Uffizi al MuHKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen di Anversa. Riprende e sviluppa un precedente (Le Porte di Palazzo Fabroni) del 1995 ed è un dispositivo espositivo utilizzato più volte da allora, ma sempre rispecchiando una classificazione che si potrebbe dare alla società di quel momento e proponendo contemporaneamente una città ideale. L’articolazione della città in Uffizi riprende una riflessione alla quale l’artista ha dedicato spazio in La formula della creazione, 2022, libro nel quale egli esamina il proprio percorso, identificando 31 passi che, conducendo alla genesi di una nuova società, diventano punti cardinali alla base della Formula della Creazione. All’interno della visione di una nuova comunità eticamente responsabile, la mostra è anche un dispositivo per coinvolgere le persone, a partire dai lavoratori che a vario titolo operano all’interno e orbitano attorno al Museo rendendolo un microcosmo di una possibile città ideale. Ogni giorno, una persona dotata di un sapere e di una prassi specifica in un’area per la quale esiste uno dei 29 Uffizi sarà il responsabile catalizzatore della giornata: ad esempio un addetto stampa sarà responsabile dell’Uffizio Comunicazione, mentre il medico competente potrebbe collaborare in una giornata dedicata all’Uffizio Salute, tanto quanto un’Artenauta potrebbe condurre una giornata sull’educazione, così come un responsabile della caffetteria potrebbe seguire la giornata dedicata all’Uffizio Nutrimento, il giardiniere essere responsabile dell’Uffizio Ecologia e un curatore quello dell’Uffizio Arte, mentre una bibliotecaria potrebbe occuparsi della giornata dedicata all’Uffizio Scrittura. In questa maniera l’artista revitalizza e reinventa il concetto di mostra temporanea e contribuisce a realizzare pragmaticamente un nuovo mondo basato sulla Demopraxia. Infine attraverso il percorso espositivo si configura come un viaggio nei principali centri d’irradiazione italiani di questo fenomeno prettamente metropolitano, nato a Londra nel 1956 e sviluppatosi in contemporanea nei grandi centri urbani dove la moderna società dei consumi e delle comunicazioni di massa si manifesta in maniera più evidente, da New York a Los Angeles e quindi in Europa, al punto da divenire la principale espressione artistica degli anni Sessanta del secolo scorso. Un itinerario tra quelle città – come Roma, Milano, Torino, Venezia, Palermo e Pistoia – che, attraverso una serie di connessioni, hanno recepito i temi e i linguaggi della moderna società dei consumi e della comunicazione di massa creando un terreno fertile per la diffusione della Pop Art. Un periodo di straordinaria vivacità e ricchezza creativa grazie agli artisti che hanno guardato alla scena internazionale, all’attività delle gallerie private, dei critici d’arte che hanno intessuto i rapporti tra l’Italia e il resto del mondo, dei collezionisti, delle riviste e delle istituzioni pubbliche che hanno saputo cogliere le novità e dare loro il giusto rilievo. Notevole è la presenza in mostra di importanti artiste, alle quali è dedicato anche un saggio in catalogo, un ulteriore segno di quella spinta al rinnovamento e alla messa in discussione dello status quo che investono la società e la cultura italiana del decennio.
Venezia: la Biennale e il mito americano
Il viaggio prende avvio da Venezia, con la storica Biennale d’Arte del 1964, che ospita quattro artisti americani che anticipano la Pop Art: Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Jim Dine e Claes Oldenburg. Rauschenberg vince il Gran premio per la pittura segnando l’affermazione della Pop Art e dell’arte americana sulla scena mondiale. Il percorso si apre proprio con tre lavori di Robert Rauschenberg (Blue Exit, 1961), Jasper Johns (Flag, 1969) e Roy Lichtenstein (Yellow and Black Brushstroke – Eat Art, 1970-1971) invitato alla Biennale del 1966, opere di autori che generano immediate reazioni negli artisti italiani che si appropriarono del loro stile e anche delle icone della società statunitense. Mimmo Rotella, ad esempio, in L’ultimo Kennedy (1963) usa un manifesto relativo alla visita in Italia del 1963 di John Fitzgerald Kennedy per comporre il ritratto del presidente americano con la tecnica del décollage, Ettore Innocente (Jasper Johnson alla Casa Bianca, 1964) cita le opere di Jasper Johns e allude con ironia a Lyndon Johnson, appena incaricato di succedere a Kennedy assassinato proprio alla fine del 1963, mentre Roberto Crippa (La mia Marilyn, 1964) si concentra sul mito hollywoodiano di Marilyn Monroe.
Roma: una nuova generazione
Un’ampia sezione si focalizza su Roma, il principale centro artistico nazionale di quegli anni, dove raggruppati nella “Scuola di Piazza del Popolo”, così chiamata in onore del Caffè Rosati e della Galleria La Tartaruga situati nei pressi della piazza, si ri trovano Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Mimmo Rotella, Mario Ceroli, Pino Pascali, Fabio Mauri, Jannis Kounellis, Titina Maselli, Giosetta Fioroni, Laura Grisi e altri ancora, sostenuti da galleristi quali Plinio de Martiis e Giuseppe Liverani, o da intellettuali quali Alberto Moravia e Goffredo Parise. Il gruppo si caratterizza per varietà di stili e linguaggi. Si va dalle soluzioni liriche, come la nave di Jannis Kounellis, o il cielo americano vagheggiato da Tano Festa (Cielo NewYorchese, 1966) all’analisi della politica del presente e del passato che emerge nei simboli imperiali della lupa capitolina (Testa di lupa capitolina che sbava, 1964) e dell’aquila americana (Frammento romano, 1965) ripresi da Franco Angeli, dal profilo del Segretario della Difesa americano Robert McNamara (1961-1963) di Sergio Lombardo al chepì, un copricapo militare francese, imbiancato da Gianfranco Baruchello (La révision du procès, 1962), per ricordare la lotta di liberazione dell’Algeria dal dominio coloniale della Francia. Nelle opere pop i riferimenti all’arte del passato dialogano con le allusioni alla cultura e alla società contemporanea. Se Giosetta Fioroni (Particolare della nascita di Venere, 1965) e Mario Ceroli (Goldfinger / Miss, 1964) rivisitano, trasformandola, la Venere di Botticelli, Renato Mambor crea rebus visivi accostando i monumenti romani come il Colosseo a silhouette di animali (Zebra e Colosseo, 1965). Gli oggetti quotidiani contribuiscono a dare forma alle rappresentazioni della società degli anni Sessanta. Le opere di Laura Grisi (Model Car Racing, 1967) e Pino Pascali (Baco da setola, 1968) alludono alla civiltà dei consumi e alle sue diverse manifestazioni scegliendo soggetti e materiali sorprendenti; Cesare Tacchi (Sul divano a fiori, 1965) sfrutta invece un elemento tipico dell’arredo borghese, la stoffa trapuntata, per rappresentare scene di vita domestica. Nella mostra di Pistoia non manca un affondo su Mario Schifano che inizia la sua ricerca con opere monocrome che rimandano all’essenzialità delle forme degli schermi e della segnaletica stradale, ma che già nel 1963 introducono i simboli più riconoscibili del consumismo e dell’influenza americana sugli stili di vita, come i loghi di Coca Cola o Esso. Se Schifano evoca le merci in forma di loghi e icone accompagnandoli con la scritta “tutta propaganda”, Titina Maselli con la sua bottiglia di Acqua minerale le presenta per quello che sono. Anche il corpo, frammentato e riprodotto all’infinito dal cinema e dai media, diventa merce. Umberto Bignardi ritaglia la bocca di Sofia Loren da una rivista, mentre Claudio Cintoli probabilmente riproduce nel suo dipinto quella di Ursula Andress, attrice cult del film Agente 007 – Licenza di uccidere del 1962, che divenne modello per il murale realizzato all’interno del Piper club a Roma, uno dei locali iconici della capitale cui si deve un impulso decisivo all’affermazione della musica Beat in Italia.
La Scuola di Pistoia
Proseguendo verso nord, le sale dedicate a Pistoia, presentano le opere di quattro autori, Roberto Barni, Umberto Buscioni, Adolfo Natalini e Gianni Ruffi, collettivamente denominati “Scuola di Pistoia”. Quello di Pistoia è un caso unico nel panorama artistico degli anni Sessanta. Muovendo dal piccolo capoluogo di provincia questi artisti sono in grado di dialogare, ciascuno con un proprio linguaggio personale e caratterizzato, con le forze più innovative della ricerca artistica del periodo e di fornire una precisa e riconoscibile interpretazione della Pop Art.
Viaggio in Italia: Torino, Milano, Firenze , Bologna, Genova, Palermo
L’itinerario continua a Torino, dove le gallerie Il Punto e Sperone, in collaborazione con la galleria Sonnanbend di New York e Parigi, introducono in Italia i lavori di Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Robert Rauschenberg. In questo clima crescono ed espongono autori come Michelangelo Pistoletto con i suoi quadri specchianti (Scala, 1964) e Piero Gilardi con i tappeti-natura (Cocomeri, 1966), due personalità che saranno presto protagoniste del fenomeno artistico dell’Arte povera nato proprio a Torino, oltre ad Aldo Mondino e Ugo Nespolo che rappresentano invece una versione particolarmente ironica e giocosa del linguaggio pop, che mischia riferimenti alla tradizione artistica moderna con i più popolari giochi enigmistici e puzzle. A questi autori si aggiungono nomi più defilati come Pietro Gallina o Anna Comba. Milano, punto di riferimento per la modernizzazione del Paese, anche in ambito artistico, vede affermarsi una versione della Pop Art più prossima al Nouveau Réalisme francese, e in seguito, anche per l’azione della Galleria Milano e dello Studio Marconi, un’altra d’ispirazione londinese, con autori quali Valerio Adami, Lucio Del Pezzo, Emilio Tadini. A questi si aggiunge Enrico Baj che, unendo gusto kitsch a raffinate citazioni, riesce a creare un collegamento tra dadaismo, surrealismo e Pop Art. Questo tour lungo la Penisola, che tocca realtà come Firenze, Bologna e Genova, ciascuna delle quali ha ricoperto un ruolo particolare nella diffusione della Pop Art in Italia con autori come Alberto Moretti, Roberto Malquori, Elio Marchegiani, Concetto Pozzati, Plinio Mesciulam, giunge infine a Palermo dove, a fronte di una situazione sociale complessa, si assiste alla formazione di una scena culturale vivacissima, come dimostrano le due edizioni della mostra Revort, che nel 1965 e nel 1968 presentano i maggiori rappresentanti della Pop Art internazionale nel capoluogo siciliano. Animatore di queste vicende è il musicologo Antonio Titone che per alcuni anni si dedica alla pittura con opere dal linguaggio pop particolarmente originali. La rassegna si completa con l’ultima sezione dove s’incontrano due figure icona della Pop Art inglese e statunitense: Richard Hamilton e Andy Warhol. Del primo si presenta una delle sue opere più conosciute, Swingeing London, che ritrae il musicista Mick Jagger e il gallerista Robert Fraser durante il loro arresto per droga nel 1967; del secondo, una serigrafia della serie Flowers, che racconta un immaginario psichedelico che segnerà a sua volta gli anni Settanta ormai alle porte. Le opere di Fabio Mauri e Franco Angeli, ancora pop nello stile, ma ben diverse nei contenuti, registrano la crisi della fase del “boom economico” tra contestazioni politiche e sociali. La mostra è corredata da un volume edito da Electa con un testo critico dedicato al contesto storico artistico della Pop art italiana di Walter Guadagnini, e affondi tematici di Raffaella Perna, Helga Marsala e Marco Bazzini.
Palazzo Buontalenti Pistoia
’60 Pop Art Italia
dal 16 Marzo 2024 al 14 Luglio 2024
dal Mercoledì alla Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00- Lunedì e Martedì Chiuso
Installation view della mostra ’60 Pop Art Italia, 2024, Pistoia. Courtesy Fondazione Pistoia Musei, © photo Ela Bialkowska, OKNOstudio