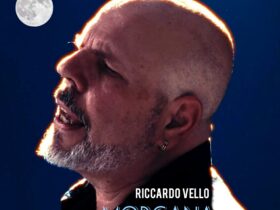in mostra al Museo Mart di Rovereto
Giovanni Cardone
Fino al 1 Settembre 2024 si potrà ammirare al Museo Mart di Rovereto la mostra Arte e Fascismo da un’idea di Vittorio Sgarbi a cura di Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari. Tra pittura, scultura, documenti e materiali d’archivio, il percorso espositivo si snoda tra 400 opere di artisti e architetti come Mario Sironi, Carlo Carrà, Adolfo Wildt, Arturo Martini, Marino Marini, Massimo Campigli, Achille Funi, Fortunato Depero, Tullio Crali, Thayaht, Renato Bertelli, Renato Guttuso.Provenienti da collezioni pubbliche e private le opere dialogano con alcuni dei grandi capolavori del Mart e con numerosi materiali provenienti dai fondi dell’Archivio del ’900. L’esposizione Arte e Fascismo analizza i vari e complessi modi in cui il regime fascista influì sulla produzione figurativa italiana, utilizzando a fini propagandistici i linguaggi dell’arte e dell’architettura. Affondando le sue radici nei decenni antecedenti e spaziando dalle pratiche tradizionali alle arti applicate, la cultura visiva del Ventennio testimonia lo svilupparsi di una varietà di stili senza precedenti. Diversamente da altri regimi, quello fascista non impone un gusto, facendo proprie anche alcune delle tendenze artistiche che si affermano in quel periodo storico. La mancanza di un unico orientamento facilita lo sviluppo di un’eterogenea e dinamica presenza di espressioni e correnti. Accanto al persistere di ricerche di avanguardia legate al Futurismo, si delinea una linea di “ritorno all’ordine”, che confluisce nel movimento del Novecento italiano, creato da Margherita Sarfatti. Il ritorno all’antico, funzionale all’affermazione della tradizione italiana, trova varie declinazioni, dal rinnovato sguardo ai maestri antichi dei protagonisti di Novecento fino a più radicali affermazioni di un’arte di propaganda volta alla costruzione del consenso. Il modello di una ritrovata armonia tra tradizione e modernità gode del consenso da parte del regime, alla ricerca della definizione di un sistema delle arti organizzato. Uno straordinario apparato di premi, esposizioni pubbliche, convenzioni e mostre permette al regime di intercettare gli artisti più significativi, di sostenerne l’opera e di inglobarli nel più ampio progetto di promozione generale. Attraverso la partecipazione a biennali, quadriennali, mostre sindacali, a concorsi e a commissioni pubbliche gli artisti danno voce all’ideologia, ai temi e ai miti del fascismo. Lo stesso rapporto tra gli artisti e il potere non è definito né unico. Accanto a figure dichiaratamente fasciste, convinte sostenitrici del Duce come Depero e Sironi,si muovono artisti meno ingaggiati, più o meno distanti ma comunque presenti nel ricco panorama italiano. Allo stesso tempo, i nuovi luoghi del potere divengono strumento di affermazione attraverso un linguaggio aperto tanto al classicismo quanto al razionalismo, che coinvolge architettura, scultura e arte murale, rinata sotto l’impulso di una rinnovata volontà celebrativa. Da un mio Saggio scritto a quattro mani con Rosario Pinto Valori Plastici E il Clima di Ritorno all’Ordine edito da Printart Edizioni Salerno dove descrivo Arte e Fascimo dicendo: In questo mio scritto ho cercato di tratteggiare il Futurismo per me c’è una differenza tra ‘Avanguardia’ e ‘Movimento’ per me il Futurismo è un movimento che ha messo insieme tante anime artistiche diverse. Il futurismo è in origine un movimento letterario italiano, fondato da Filippo Tommaso Marinetti agli inizi del 1909. Poiché Marinetti era bilingue e operava a Parigi, oltre che a Milano, il suo movimento è chiamato talvolta futurismo italo-francese. Il termine futurismo indica anche alcune avanguardie poetiche russe, che in qualche misura s’ispirarono alle teorie di Marinetti e che, con i loro maggiori rappresentanti, crearono opere di gran lunga superiori, per dignità letteraria, a quelle dei futuristi italiani. Non si ebbero altrove veri e propri movimenti futuristi, ma i termini ‛futurismo’ e ‛futurista’ sono stati spesso usati, in un senso più lato, anche a proposito di scrittori nelle cui opere prevalessero l’entusiasmo giovanile, la fiducia nell’avvenire, una visione dinamica della vita, l’avversione alle tradizioni e alle autorità e, contro il vecchio patrimonio culturale, s’inneggiasse alle manifestazioni della vita moderna e specialmente alle ultime conquiste della tecnica. Tali atteggiamenti coincidevano spesso con l’esigenza d’innovazioni formali in quanto, si sosteneva, un contenuto moderno richiede una forma radicalmente nuova. Prima della grande guerra, ma talvolta anche dopo, pure questi ‛futuristi’ s’ispirarono spesso, direttamente o indirettamente, alle idee di Marinetti. In questo articolo verrà esaminato il futurismo letterario in Italia e in Russia. Come limiti cronologici possiamo assumere lo scoppio della prima guerra mondiale per il futurismo italiano e la Rivoluzione d’ottobre per quello russo. Dopo queste date, i due movimenti ma naturalmente non sempre i singoli autori perdono la loro vitalità, i loro tratti futuristi, il loro rilievo internazionale, acquistando invece una più spiccata fisionomia politica. Marinetti continua a pubblicare una lunga serie di manifesti, che però sempre più raramente trovano risonanza fuori dai confini d’Italia e hanno spesso scarso rapporto con la letteratura. Continuare a usare il termine futurismo per un’arte ufficiale filofascista, borghese e reazionaria Marinetti divenne accademico d’Italia nel 1929 vorrebbe dire sottrarre al termine ogni plausibile motivazione etimologica. Dopo la Rivoluzione d’ottobre, molti scrittori futuristi russi, fra cui Majakovskij, salutarono con entusiasmo i nuovi ideali, ma il ‛comfuturismo’, per fare un esempio, si discosta così decisamente dal precedente futurismo russo, tanto nei contenuti quanto nelle forme, che anche in questo caso il termine futurismo perde molte delle sue connotazioni originarie. I futuristi ortodossi, dal canto loro, non forniranno più al dibattito estetico-letterario contributi degni di rilievo. Quanto la nozione stessa di futurismo fosse ormai svuotata di senso risulta chiaro se si riflette che tale termine viene ormai usato per indicare tanto una letteratura fascista quanto una socialista. Paradossalmente, si può dire che il futurismo è un tipico fenomeno di reazione, il quale trova la sua origine nella discrepanza esistente fra realtà e poesia in un dato momento storico. Intorno al 1900 la letteratura occidentale, e specialmente la poesia, è dominata dal simbolismo: corrente, nel suo complesso, trasognata, nostalgica, negativa nei confronti della realtà materiale circostante. Il progresso tecnico è ignorato e solo eccezionalmente si dà spazio, in letteratura, a motivi moderni. Ma questo è anche il periodo in cui la stampa e la letteratura popolare descrivono entusiasticamente, in uno spirito materialistico-evoluzionistico, i nuovi successi della tecnica che rendono piccolo il globo e permettono all’uomo di dominarlo: con accenti nietzschiani si lodano gli automobilisti sportivi e i pionieri del volo, si esalta la vita attiva, dinamica tipica della ‛mentalità americana’ e la forte umanità moderna che vive nelle megalopoli, ebbra di elettricità, di telegrafia senza fili, di cinematografia, delle nuove macchine e delle loro folli velocità: secondo i giornalisti, i corridori automobilisti ‛perforano lo spazio’ e ‛sfrecciano come sparati da un cannone’. Sono gli anni dei fratelli Wright e di Blériot. Sono questi aspetti della realtà che forniscono al futurismo lo stimolo più importante. Più che i letterati, sono i divulgatori, gli entusiasti filosofi improvvisati a influenzare Marinetti. Più che Du Camp, Whitman, Verhaeren, Romains, Adam, D’Annunzio e altri che, prima di Marinetti o contemporaneamente a lui, avevano inneggiato – ma con moderazione – al Moderno, è M. Morasso, il profeta del motore a scoppio, che riecheggia nei manifesti letterari di Marinetti: colui cioè che con La nuova arma (1905) e Il nuovo aspetto meccanico del mondo (1907) aveva salutato ‟l’uomo della velocità» e predicato la nuova ‟estetica della velocità», da cui sarebbero nate opere paragonabili alla Vittoria di Samotracia. Circa le ‛parole in libertà’ e le altre teorie tecnico-letterarie è probabile invece che gli esperimenti linguistici dei simbolisti abbiano, almeno indirettamente, svolto un ruolo importante: così per es., le teorie di Mallarmé sulle analogie, l’apparente anarchismo linguistico di Rimbaud e la sua immaginosa lingua ‛senza fili’, il sogno di R. Ghil e di altri simbolisti di creare l’art total e via di seguito. Il tentativo dei simbolisti introversi di dare una forma sfumata, poetica, al sogno, al mondo interiore, all’irrealtà, è però sostituito dalla concretissima raffigurazione che gli estroversi futuristi danno della realtà circostante.
I paroliberisti portano a termine, in modo inaspettato ma radicale, il lavoro iniziato dai versiliberisti. Che nel poeta simbolista Filippo Tommaso Marinetti fosse così forte la reazione contro il simbolismo può essere in parte spiegato con i suoi anni in Egitto e con il contrasto, da lui vissuto intensamente, fra il clima ‛da mummie e da museo’ proprio dell’Egitto e dell’Italia, e quello della Parigi moderna e della Milano industriale, dove egli dal 1905 pubblica il periodico simbolista internazionale ‟Poesia». Prima della fondazione del futurismo, a parte alcuni scritti insignificanti e un paio di lavori che mostrano la sua ambivalenza nei confronti di D’Annunzio. Le opere pubblicate da Marinetti sono fortemente colorate di parnassianesimo, simbolismo, decadenza e mostrano la profonda conoscenza che l’autore aveva dell’Oriente; ma sono al contempo spiccatamente antintellettualistiche e aggressive, e inneggiano talvolta ad aspetti della vita moderna. Nella poesia ditirambica A mon Pégase, stampata la prima volta in ‟Poesia» nell’agosto 1905 con il titolo A l’automobile, si saluta con entusiasmo la nuova musa del poeta, l’automobile, ma, anche se vi si avverte una certa ebbrezza della velocità, la poesia è ancora avvolta in pieghe simboliste e le immagini ricordano il Parnasse. Nel poema in prosa La mort tient le volant, pubblicato per la prima volta nei numeri ottobre-gennaio di ‟Poesia» (1907-1908) con il titolo Le circuit de la jungle e ispirato alle gare automobilistiche di Brescia, l’entusiasmo di Marinetti si approssima alquanto alla realtà, diviene meno idealistico il poeta, del resto, aveva quell’anno acquistato un’automobile. L’ebbrezza della velocità è certamente un elemento nuovo, sebbene i legami con la tradizione simbolista rimangano rilevanti. Comunque, è possibile che l’opera sia stata sentita come programmatica: il dio della nuova era, la Velocità, attacca la vecchia poesia simbolista, segnata e posseduta dalla morte. Secondo noi, fu la lettura dell’opera già citata di Morasso che portò Marinetti a rompere definitivamente e apertamente con il simbolismo e ad accettare i prodigi tecnici della realtà moderna. La nascita del futurismo letterario può essere datata al 20 febbraio del 1909, quando ‟Le Figaro», in prima pagina, pubblicò Fondation et manifeste du futurisme, firmato da Filippo Tommaso Marinetti e recante, come la maggior parte dei successivi manifesti futuristi, la data del giorno 11. In una versione italiana del libro Le futurisme (1911), Marinetti scrive di aver compreso, l’11 ottobre del 1908, che l’attività di ‟Poesia» fino a quei momento e il simbolismo in genere non erano più soddisfacenti, e che era ormai necessario ‟scendere nelle vie». Il Manifesto venne scritto presumibilmente nel dicembre del 1908, e presentato a Milano, intorno al Capodanno 1909, a P. Buzzi, E. Cavacchioli e forse a O. Vecchi e al siciliano F. De Maria. È probabile che alla memorabile notte descritta nell’introduzione del Manifesto fosse presente anche D. Cinti, segretario di Marinetti e di ‟Poesia». A. Mazza, R. Mannoni e A. Palazzeschi aderirono assai per tempo al gruppo e a ‟Poesia» fu aggiunto il sottotitolo ‟Organe du futurisme». Parigi, Milano e Trieste la questione di Trieste conferisce fin dall’inizio al futurismo una netta connotazione politica possono essere considerate i luoghi di nascita del futurismo; tatticamente, fu una prova della perspicacia di Marinetti la scelta di Parigi come piattaforma di lancio. Il termine futurismo ma solo come denominazione di un atteggiamento politico-sociale sembra essere stato usato per la prima volta nel 1903 dallo scrittore catalano G. Alomar in El futurisme, presentato dal ‟Mercure de France» in un lungo articolo 1 dicembre 1908, che Marinetti aveva probabilmente letto. Sembra che anche i termini ‛dinamismo’ e ‛elettricismo’ siano stati presi in considerazione come possibili nomi del movimento; ma, per motivi propagandistici, Marinetti avrebbe invece scelto ‛futurismo’, quale denominazione più efficace della ‛sua’ scuola perfino le sue iniziali entrano nel nome FuTurisMo, nonché della ‟nuova formula dell’Arte-azione», che egli da allora comincia a diffondere e che attrae a sé giovani e meno giovani Marinetti aveva allora 32 anni, entusiasmati dall’avvenire che i futuristi, gli ‛uomini del futuro’, ritengono di rappresentare e che consente di sbarazzarsi di ogni vecchiume e di guardare alla realtà circostante con occhi nuovi e disincantati. I nomi d’arte dei futuristi sono eloquenti: Libero Altomare, Luciano Folgore, Auro d’Alba, Dinamo Correnti ecc.!
Ma, se fin dai tempi del manifesto del ‟Figaro» il termine futurismo è usato anche in un’accezione più ampia, per indicare genericamente la ribellione artistica e le nuove tendenze, il futurismo ortodosso dà un’impressione di forte omogeneità, con Marinetti come guida e la redazione di ‟Poesia» con D. Cinti ‘segretario del movimento’ come punto d’incontro. ‟Poesia» pubblica ininterrottamente creazioni futuriste, manifesti e poesie, antologie e numeri propagandistici, spesso con prefazioni di Marinetti; riproduce manifesti, commenti della stampa e dichiarazioni sul futurismo, elenca opere futuriste, presenta i futuristi ortodossi e i sostenitori del futurismo. I manifesti – imperativi, categorici – sono scritti al plurale e vengono spesso firmati da più aderenti. L’omogeneità stilistica si spiega con il fatto che Marinetti, il quale veramente possiede ‛l’arte di far manifesti’, li scrive o almeno li rielabora personalmente e sono appunto i manifesti che vengono considerati i suoi migliori prodotti letterari: sin dal primo, sul ‟Figaro», assunto poi a modello dei successivi. In quale misura Marinetti vi lasci il suo segno appare, fra l’altro, se si considera che almeno 18 di essi, precedenti lo scoppio della guerra, sono datati (anche se non firmati da lui) all’undici del mese e hanno spesso undici paragrafi Filippo Tommaso Marinetti era nato il 22 dicembre e considerava l’11 come il suo numero portafortuna. Inoltre egli mette a disposizione del movimento le sue non trascurabili risorse economiche, indispensabili per l’esistenza stessa della ‛scuola’, e cura con moderna efficacia la propaganda: invia rapporti, manifesti e lettere alla stampa; tiene conferenze sul futurismo a ogni occasione; distribuisce volantini; organizza bizzarre serate; utilizza abilmente come strumenti pubblicitari i processi in corso contro opere o esposizioni futuriste; per gran parte dell’anno funge da ambasciatore viaggiante del movimento. In pro del futurismo egli accetta, evidentemente, una visione ‛pragmatica’ della verità ma ben pochi debbono aver preso sul serio le sue fantasiose tabelle statistiche sugli adepti, sulle conversioni, sui feriti nel corso delle serate ecc. È in genere degna di nota la forza con cui Marinetti crede al risultato ottenuto, in ogni contesto, mediante semplici addizioni o superlativi, il che lascia certo tracce profonde nella formazione delle sue teorie letterarie e nelle ‛parole in libertà’. Per questo aspetto Marinetti prosegue evidentemente il materialismo positivista dell’Ottocento e fa sua una teoria evoluzionistica delle più banali, in base alla quale, grazie appunto a criteri quantitativi, il presente supera il passato e il futuro il presente. Che poi la sua contemporaneità fosse improntata a una visione dell’uomo di matrice nietzschiana fu certamente di aiuto per la propaganda futurista. La fanfara di Marinetti non risuona invano ed egli riesce a inquadrare nel suo indirizzo, inizialmente solo poetico, rappresentanti di settori culturali assai diversi. Nel 1914 egli può contare su numerose sezioni futuriste: Poesia, Pittura, Musica, Scultura, Azione femminile, Arte dei rumori, Architettura, Antifilosofia, Antimorale e Politica; e molte altre se ne aggiungeranno in seguito. È evidente la sua ambizione di ricomprendere nel futurismo l’intera gamma delle espressioni del modernismo. Il periodo di massimo splendore del movimento in Italia va all’incirca dal febbraio del 1913 allo scoppio della guerra, quando Papini e Soffici, abbandonando temporaneamente l’asprezza delle precedenti critiche, appoggiano attivamente il futurismo nel corso di provocatorie serate, e aprono ‟Lacerba», che dal 1° gennaio del 1913 esce con periodicità quindicinale, anche ai futuristi di Milano. I fiorentini, ma qui il termine futurismo è usato nel suo senso più largo, hanno in comune con Marinetti una forte insoddisfazione per la situazione letteraria e artistica italiana ed esigono un’arte e una letteratura nuove, non soffocate da vecchie dottrine e liberate dall’autorità del passato. Essi si fanno inoltre banditori di un dinamismo antintellettualistico che prende spunto dall’élan vital di Bergson, dottrina allora assai in voga. Nessuno dei redattori di ‟Lacerba», però, accetta la (riduttiva) interpretazione marinettiana del concetto di futurismo; essi dunque si allontanano quando sentono il peso del dogmatismo di Marinetti e di Boccioni. Gli atteggiamenti ribelli di Papini e la sua furia iconoclasta in ‟Lacerba», le sue stroncature della cultura ufficiale, le sue affermazioni antimoralistiche e antifilosofiche offrono ai futuristi milanesi molti stimoli, specialmente sul problema dell’antipassatismo Papini tuttavia fu sempre critico verso la mania reclamistica di Marinetti, verso il suo materialismo, il suo puerile ottimismo, la sua retorica modernista (‟la retorica da chauffeurs«) come anche verso il naturalismo imitativo delle parole in libertà. Quando Soffici e Papini, che distinguono fra marinettismo e futurismo, rompono con il primo e propongono il futurismo nel suo senso più ampio, Palazzeschi si era già allontanato da Marinetti. Del resto, se si prescinde dalla poesia L’incendiario e dal manifesto antitradizionalista Il controdolore, con la sua Umwertung fortemente nietzschiana, non c’è molto di futurista nell’opera di Palazzeschi. Lo stesso vale per G. P. Lucini, che si allontana da Marinetti nella primavera del 1913, dopo che questi aveva tentato invano d’inquadrarlo nella compagine futurista e dopo che ‟Poesia», già nel 1909, aveva ospitato la sua raccolta di poesie Revolverate. Lo scoppio della guerra, esaltando quanto di comune vi era nella visione politica, riunisce nella propaganda interventista gli aderenti alle due correnti, che spesso si arruolano volontari e, in qualche caso, non faranno ritorno dal fronte. Si è parlato spesso della difficoltà di trovare opere futuriste rappresentative. Gli ortodossi, pedissequi imitatori di Marinetti, non sono scrittori interessanti; quelli più originali non si lasciano costringere negli schemi del futurismo dogmatico teorizzato dal fondatore. La sua originalità diviene un bene collettivo del movimento, il cui sviluppo s’identifica più o meno con quello del suo capo: per molti aspetti, il futurismo è Marinetti stesso. Lo squilibrio fra teoria e prassi è però stridente. I manifesti dilagano ma le realizzazioni poetiche sono alquanto esili e, se si prescinde dalle ‛parole in libertà’, corrispondono raramente alle enunciazioni programmatiche. Per i primi lavori successivi al manifesto sul ‟Figaro», ciò può essere spiegato pensando che essi furono iniziati prima della nascita del futurismo. In cui solo la prefazione dedicata a W. Wright ricorda il futurismo, e per il ‛romanzo esplosivo’, ambientato nel deserto, Mafarka le futuriste (1909-1910), il cui protagonista, superuomo nietzschiano, guidato dall’istinto e dalla volontà si libera dei pregiudizi sentimentali e passatisti e quindi, grazie a un puro atto di volontà, può generare il figlio Gazourmah che, alla fine del romanzo, detronizza il sole. Nella Bataillede Tripoli, scritto quando Marinetti era corrispondente di guerra in Libia, alla fine del 1911, appaiono le difficoltà che egli trova ad esprimere nella prosa tradizionale le impressioni che d’un tratto aggrediscono l’uomo in una guerra moderna. Più o meno contemporaneo è il grande romanzo politico in versi liberi, Le monoplan du pape, grottesco nel contenuto e con tratti fortemente anticlericali e antiaustriaci. Il papa viene sequestrato sul monoplano futuristico dell’io e costretto a fare esperienza di tutto ciò che in Italia provoca disgusto in un futurista, dopo di che viene gettato ai pescecani nell’Adriatico. L’opera ha parti di grande bellezza lirica, nel contrasto fra uno smisurato bisogno di attività e certe tendenze sentimentali, spesso raccolte intorno all’immagine della madre. La ricchezza verbale, la quantità di sensazioni, la prospettiva aerea promettono comunque uno sviluppo, e l’opera sarà in seguito considerata da Marinetti come il primo tentativo compiuto nel genere artistico futurista dell’aeropoesia. Nell’estate del 1912 Marinetti compie l’ultimo passo e scrive le sue prime ‛parole in libertà’, Battaglia Peso+Odore, probabilmente come risposta alle critiche rivolte al Manifesto tecnico della letteratura futurista (maggio 1912). Ma solo nel febbraio del 1914 Marinetti pubblica un intero volume di ‛parole in libertà’, il famoso Zang Tumb Tuuum, ispirato all’assedio di Adrianopoli dell’ottobre del 1912. Il manifesto letterario del maggio 1913 (Distruzione della sintassi – Immaginazione senza fili – Parole in libertà) e il Manifesto tecnico del maggio 1912, con il suo supplemento, fungono da prologo e epilogo. Zang Tumb Tuuum è il verbo del profeta tradotto in realtà, e Marinetti, nel corso dei suoi viaggi propagandistici per convertire il mondo, ne declamava magistralmente dei brani. Non c’è qui spazio per trattare dei poeti minori del futurismo: P. Buzzi, L. Folgore (pseudonimo di O. Vecchi), E. Cavacchioli, A. d’Alba (pseudonimo di U. Bottone), A. Mazza, L. Altomare (pseudonimo di R. Mannoni), F. De Maria, F. Cangiullo e altri. Probabilmente, solo Folgore e d’Alba pubblicarono manifesti prima della guerra, ma non sembra che Marinetti li considerasse specificamente futuristi. Il culto del futuro, e le ottimistiche speranze in esso riposte cioè, futurismo nel suo valore etimologico comportano l’accettazione delle conquiste più recenti della tecnica moderna quindi modernolatria, ovvero culto del moderno, quale si manifesta nelle realizzazioni meccaniche e nella velocità; il termine fu creato da Boccioni. Le grandi città moderne e le guerre esigono, e in qualche misura creano, uomini attivi, dinamici (attivismo/dinamismo), che vivono la loro contemporaneità in modo radicalmente diverso dai precedenti e non hanno quindi interesse a scavare nel passato; essi si sentono liberati dalle tradizioni, non riconoscono, e anzi negano violentemente l’autorità, che sbeffeggiano e sentono come appartenente al passato, come ostacolo alla creazione di opere moderne (antipassatismo). La vita convulsa della nuova umanità, la sua nuova ‛sensibilità futurista’ producono nuove forme e implicano l’esigenza di una ‛forma’ (tecnica) estetica nuova. La lingua, le regole grammaticali e sintattiche tradizionali, che non possono più dare espressione alla realtà, devono essere infrante e sostituite da nuove e libere parole. È in questo contesto che nascono gli slogan futuristi come parole in libertà (PIL), ‟immaginazione senza fili» (ISF) e ‟simultaneità». Contenuti: antipassatismo – dinamismo/attivismo – modernolatria – sensibilità futurista. – Ciò che più colpiva, già nel manifesto sul ‟Figaro», era l’antipassatismo. Istituire un confronto fra la Vittoria di Samotracia e un’automobile da corsa – e per di più, come appare dal paragrafo 4 del manifesto, a svantaggio della prima – era certo cosa inaudita. Le proposte di distruzione di musei, biblioteche, accademie, che evidentemente non dovevano essere interpretate letteralmente, furono da molti considerate come pura e semplice follia. I critici paragonarono a volte Marinetti a Erostrato e videro in lui il Bakunin, il Marat o il Babeuf della rivoluzione artistica. Egli attacca ripetutamente il ‛clima da museo’, raccomanda di vendere i vecchi capolavori famosi conservati in Italia e di comprare cannoni. Venezia, ‟cloaca massima del passatismo», è sottoposta a vere e proprie campagne aggressive e i veneziani vengono esortati a dar fuoco alle gondole. Con argomentazioni dello stesso tipo, l’ira futurista aggredisce Roma, Firenze, Parma, si scaglia contro ogni inclinazione romantica, esotica, sentimentale, contro le rappresentazioni stereotipe della Spagna, della luna, della donna, dell’amore viste come forze che ostacolano il poeta futurista cui spetta di sconfiggere i pregiudizi del passatismo prendendo in questo a modello il Mafarka del romanzo marinettiano. Il disprezzo per il romantico chiaro di luna e quello per la tradizionale visione della donna, cui vengono dedicati due manifesti diversi, sono temi ricorrenti in molta poesia futurista. Politicamente i futuristi sono antidemocratici, anticlericali, antipacifisti e antiaustriaci. Il gruppo di ‟Lacerba», guidato da Papini, Palazzeschi e Tavolato, l’‛immoralista’ del movimento, intraprendono una violenta Umwertung lodando, contro l’umanità ‛normale’, prostitute, omosessuali, criminali e pazzi. ‟Odiatevi!», proclama Papini, e su ‟Lacerba» si attacca, al seguito di Nietzsche, il cristianesimo come religione dei deboli e Dio viene definito come ‟cloaca massima di tutti gl’idealismi». Se, fra i critici contemporanei, Croce è colpito in modo particolarmente duro, nella rubrica ‟Sedia elettrica» di ‟Lacerba» si procede a una serie ininterrotta di esecuzioni. Opere d’arte classiche e valutazioni tradizionali vengono ridicolizzate in vari modi: ‟Bisogna sputare ogni giorno sull’Altare dell’Arte», dice Marinetti nel Manifesto tecnico del 1912, in cui il brutto viene proposto come poeticamente prezioso. Nell’‟Almanacco purgativo» dei futuristi di ‟Lacerba» vengono stroncati, spesso in modo ingegnoso e divertente, antichi maestri e capolavori. La Gioconda, questa ‟icona del passatismo», sarebbe un ottimo nome per un lassativo, e i futuristi esultano alla notizia del furto al Louvre, rattristandosi poi per il successivo recupero. Sotto la guida di Papini, l’antipassatismo assume anche un forte carattere antintellettualistico e si predicano un dinamismo ideologico e un relativismo estremo. Ogni epoca deve creare norme e arti proprie. Il dinamismo futurista è probabilmente influenzato, in modo indiretto, dal filosofo alla moda dell’epoca: Bergson. Per esempio, le teorie marinettiane sullo ‟stile vivo che si crea da se» ricordano la volgarizzazione della concezione bergsoniana della durée. Che la modernolatria sia un importante presupposto del futurismo, appare del tutto chiaro. Marinetti avrebbe potuto fare sua la parola d’ordine di D’Annunzio: ‟Marciare non marcire»; i verbi di moto come ‛marciare’, ‛salire’, ‛scendere’, ‛correre’ sono innumerevoli nelle opere futuriste.



L’attivismo è un’esigenza insopprimibile e il futurismo è, secondo Marinetti, appunto la nuova formula per l’‟Arte-creazione». L’atto del creare è più importante dell’opera finita, la casa in costruzione è più bella di quella terminata. I contemporanei si scontrano con lo spietato attivismo futurista soprattutto nel corso delle loro serate violentemente provocatorie, in cui si eccita l’aggressività del pubblico con metodi che vanno dalle goliardiche polverine irritanti agli attacchi politici, prima a proposito della questione triestina, poi di Tripoli e infine dell’intervento. Gli attacchi contro l’Austria e gli Asburgo provocarono inoltre complicazioni diplomatiche. L’uomo dinamico, attivo, proposto dai futuristi fin dal manifesto del ‟Figaro» e cantato naturalmente anche nella poesia futurista, la quale brulica di soldati, alpinisti, esploratori, corridori automobilisti, volatori e altri sportivi, o comunque persone che vivono pericolosamente. ‛Uomo’ e ‛lottatore’ sono sinonimi secondo Marinetti, e la volontà di vivere nel rischio, la passione per il record, la ‛fisicofollia’ sono elementi importanti dell’uomo futurista. La violenza viene vista, ricalcando Sorel, come positiva e inevitabile, l’aggressività come un presupposto per la creazione, anche in campo artistico. ‟Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro» si legge nel paragrafo 7 del manifesto del ‟Figaro». La guerra si legge al paragrafo 9 proclamata ‟sola igiene del mondo», e si arriverà in seguito a dichiarare che essa è la più importante delle creazioni artistiche del futurismo. E degno di nota che Marinetti, nelle sue parole in libertà, rappresenti esclusivamente esperienze di guerra. L’eroismo bellico come forza etica è uno dei motivi conduttori del futurismo e i richiami al culto della violenza sono in Marinetti tanto numerosi quanto triviali. L’osservatore di oggi può senz’altro stupirsi del grande numero di critici, contemporanei di Marinetti, che recepirono positivamente la sua violenza e il suo antipassatismo. Se la guerra moderna, con tutte le sue manifestazioni acustiche, è una delle fonti d’ispirazione delle parole in libertà, l’altra è certamente la modernolatria, intesa soprattutto come accettazione della metropoli moderna, i cui prodigi tecnici (luci elettriche, grattacieli e simili) sono descritti icasticamente nell’ultimo paragrafo del manifesto del ‟Figaro». Del resto Marinetti parla spesso di una ‟bellezza meccanica», che nello stesso manifesto è rappresentata dall’automobile lanciata a tutta velocità. Allo stesso tempo, questo è un ottimo esempio della nuova bellezza futurista per eccellenza, ‟la bellezza della velocità», cuore del ‟regno meccanico» che presto sostituirà, secondo Marinetti, il ‟regno animale». Elettricità, telegrafo, cinematografo, macchine (specialmente automobili e aeroplani) e velocità diventano motivi frequentissimi e simboli portanti nelle poesie futuriste, in una lingua che però è piena di immagini e paragoni barocchi. L’antropomorfizzazione di motori e oggetti meccanici cede sempre più a una disumanizzazione e meccanizzazione dell’uomo mirante a conquistare nuovi domini alla dea Velocità, che annuncia una nuova religione e una nuova morale ed esige, inoltre, un’estetica del tutto nuova proclama categoricamente da Marinetti sia come tema sia come elemento formale, la velocità ha un ruolo dominante nella letteratura futurista in cui l’‛ebbrezza della velocità’ dell’uomo moderno è un fattore di grande importanza. Nel manifesto del maggio 1913 Marinetti parla di ‟coscienze molteplici e simultanee in uno stesso individuo», pensiero a lui assai caro e tema prediletto di conferenze nelle tournées all’estero, durante le quali cerca di precisare ‟la nuova sensibilità futurista». Il cittadino della grande città moderna vive, grazie allo sviluppo tecnico offerto, dal telegrafo, dal telefono, dal grammofono, dal treno, dall’automobile, dall’aeroplano, dal cinema ecc., con un’intensità diversa che nel passato, e può disporre di una sintesi quotidiana di ciò che avviene in tutto il mondo. La sua sensibilità viene moltiplicata e l’uomo acquisisce un ‛senso globale’ o ‛senso mondiale’, cioè quasi una sorta di ubiquità e simultaneità. Il tempo e lo spazio sono morti, si annuncia già nel manifesto del ‟Figaro» perché l’uomo ha creato ‟l’eterna velocità onnipresente». La simultaneità come motivo poetico viene usata, prima della guerra, in modo alquanto vago: ci si limita a giustapporre in una poesia tradizionale o nelle parole in libertà, denominazioni di luoghi geograficamente distanti fra loro.
Ma durante e subito dopo la guerra questo stesso motivo assume un certo rilievo nelle sintesi del teatro futurista, come anche nei manifesti La cinematografia futurista (1916) e Il teatro futurista radiofonico (1933, lo stesso anno in cui Marinetti pubblica i Poemi simultanei). Invece la simultaneità degli anni prebellici influenza, se non la forma, la visione futurista dell’uomo. Questa è una conseguenza logica della modernolatria dei futuristi e della loro fede nella dea Velocità. Si deve anche osservare che questo ‟uomo moltiplicato» è fatto di parti sostituibili ed è quindi teoricamente immortale. Non cercherò di esaminere qui gli audaci tentativi compiuti nelle arti figurative e nella musica per soddisfare i nuovi bisogni espressivi dell’uomo moderno, ma va sottolineato che gli artisti futuristi della parola e dell’immagine collaborano strettamente e che anche i pittori creano parole in libertà: è forse questa la spiegazione dell’importanza che assume il momento visuale. Le frontiere fra le arti vengono spesso cancellate: i poeti futuristi devono essere stati ispirati in particolar modo dal tentativo boccioniano di risolvere, nella teoria e nella prassi i diversi problemi della simultaneità sotto il segno della ‛compenetrazione dei piani’ e della ‛simultaneità degli stati d’animo’. A volte, infatti, i poeti tentano nei loro scritti di rendere tanto le ‛linee-forza’ quanto la ‛compenetrazione’ dei pittori. ‟I trams s’incrociano, l’automobili sembra/entrino nei trams e ne fuorescano», scrive Buzzi in una poesia ‛urbana’ in Versi liberi, alludendo probabilmente a un passo famoso del Manifesto tecnico della pittura futurista. Cangiullo ha tentato nelle sue parole in libertà Addiooooo di rendere Gli addii, n. 1 del trittico boccioniano Stati d’animo, che indusse molti futuristi a rendere verbalmente la simultaneità dello stato d’animo totale nell’uomo moderno, che è bombardato da sensazioni immediate ma allo stesso tempo sente come attuali esperienze e ricordi depositati nel passato; ed è questo un campo che si suole piuttosto ricondurre all’arte delle parole che a quella delle immagini. Va anche ricordato che le teorie dei pittori futuristi sulla simultaneità provocarono un violento dibattito a Parigi, dove la paternità della nozione di ‛simultaneità’ fu contesa fra Boccioni e diversi cubisti; ciò influirà in modo non indifferente sull’arte della parola dei circoli poetici parigini vicini al futurismo. Come abbiamo già detto, Marinetti svolgeva in ‟Poesia», un’energica propaganda a favore del vers libre e la sua ultima opera di rilievo prima delle parole in libertà, è in versi liberi. Qui è interessante la prospettiva aerea – il paesaggio danza, si contorce e qualche passo presenta un certo parallelismo con i mutamenti di prospettiva alla Porter nella tecnica cinematografica. Nel Manifesto tecnico del maggio 1912 Marinetti ci informa che fu proprio durante un volo che egli per la prima volta comprese ‟l’inanità ridicola della vecchia sintassi ereditata da Omero» e sentì un furioso bisogno di ‟liberare le parole traendole fuori dalla prigione del periodo latino». Volando, tutto appare in una prospettiva nuova, ‟non più di faccia o per dietro, ma a picco, cioè di scorcio». Le teorie sulle parole in libertà vengono inoltre esposte in Risposte alle obiezioni, nell’agosto dello stesso anno, e nel manifesto del maggio 1913. A questi scritti si aggiungono gli articoli-manifesti su ‟Lacerba» e altrove. È dunque l’elica che detta le teorie letterarie nel Manifesto tecnico del 1912. Il sostantivo deve essere usato liberamente senza riguardo per la struttura della frase: nel verbo devono dominare le forme infinite perché solo esse sono sufficientemente dinamiche per rendere la continuità della vita e possono dunque raggiungere l’intuizione elastica del lettore moderno. Gli aggettivi e gli avverbi sono statici, impediscono la fantasia e per questo vanno banditi; il sostantivo deve quindi essere caratterizzato da un altro sostantivo che crei un’analogia, per es. ‛uomo-torpediniera’. Parole come ‛così’, ‛come’, ‛simile a’ sono inutili perché l’acuita sensibilità dell’uomo moderno coglie immediatamente l’analogia. Anche i segni d’interpunzione convenzionali vengono eliminati perché statici. Al loro posto Marinetti raccomanda segni matematici e indicazioni ritmiche, come +−x:=, che possono rendere i movimenti, la quantità (come le lettere maiuscole e le variazioni tipografiche) e fanno risparmiare tempo. Le analogie e le immagini sono come il sangue della poesia e il poeta può, con ‟la catena delle analogie», riprodurre le fasi successive del movimento di un oggetto. La materia in sé deve sostituire l’io e le tendenze psicologistiche della letteratura; ciò è reso possibile dall’intuizione del poeta e dalla ‟ossessione lirica della materia». Non è lecito attribuire alla materia qualità umane: la vita dei motori e la vita meccanica devono essere rese per se stesse, al massimo con l’aiuto di qualche strumento tecnico mutuato dalla cinematografia. Alla letteratura vanno aggiunti tre elementi non letterari: il ‛rumore’, che rivela la dinamica degli oggetti e può essere ottenuto con l’onomatopea, il ‛peso’, che svela la capacità degli oggetti di volare, e l’‛odore’, che mostra la loro capacità di diffondersi. Grazie all’‛immaginazione senza fili’, in una similitudine poetica è sufficiente un solo membro. In Risposte Marinetti riporta un capitolo della Battaglia Peso+Odore come esemplificazione e risposta alle critiche rivolte al Manifesto tecnico. Ne riproduciamo qui un breve passo, tralasciando però le peculiarità tipografiche: ‟mitragliatrici = ghiaia + risacca + rane Tintinnio zaini fucili cannoni ferraglia atmosfera = piombo + lava + 300 fetori + 50 profumi selciato materasso detriti sterco-di-cavallo carogne flic-fiac ammassarsi cammelli asini TUMB-TUUUM cloaca Souk-degli-argentieri dedalo seta azzurra galabieh porpora aranci moucharabieh archi scavalcare biforcazione piazzetta pullulio». Sono evidenti le sequenze di sostantivi, le analogie dirette ‛senza fili’, la mancanza di aggettivi, avverbi, congiunzioni, interpunzione, la presenza di cifre, segni matematici, infiniti, la libertà grammaticale e sintattica. I rumori (l’onomatopea), gli odori e il peso sono resi direttamente con i sostantivi, e l’enfasi posta sulla quantità si manifesta nel tentativo di rendere la simultaneità di uno stato d’animo mediante addizioni. L’io è assente, il disordine è palesemente massimo, e l’aspetto tipografico è anormale (il passo citato è preceduto da una superficie bianca). Nel manifesto del maggio 1913, Distruzione della sintassi, prosegue l’esposizione teorica, mentre Marinetti spiega il nuovo modo in cui l’uomo moderno, inebriato di velocità, percepisce l’esistenza: è un modo cioè sintetico, rapido, ellittico, che rifugge perciò da analisi e spiegazioni: ‟Raccontami tutto, presto, in due parole!». Di qui l’esigenza di una lingua telegrafica, secca, laconica. Si annuncia la morte del verso libero, che è ora sostituito dalle parole in libertà (PIL), e si apre la strada per le analogie dirette della ‟immaginazione senza fili» (ISF). Si proclama che gli aggettivi ormai potranno avere solo funzione di segnali e se ne accettano tre tipi: aggettivo semaforico, aggettivo-faro e aggettivo-atmosfera. La tipografia tradizionale deve essere distrutta. Le argomentazioni a favore dell’onomatopea ricordano quelle dei pittori futuristi e cubisti a favore del collage. Si raccomanda l’uso di segni matematici, fra cui + per connettere i componenti di un’esperienza di simultaneità. Marinetti chiama il suo progetto per la simultaneità ‟lirismo multilineo» e lo equipara a ‟quella simultaneità che ossessiona anche i pittori futuristi». Ogni riga contiene un tipo diverso di sentimenti o di sensazioni, e il lettore può seguire le impressioni compresenti abbracciando con lo sguardo un gruppo di righe. E’ predominante una catena di sensazioni e analogie visive, questa verrà stampata più nettamente, mentre la catena di sensazioni acustiche verrà resa con caratteri più grandi di quelli usati per la catena di fenomeni olfattivi; questi ultimi, a loro volta, domineranno le catene che indicano il peso o la dispersione degli oggetti. Quando si descrive come i Turchi incendiano un ponte bulgaro, si usano caratteri di ben sei formati diversi; la catena con i caratteri maggiori rende il senso di disperazione ‟fine disperazione perduto niente-da-fare inutile» – mentre quella con i caratteri più piccoli riproduce gli odori “sterco-di-cavallo orina bidet ammoniaca odore-tipografico». Altre righe rendono denominazioni di colori, esclamazioni, crepitio di mitragliatrici e altri fenomeni acustici, sensazioni tattili, ecc. ecc. La novità consiste nella disposizione ‟multilinea». Marinetti difende anche una ‟ortografia libera espressiva», ‟urrrrrrraaaaah», che si collega direttamente alla prediletta onomatopea: in questo modo il declamatore raggiungerà ‟l’accordo onomatopeico psichico». Come abbiamo ricordato, l’ispirazione all’onomatopea veniva a Marinetti principalmente dalla guerra e dalla metropoli moderna. In un articolo su ‟Lacerba» dell’aprile 1914, Marinetti riassume e precisa le sue teorie sull’onomatopea.
I presupposti ne sono l’invasamento dei futuristi per la materia e il loro amore per i motori. Marinetti distingue fra quattro tipi di onomatopea. La più semplice è l’‟onomatopea diretta imitativa elementare realistica» il crepitio delle mitragliatrici viene reso con ‟tatatatata», spesso ridicolizzata dai critici contemporanei di Marinetti, che in lui videro solo questo aspetto onomatopeico. Gli altri tipi sono l’‟onomatopea indiretta complessa e analogica» (il ‟rumore rotativo del sole africano e il peso arancione del cielo» vengono riprodotti con ‟dum-dum-dum-dum»), l’‟onomatopea astratta» (uno stato d’animo può essere espresso con ‟ran ran ran ran») e l’‟accordo onomatopeico psichico», che si raggiunge quando si combinano più ‟onomatopee astratte». C’è qui probabilmente l’eco dei discorsi dei pittori futuristi sulla ri-creazione del’‟accordo psichico» e degli ‟stati d’animo». La ‟sensibilità numerica» è la conseguenza dell’esigenza, da parte dell’uomo moderno, di precisione e rapidità. Le definizioni liriche devono essere quanto mai esatte e possibilmente avere forma di equazione: ‟orizzonte = trivello acutissimo del sole + 5 ombre triangolari (1 km dilato) + 3 losanghe di luce rosea + 5 frammenti di colline + 30 colonne di fumo + 23 vampe». Con le parole in libertà si rompe, secondo Marinetti, la tradizione, nata con Omero, della successione narrativa perché le PIL esprimono il carattere integrale, dinamico e simultaneo dell’universo. Dunque, dietro l’ambizione del paroliberista di riprodurre la totalità come è sentita dall’uomo moderno, che vive febbrilmente ed è esposto a infinite sensazioni, si nascondono una considerazione materialistica e quantitativa della realtà circostante e una teoria sulle possibilità espressive dell’imitazione. Le PIL non sono né prosa né poesia tradizionali (distinzioni come forma-contenuto, soggettivo-oggettivo, poesia-realtà sono difficilmente applicabili a opere che vogliono esprimere la materia in sé), ma piuttosto una forma di letteratura ‛concreta’. In alcuni casi limite, le PIL forniscono materia bruta che viene resa con onomatopee e immagini in libertà. Gli elementi puramente visivi predominano più nel paroliberista Cangiullo che in Marinetti, ma naturalmente sono di gran lunga più spiccati nei pittori futuristi che si dedicano alle PIL, quando i confini fra le diverse arti tendono a svanire: le parole di Carrà ‟noi pittori-poeti futuristi» sono significative. Del resto, Marinetti sosteneva che le PIL dovessero essere ‟autoillustrazioni». Anche gli elementi calligrafico-ideografici, per cui il volo dell’aeroplano veniva reso visivamente con la disposizione delle lettere, richiamarono un grande interesse nel dibattito internazionale della Parigi prebellica, e certamente influenzarono, tra gli altri, Apollinaire. Mentre alla metà del secondo decennio del XX secolo in tutta Europa, quasi in coincidenza cronologica con alcuni dei più trasgressivi movimenti dell’avanguardia, e per mano di artisti che di questi movimenti erano stati parte attiva, dal cubismo al dadaismo, dall’espressionismo al futurismo, soffiò il vento di un nuovo classicismo, annunciato da opere diventate simbolo di quell’inversione di linguaggio, o, meglio sarebbe dire, di quella conversione “al concreto, al semplice, al definitivo” di cui parlerà alcuni anni più tardi Margherita Sarfatti, la teorica del Novecento italiano. Partendo proprio dalla figura ella era una grande letterata è fu la prima donna in Europa ad occuparsi di critica d’arte, dimostrando versatilità e competenza. Tuttavia oggi viene comunemente ricordata soprattutto perché, pur provenendo da una famiglia ebrea, ella 1910 divenne l’amante di Benito Mussolini pianificandone la politica culturale fino alla svolta delle leggi razziali, quando per lei divenne opportuno espatriare. In realtà, per quanto contraddittoria, la vicenda umana e professionale della Sarfatti non merita le facili riduzioni. Come altri personaggi del suo tempo, la Margherita Grassini sembra attratta in modo ricorrente dai percorsi contrastati e fiammeggianti di passioni, sotto alcuni aspetti dimostra il suo impegno contro la discriminazione sessista, scrivendo e finanziando dei periodici femministi, sotto altri aspetti evidenzia una tendenza a misurarsi soprattutto con il modello di successo maschile, rappresentato prima dal padre, poi dal marito, da Mussolini e persino da alcuni artisti con cui in tempi diversi instaura una relazione sentimentale. Margherita si muove spesso su un crinale di improbabili equilibri che nel periodo di impegno socialista scrive sull’Avanti, e si batte per l’uguaglianza, tuttavia non riesce a rinunciare al lusso e ai privilegi di casta, tanto che di frequente viene criticata dalla sua stessa cerchia.
Scrive sul periodico ‘Unione femminile’ e collabora fino al 1915 alla pubblicazione ‘La difesa delle donne lavoratrici’, frequenta la Kuliscioff, ma il suo emancipazionismo naufraga di fronte al mito dell’uomo-guida, dell’amour fou a cui immolarsi. Margherita si forma sugli scritti di John Ruskin, legge Marx, Turati e Anna Kuliscioff. Nel 1898 sposa giovanissima, a dispetto della famiglia, un avvocato socialista da cui avrà tre figli, lui che aveva tredici anni più di lei, imposta il matrimonio in modo libertario. Si impantana per quasi vent’anni nella relazione con Mussolini, anche lui sposato ma geloso al pari di lei. Animata da uno spiritualismo tormentato e segnato tra l’altro dal suicidio di una sorella Margherita esita tra la fede ebraica e il cattolicesimo, a cui si converte nel 1928. La Margherita Grassini Sarfatti trasforma anche la propria visione politica, inizialmente affine al socialismo, in un convinto nazionalismo e progressivamente si coinvolge nell’avventura fascista. Appoggia il regime, ma discute con Mussolini a proposito dei gerarchi in ascesa, che lei considera volgari e pericolosi. Il rapporto con lui attraversa alti e bassi, finché si deteriora ed entra in piena crisi la Sarfatti fugge quando vengono approvate le leggi razziali e ritorna solo alla fine del conflitto mondiale, per trascorrere gli ultimi anni lontana dalla ribalta a cui era abituata. Gli scritti e le testimonianze concordano sulla poliedrica intelligenza di Margherita e sulla vastità della sua cultura, la Grassini cresce in una famiglia veneziana assai agiata e dispone di maestri eminenti, sensibile intenditrice d’arte, condivide con il marito Cesare il desiderio di una vita sociale più vivace perciò nel 1902 si trasferisce con lui a Milano, dove dà vita ad un salotto frequentato dai più promettenti artisti del momento e guida iniziative culturali importanti. Conosce quattro lingue e incontra personalità di fama dal futuro pontefice Pio X, alla regina Elena di Savoia, a Guglielmo Marconi, a Joséphine Baker e si circonda di numerosi artisti e letterati tra cui Ada Negri, Fogazzaro, Marinetti, Shaw, Cocteau, D’Annunzio, Prezzolini, Palazzeschi, Panzini, scultori e pittori del calibro di : Adolfo Wildt, Arturo Martini, Mario Sironi, Marussig, Carrà, Russolo, Boccioni e degli architetti Sant’Elia e Terragni. L’incontro anche sentimentale con il giovane Mussolini avviene nel 1912 su posizioni socialiste, da cui entrambi si allontanano in quanto interventisti per fondare Il Popolo d’Italia, ma la realtà della Prima Guerra Mondiale è durissima, nel 1918 muoiono al fronte anche ragazzi come il figlio di Margherita in questa fase gli ideali di sacrificio e dedizione patriottica che avevano animato il figlio non vengono messi in discussione dalla Grassini, ma anzi diventano un riferimento consolatorio per lei, che in seguito pubblicherà un volume in versi dal titolo ‘ I vivi e l’ombra’, dedicato al figlio. Morto il marito nel 1924 Margherita accompagna in modo sempre più scoperto l’affermazione di Mussolini e del partito esperta organizzatrice di eventi, collabora al piano della marcia su Roma, agli scritti teorici del fascismo e in pieno regime assume anche incarichi istituzionali. Probabilmente la Grassini, forte della stima di cui gode già da tempo a livello internazionale per i suoi scritti, è convinta di poter guidare le scelte politico-culturali del regime e sottovaluta la progressione del clima antisemita. Infatti, sulla questione ebraica Mussolini cambia nel tempo la sua posizione, passando da una iniziale tolleranza all’assunzione piena del modello nazista. Anche rispetto alla donna che lo sostiene egli muta atteggiamento, pur apprezzandone la bellezza la definisce avara e sordida, secondo uno stereotipo collaudato dalla propaganda fascista nel descrivere gli ebrei. Eppure il duce ha ricevuto da Margherita grande sostegno economico oltre che morale. Anche il miglior biglietto di presentazione ai governi stranieri gli giunge dalla Sarfatti che nel 1926 la scrittrice pubblica ‘Dux’, la biografia mussoliniana che adula il capo e lo descrive vitale, spregiudicato, sensuale e aggressivo, energico portatore di ciò che viene indicato come spirito italico, con la sua consueta padronanza della scena, Margherita presenta il libro negli USA assicurandogli un enorme successo. Finché Mussolini è impegnato nella prima organizzazione dello Stato fascista, la Grassini ha notevole spazio probabilmente sono sue alcune parole chiave della propaganda fascista, come fascio e duce, è sua la mistica della romanità resuscitata dal fascismo, è lei a rendere credibile all’estero l’immagine del duce. Il desiderio mussoliniano di grandezza si arma della competenza di Margherita, che intende correggere il cattivo gusto dell’estetica fascista e assumere il ruolo di musa e mediatrice. Del resto Margherita è un’autorità nel campo dell’arte, e da sempre ama valorizzare i talenti orchestrandone la riuscita, incoraggia e protegge i giovani artisti con Umberto Boccioni ed Emilio Notte ha avuto anche brevi relazioni, persegue il disegno di una nuova società in cui l’arte sia sovrana. La sua visione mescola esaltazione spirituale e residui risorgimentali, spirito pedagogico e individualismo in questo quadro gli artisti sono determinanti per la costruzione del futuro. Tra le due guerre l’arte europea, accantonando l’impeto destabilizzante delle Avanguardie, è pronta a rivalutare il realismo classico, in Italia Margherita Grassini Sarfatti auspica appunto un ritorno al classicismo. Con entusiasmo dà corpo al suo progetto, che intende coniugare la modernità con la monumentalità del Rinascimento. Infatti, nel 1922 fonda il gruppo noto come Novecento, al quale inizialmente aderiscono sette pittori A. Funi, P. Marussig, L. Dudreville, E. Malerba, M. Sironi, U. Oppi e A. Bucci; alcuni di loro se ne allontanano presto per timore di essere strumentalizzati, ma il gruppo si ricostituisce nel 1926 con il nome di Novecento Italiano e raccoglie, data la protezione assicurata dal regime, un numero assai alto di adesioni. Nonostante le pressioni di chi vuole ridurre la cultura a semplice strumento di regime, per qualche tempo la Sarfatti riesce a mantenere questa iniziativa lontana dai toni più volgarmente propagandistici, tenendo fede alle motivazioni artistico culturali che la animano. Negli anni successivi la Grassini si interessa all’architettura razionalista, privilegiando progettisti volti al contemporaneo come Terragni, Figini, Michelucci e Pollini. Proprio al giovanissimo Terragni, di cui capisce e protegge il talento, Margherita commissiona il monumento funebre per il figlio Roberto, ignorando altri professionisti più in vista, ma non ugualmente radicali. Inoltre promuove la valorizzazione delle arti applicate con il fine di coniugare modernità e tradizione, rinnova la Biennale di Monza e istituisce la Triennale di Milano, facendovi costruire il Palazzo dell’Arte. Sebbene aspiri a raccogliere in Novecento l’intera ultima produzione artistica italiana, Margherita è comunque aperta a tutti i fenomeni emergenti e interessata alle differenze estetiche ma nel frattempo il Ministero della cultura si trasforma in un rissoso centro di potere, da cui le arrivano attacchi sempre più numerosi. Mentre all’estero le finalità artistiche di Novecento riscuotono grande successo, in Italia alla Sarfatti viene meno buona parte degli appoggi. L’emarginazione di questa lucida intellettuale coincide in architettura con l’adozione da parte del regime di un freddo e retorico stile littorio, ben lontano dalla sobrietà formale del razionalismo. Il tentativo grassiniano di dare al fascismo una piattaforma ideale ormai è diventato ingombrante, Margherita non concorda con le imprese coloniali, non approva l’intensificarsi dei rapporti con la Germania nazista, si scontra con l’ostilità di gerarchi avidi e senza scrupoli come Farinacci e Starace e nel contempo percepisce la perdita di interesse nei suoi confronti da parte di Mussolini. Nel 1938, di fronte al clima così mutato, la Sarfatti fugge all’estero; la sua famiglia invece vive in pieno le vicende del totalitarismo antisemita, tanto che una sorella Nella Grassini Errera rimarrà vittima del lager ad Auschwitz. Margherita soggiorna prima a Parigi dove frequenta tra gli altri Jean Cocteau, Colette e Alma Mahler e infine si stabilisce in Sud America, dato che il suo desiderio di essere accolta negli USA non ha trovato risposta. Ritorna in Italia alla fine della guerra e nel 1955 riesce a far stampare una autobiografia dal titolo ‘Acqua Passata’, dove il rapporto con Mussolini è quasi ignorato. Resta invece inedito a lungo il primo manoscritto delle sue memorie intitolato ‘Mea culpa’, pubblicato solo post mortem con il titolo My fault. Negli ultimi anni Margherita si isola nella sua villa di Cavallasca, vicino a Como, dove morirà nel 1961.L’interesse per l’arte oppure per le ‘arti’ nasce precocemente e si esprime compiutamente in occasione dell’Esposizione Internazionale di arti decorative e industriali moderne tenuta a Parigi nel 1925 e delle Biennali di Monza e poi le Triennali di Milano, occasioni cui ella partecipa direttamente. I suoi interventi in questi ambiti sono stati oggetto di studi specifici ad opera di storici delle rispettive discipline pur tuttavia, ho deciso di riportarle in questo saggio per meglio capire la sua figura di Critico d’Arte e di donna ed i vari movimenti artistici che hanno caratterizzato il primo novecento. Come non ricordare il “ritorno a Ingres“ di Picasso, con la serie dei piccoli disegni naturalistici e dei ritratti di Ambroise Vollard e di Max Jacob, dipinti dal pittore spagnolo verso il 1915, testimonianza di uno dei “ritorni” più celebri della storia dell’arte del ’900, o quello altrettanto significativo del pittore italiano Gino Severini, che nel 1916 dipinse “in una forma semplice che rammenta i nostri primitivi toscani” il Ritratto di Jeanne e La maternità? Ma quale fu la pittura che deviò il suo corso nel nuovo classico del ’900? Secondo Franz Roh, il teorico tedesco del realismo magico, tutta la migliore pittura europea, dal cubismo al futurismo, all’espressionismo, fu interessata da questo “ritorno all’ordine” e la maggior parte degli autori che avevano propugnato le tesi dell’avanguardia si ritrovarono verso la fine del secondo decennio del secolo a ripassare la lezione degli antichi maestri. Nell’elenco delle tendenze realiste comparse tra la fine dei secondi anni Dieci e i primi anni Venti, Roh cita il naturalismo di Derain, il purismo di Ozenfant e Janneret, il classicismo di Valori Plastici, la scuola di Rousseau, il verismo di Dix e Grosz, il nuovo linearismo di Beckmann e Hofer. All’origine di questa sorta neo figurativa, che attribuiva alla pittura una funzione ermeneutica della realtà profonda attraverso lo studio delle apparenze, stava l’idea del ritorno inteso non come reazione all’avanguardia, bensì come richiamo dell’antico e del classico alla contemporaneità. Scriveva nel 1988 a questo proposito Jean Clair, in un importante saggio dedicato al realismo magico, che il ritorno della pittura a schemi saldamente legati alla tradizione antica era da considerare “insito nella vita stessa delle forme”: “Non il ritorno automatico, passivo e nostalgico ai valori sicuri del passato, bensì l’espressione ansiosa, dopo il decennio frenetico che la storia dell’arte aveva attraversato fra il 1905 e il 1915, del bisogno di fondare l’arte del dipingere su basi più solide e più stabili”. Che non si fosse trattato di un “ritorno” inteso come restaurazione di uno stile antico, contrapposto al linguaggio delle avanguardie del primo Novecento, lo dimostra l’ampio dibattito critico, vivacissimo soprattutto in Italia e in Germania, attorno alla definizione della parola classico, da non intendersi, come spiegava il letterato italiano Massimo Bontempelli, come una determinazione di tempo, bensì come una categoria spirituale: “classica – scriveva infatti Bontempelli, profeta della ‘fine dell’avanguardia’ – è ogni opera d’arte che riesca ad uscire dal proprio e da ogni tempo”. I critici letterari che si occupano della produzione letteraria di Bontempelli, adoperano di solito il termine “realismo magico” per definire i tratti tipici del suo stile letterario. Comunque, occorre rendersi conto del fatto che nelle opere di Bontempelli possiamo individuare sia elementi tipici proprio per il realismo magico sia elementi che rivelano l’ispirazione da altre correnti letterarie. La produzione bontempelliana quindi non può essere definita nei limiti di un solito filone letterario, ma si tratta piuttosto di un risultato dell’influenza di vari movimenti letterari, artistici e filosofici del tempo. Siccome la presente tesi si occupa dei racconti di Bontempelli scritti negli anni ‘20 e ‘30, nei quali l’influsso del realismo magico sulla produzione dello scrittore prevale sulle altre tendenze, è opportuno soffermarsi proprio su questo argomento. Lo scopo di questo capitolo è perciò quello di provvedere uno sfondo teoretico necessario per poter affrontare l’opera letteraria dello scrittore. Si propone di definire il termine realismo magico e di individuare i tratti tipici di questo filone letterario, confrontandolo con altri filoni letterari che manifestano tratti simili. Inoltre, ci si concentra sulla concezione del realismo magico di Bontempelli, delineando i suoi concetti più significativi. Esaminando l’espressione “realismo magico”, si può notare che si tratta di una sorta di ossimoro che unisce due elementi semanticamente in contrasto – da una parte il sostantivo “realismo” che si riferisce a situazioni e ambienti reali, e dall’altra l’aggettivo “magico” che viene associato con il mondo fantastico e immaginario. Tra i tratti tipici del realismo letterario appartengono l’ambientazione precisa, i protagonisti comuni e la rappresentazione fedele della vita dei personaggi. Gli autori quindi cercano di raffigurare la realtà quotidiana, creando nei lettori la sensazione che raccontino fatti veri. Dal punto di vista della forma, la narrativa tende a seguire l’ordine degli avvenimenti senza sperimentazioni stilistiche o formali, facendo continuamente il riferimento al reale. Il termine “magico”, invece, viene spesso usato per riferirsi a eventi straordinari, soprannaturali e inverificabili. Così, nella narrazione si trovano temi e situazioni inconsueti che si intrecciano e si oppongono con gli schemi tradizionali usati nel realismo. Il termine “realismo magico” è quindi una sintesi di due termini opposti che costituiscono un legame tra il mondo reale e fantastico. In altre parole, si parla del realismo magico quando gli elementi magici appaiono in un contesto realistico. Il termine “realismo magico” è per la prima volta utilizzato nel 1925 dal critico tedesco Franz Roh per descrivere lo stile particolare del gruppo dei pittori tedeschi appartenenti al movimento artistico “Nuova Oggettività”. Gli artisti appartenenti a questo movimento cercano di esprimere l’orrore e il caos della guerra, ma i loro dipinti sono privi di ogni sentimentalità. Per di più, nella loro concezione della realtà sono notevolmente influenzati dal pittore italiano Giorgio De Chirico, esponente principale della corrente artistica che si chiama “La Pittura metafisica”. Tra i caratteri fondamentali della produzione di De Chirico appartengono per esempio le prospettive multiple, l’assenza dei personaggi umani, le scene che si svolgono nei posti isolati e l’atmosfera inquietante, tutto ciò suscita la sensazione di solitudine e straniamento. Dunque, i dipinti metafisici raffigurano oggetti ed eventi che fanno parte della realtà quotidiana, ma li presentano da prospettive diverse, creando una sensazione del mistero e della meraviglia. A differenza del realismo magico letterario, nella pittura non troviamo gli elementi magici o fantastici inquadrati esplicitamente nella rappresentazione della realtà, ma si tratta piuttosto di una visione del mondo attonita, come se la realtà fosse vista attraverso un obiettivo misterioso. Successivamente, il realismo magico è associato con il realismo insolito degli artisti come Ivan Albright, Paul Cadmus e George Tooker che fanno parte del gruppo di pittori americani attivi negli anni ‘40 e ’50. Quanti dipinti si potrebbero considerare delle vere e proprie opere che fanno parte di quel rinnovamento che, in opposizione ai linguaggi delle avanguardie, allo scorcio del secondo decennio del secolo tornarono a parlare l’antica lingua dei grandi maestri primitivi italiani, di Giotto, di Piero della Francesca e di Paolo Uccello, alcuni addirittura ritrovando nuove suggestioni nel mito delle culture arcaiche e primitive, così come magistralmente rilette da Picasso il volto più dionisiaco dell’arte contemporanea, in alcuni tra i suoi più incredibili dipinti degli anni Dieci, primo fra tutti Les demoiselles d’Avignon? Un sintetismo primitivo, che aveva appassionato anche il giovane Amedeo Modigliani, quando giunse a Parigi nel 1906, e aveva messo alla prova, suppergiù negli stessi anni, un po’ tutta l’avanguardia, da Apollinaire a Marie Laurencin, da Delaunay a Vlaminck, da Brancusi a Max Jacob, da Picasso a Max Weber, che nel culto delle antiche civiltà nere, ma soprattutto nell’opera incorrotta e profondamente ingenua del Doganiere Rousseau, colsero l’esempio più alto del realizzarsi, nell’attualità della storia contemporanea, di una nuova, perfetta congiunzione di forma, verità e simbolo. E proprio a Rousseau va dato merito se rimase accesa nell’arte europea del XX secolo una fiamma di naïvetè arcaica ed innocente, capace di alimentare il cuore di molti artisti moderni, dai già citati Picasso, Derain, Max Weber, all’italiano Carlo Carrà, che per questa via, spenta la passione futurista e non ancora domata quella metafisica, ritroverà, verso il 1915, i caratteri distintivi di una “pittura dell’origine” sua propria, animata da suggestioni e motivi che richiameranno a nuova vita non solo la tradizione arcaica dei pittori primitivi del Trecento e Quattrocento ma anche la forza perduta del simbolo. In Carlo Carrà il ricordo della figurazione primitiva di Rousseau diventerà l’allegoria del Fanciullo prodigio, un dipinto del 1915, in cui si è voluto acutamente ravvisare una sorta di ritratto dell’Artista, di colui che attraverso la sofferenza dell’età adulta ha ritrovato la fanciullezza e nella fanciullezza ha riabbracciato il prodigio della Meraviglia, lo sguardo incontaminato della purezza. Nello spazio senza tempo, dove viaggia La carrozzella, dipinta da Carrà nel 1916 o nel primitivismo scarnificato ed enigmatico di I romantici, sempre del 1916, si compie la brevissima ma intensa stagione del primitivismo italiano, che volgerà da queste premesse, verso l’affermazione di quella che il grande critico e storico dell’arte tedesca Wilhelm Worringer, proprio riferendosi all’opera di Carrà, nel 1921 definì “la misura classica dell’arte europea”. Se per la maggior parte degli artisti europei il ritorno alla figurazione coincise con un atto di rinuncia dei postulati teorici e formali delle dottrine dell’avanguardia, ci fu anche chi, come il grande pittore italiano di origine greca Giorgio de Chirico, sulla strada del classico aveva da sempre indirizzato la propria ricerca. Il pittore greco dal volto d’Apollo, padre della Metafisica, aveva fatto la sua scelta fin dai tempi della giovinezza, quando, negli anni di Monaco, aveva adottato come suoi maestri ideali Bòcklin e Klinger, e aveva trovato conferma alla sua idea di moderno nella scultura antica e nelle regole dell’arte italiana del Rinascimento. Fedele ai propri convincimenti, che gli fecero abbracciare da subito la strada di una figurazione classica, de Chirico, fin dall’inizio attese alla vita segreta delle cose e tentò di rappresentarla nelle sue prime composizioni metafisiche, all’incirca a partire dal 1910, sebbene l’anno ufficiale di nascita della Metafisica va ricondotto dal 1917, quando nella città di Ferrara, lì giunti per diverse ragioni, si incontrarono e ne condivisero le formulazioni di poetica Carlo Carrà, il più giovane Filippo de Pisis, Alberto Savinio, fratello di de Chirico e lo stesso de Chirico, che alla metafisica aveva da tempo dedicato il suo cuore e la mente. Come dice lo stesso De Chirico dalle pagine di “Valori Plastici”: “Tornare al mestiere! Non sarà cosa facile, ci vorrà tempo e fatica”, tuonava Giorgio de Chirico alla fine del 1919 sulle pagine di “Valori Plastici”, ad un anno dalla prima uscita della rivista diretta da Mario Broglio. Quel processo di “restaurazione” dei valori formali che si era avviato nelle arti figurative in tutta Europa nell’immediato primo dopoguerra trovò espressione in Italia in questa rivista, luogo di convergenza e di confronto delle forze più vive dell’arte e della critica di quegli anni. Sin dal primo numero ospitò sulle sue pagine i nomi più diversi di critici e artisti, provenienti da situazioni culturali talvolta contrastanti. Comune era però l’asserzione della crisi della modernità, così come era stata espressa nell’esperienza dell’avanguardia e la ricerca di uno stile e di un linguaggio che si esprimessero nell’ambito di regole formali eterne. Ciò si traduceva nella volontà di riaffermare la concezione dell’arte come esperienza della tradizione, specificamente quella italiana, e di propugnare come alternativa un rinnovato classicismo, talvolta invocato come “italianismo artistico”. Questo clima intellettuale tipicamente italiano e l’intento di definire “il carattere dell’arte” distinguono il “clima di Valori Plastici” dalla generale tendenza del ritorno all’ordine che è diffusa negli stessi anni in tutta Europa. È datato aprile 1918 il frammento poetico Zeusi l’esploratore che Giorgio de Chirico invia a Broglio da Ferrara perché appaia sul primo fascicolo di “Valori Plastici”, la cui uscita verrà invece posticipata, per vari motivi, al mese di novembre. Il primo numero di “Valori Plastici” apre all’insegna della Metafisica, recando sul frontespizio l’Ovale delle apparizioni di Carrà del 1918. Si accrediterà così l’immagine di rivista ufficiale della Metafisica, presentandosi principalmente come tribuna di espressione di de Chirico e Savinio, anche se nella mente di Broglio non c’era un preciso programma, né l’intenzione di lanciare manifesti, quanto piuttosto quella di provocare un confronto all’interno di una situazione comune. Nello stesso periodo si pubblicava il volume Pittura metafisica di Carlo Carrà. Tra il 1918 e il 1919 si parlava perciò ancora di Metafisica, finalmente chiarificata dai primi scritti teorici pubblicati dagli artisti stessi, proprio mentre evolvevano verso nuovi approdi. Et quid amabo nisi quod aenigma est? era stato infatti il titolo da lui dato molti anni prima ad un famosissimo autoritratto, opera nella quale il suo volto appare segnato da una profonda inquietudine, quasi che la capacità di vedere oltre le apparenze, gli rivelasse tutte le pene della solitudine e della malinconia, proprie dell’uomo contemporaneo. Ogni Piazza d’Italia del resto sarà, nello stesso tempo, luce accecante e ombre inquietanti, visibile e invisibile che si rincorrono, presente e passato che si congiungono. Se per i futuristi la relazione tra lo spazio e gli oggetti fu azione allo stato puro, per i pittori metafisici divenne luogo della rivelazione magica della vita nascosta delle cose: gli oggetti, pur rimanendo riconoscibili, persero ogni legame di contiguità e di logica concatenazione con lo spazio che li circondava o con gli altri oggetti disposti nello stesso spazio. Ne furono prove superbe le rarissime nature morte metafisiche di Giorgio Morandi che alla metafisica giunse più tardi, accompagnato oltre che dalla lezione di Carrà, da un ripensamento in guisa di una assoluta rarefazione delle cose nello spazio della lezione di Cézanne e la serie più nota delle Piazze d’Italia di de Chirico appunto, come la celebre Matinée angoissante, dipinta nel 1912, che ci rivela lo spettro dell’enigma in una Torino assolata, con il lungo porticato in ombra che corre a perdita d’occhio sulla sinistra e che incrocia in primo piano la sagoma cupa di un treno che passa, ricordo improvviso del padre e della terra natale. “La pittura di de Chirico scrisse Soffici sulla rivista “Lacerba” nel 1914 non è pittura nel senso che si dà oggi a questa parola. Si potrebbe definire una scrittura di sogni. Per mezzo di fughe quasi infinite d’archi e di facciate, di grandi linee dirette, di masse immani di colori semplici, di chiari e di scuri quasi funerei, egli arriva ad esprimere, infatti, quel senso di vastità, di solitudine, d’immobilità di stasi, che producono talvolta alcuni spettacoli riflessi allo stato di ricordo della nostra anima quasi addormentata. Giorgio de Chirico esprime come nessuno l’ha mai fatto “la melanconia patetica di una fine di bella giornata in qualche antica città italiana, dove in fondo a una piazza solitaria, oltre lo scenario delle logge, dei porticati e dei monumenti del passato, si muove sbuffando un treno, staziona il camion di un grande magazzino, o fuma una ciminiera altissima nel cielo senza nuvole”. Alla Metafisica successe il tempo del mito e dell’allegoria: negli anni Venti, la pittura di de Chirico, con la quale ebbe interessanti assonanze quella dell’amatissimo fratello Alberto Savinio, più interessato però alla rappresentazione onirica e surreale della realtà che all’indecifrabilità dell’enigma, si volgerà alla rilettura dei grandi Maestri del passato. La perfezione tecnica e la misura di Raffello, Tiziano, Dosso Dossi, Poussin (e negli anni Trenta soprattutto Rubens, Fragonard, Delacroix) gli fecero comprendere come raggiungere il folle sogno dell’immortalità, senza per questo rinunciare alla seduzione dell’enigma, cui si confacevano le sembianze dei manichini gladiatori, copia dei dioscuri omerici che compaiono nei suoi quadri verso il 1926, o gli archeologi ermafroditi, con il torace e il ventre ingombro di colonne, templi, alberi e quanto d’altro la sua fervida fantasia e lo stato di sogno gli suggerivano. Gino Severini anticipa tutti. Già nel 1916 aveva affermato la propria indipendenza dal futurismo, approdando alle sue prime composizioni classiche, una scelta che troverà fondamento teorico nel testo pubblicato a Parigi del 1921. È in anticipo anche sulle scelte d’altri grandi pittori del tempo, come per esempio Pablo Picasso, che solo nel 1917 porterà a conclusione, grazie anche al viaggio in Italia, quel processo pur iniziato nel ’15 di trasformazione della sua pittura in direzione neoclassica. Con Severini è forse Carlo Carrà l’artista italiano che meglio rappresenta il passaggio del guado tra avanguardia, Realismo magico, Novecento e per certi aspetti antinovecento. La sua pittura attraversò e fu protagonista di tutte le principali tappe dell’arte italiana del primo ’900, dal futurismo al primitivismo, all’avventura metafisica, all’approdo alle poetiche della nuova figurazione di Novecento, alla sublimazione dell’opposizione al regime nelle sequenze dei paesaggi dipinti negli anni estremi della dittatura. “Mutare una direzione in arte – ebbe a scrivere a questo proposito in La mia vita – non significa rinnegare tutto il passato, bensì allargarlo fino a compenetrarlo con un altro concetto estetico. Scoprire nuovi rapporti ignoti, aprire meglio gli occhi per comprendere una somma maggiore di realtà”. Passata brillantemente la prova metafisica, in cui realizzò quadri dominati dall’inquietudine ma anche opere di più complessa fattezza nate dall’ambiguità come la natura morta metafisica superò la fase critica del passaggio tra il sogno visionario metafisico e la concretezza del realismo di Novecento, tra il ’19 e il ’21, dipingendo alcune delle più radiose rappresentazioni della storia dell’arte europea del ’900. I dipinti Le figlie di Loth, L’attesa, Il Pino sul mare, esercizi di umiltà e grandezza insieme, mostrarono nella restaurazione del candore arcaico ispirato dalla pittura dei grandi Primitivi italiani, la continuità della tradizione, che allo spirito del tempo presente portava dal passato i doni della Meraviglia, della Scoperta e dello Stupore, di una pittura, insomma, che era nello stesso tempo etica ed estetica. Negli anni successivi Carrà riportò la sua pittura dentro un alveo di più forte naturalismo, dando vita ad una serie di mirabili paesaggi con figure o semplici marine raffiguranti il litorale toscano, che rappresentarono anche in età tarda, tra la fine degli anni Venti e i Trenta, il permanere nella sua ricerca di caratteri di magico realismo, coniugati non più alla rarefazione narrativa del suo antico primitivismo o della parentesi metafisica, ma piuttosto alla riscoperta di una nuova mitologia del quotidiano, ancora ricca d’incanto e di sorpresa, nella quale azioni e cose, nel permanere nell’atmosfera di un misterioso incanto, assurgevano al ruolo di nuovi riti. La ricomparsa in epoca tarda di una riflessione sulla pittura di paesaggio, impegnò Carrà nell’esecuzione quasi ossessiva di opere in cui luce e atmosfera davano spazio a quella voce antinovecentista, che fu di molti artisti contrari al regime, che proprio nella rinascita di temi molto ortodossi della pittura, come il paesaggio, seppero attendere negli anni più bui del fascismo all’esercizio etico del mestiere. La Metafisica rappresentò un episodio straordinario dell’arte italiana, ma limitato nel tempo. I suoi protagonisti, in primo luogo de Chirico, ma è il caso anche di Carrà, de Pisis, Morandi, Savinio, alle soglie degli anni Venti erano già consapevoli che questo capitolo intenso ma breve della loro ricerca stava volgendo alla fine e la loro pittura era già in ascolto di nuove suggestioni, attratta più fortemente e più compiutamente da un esercizio formale e di composizione che superava, in direzione di una ritrovata classicità, la separazione dell’enigma metafisico. Peraltro la pittura metafisica contribuì con la sua poetica di rarefazione formale, di visionaria percezione della realtà, di straniante relazione tra i luoghi e le cose, a preparare un fertile terreno per quegli artisti che alla pittura dell’avanguardia avevano dato poca retta, o per brevissimo tempo ne avevano condiviso la poetica come Mario Sironi, Achille Funi, Ubaldo Oppi, Felice Casorati, Virgilio Guidi, Antonio Donghi, Piero Marussig, Arturo Martini, artisti tutti già attivi sulla scena dell’arte nazionale nei secondi anni Dieci. Costoro, ignorando il clamore futurista in quel torno di tempo ancora acceso nei toni, e certo più interessati al richiamo della storia, erano pronti a scrivere il nuovo capitolo della pittura italiana postbellica, che dalla storia e dalla riflessione sul passato voleva trarre originale energia creativa. Il loro intento fu quello di far rivivere la tradizione antica nell’attualità del tempo presente, di ridare fiato alla ricerca dell’origine e dell’identità, di promuovere in un clima culturale dove la tendenza neopurista vinceva le ultime resistenze dell’avanguardia, una ricognizione sui repertori antichi per farne nuova fonte d’ispirazione. Tra gli interpreti più originali della traduzione metafisica in testi di puro arcaismo magico fu senza dubbio il piemontese Felice Casorati, autore di alcune tra le più toccanti e misteriose composizioni di quegli anni “di mezzo”, tra il ’20 e il ’23, anni sospesi tra la vocazione all’incanto del realismo magico e la più solida partita di Novecento. Casorati non visse il travaglio dei molti cambiamenti di stile, che aveva accompagnato la maturazione per esempio dell’opera di Carrà: il suo abbandono alla figurazione composta e tradizionale fu una scelta di antica data e risaliva ancora ai primi anni Dieci, quando nel 1907 fu accettato tra gli espositori della Biennale di Venezia e poi, tra il 1913 e il 1920, fatta salva la parentesi della guerra, partecipò sempre a Venezia alle rassegne di Ca’ Pesaro. Dunque non di ritorno ma piuttosto di continuità nella cifra classica si deve parlare per questo grande autore, che nella casa-studio di via Mazzini a Torino, accoglieva come discepoli giovani artisti come Gigi Chessa, Francesco Menzio, Carlo Levi, tutti protagonisti di quel momento d’oro della vita torinese, all’incirca verso il 1923, in cui le aspettative di un’arte nuova vennero a coincidere con la poetica del realismo magico. Ma quale antico, quale classico fu invocato da questi artisti sopravissuti alla tragica, lunga parentesi della prima guerra mondiale, che cambiò le sorti e il volto del vecchio continente, aprendo la strada a nuovi nefasti destini, nei primi anni Venti, anni ancora innocenti, celati sotto le spoglie dell’utopia socialista? Non bastò all’inizio richiamare a nuova vita la gloriosa storia che aveva fatto grande l’Italia artistica del Rinascimento: i più, Carlo Carrà in testa, vollero spingersi ancora oltre, fino alle nude pendici rocciose del Monte sacro dipinto da Giotto, per recuperare all’arte contemporanea l’essenzialità narrativa della lezione esemplare di verità ed etica dei Primitivi italiani, da Giotto a Masaccio a Paolo Uccello. Modelli che divennero esempi di riflessione per la nuova poetica del realismo magico, dove proprio il silenzio magico di Giotto fu la parola d’ordine che non fece perdere la rotta nella notte buia dell’ideologia, il silenzio delle parole mute, dei luoghi senza tempo, di vite immobili e sospese, l’unica vita possibile per chi non volle misurarsi o confondersi con la retorica di Stato. La magica e immota segretezza che pervase di sé gli oggetti della pittura italiana ed europea degli anni Venti, fu espressione di valori contrari a quelli delle avanguardie, sia nell’ambito pittorico che in quello afferente il significato dell’opera d’arte, che rispose a una nuova visione dell’oggetto acquistava il valore assoluto di “simbolo profondo per contrastare l’eterno flusso mediante qualche cosa che persiste”. È questa una definizione di poetica che attribuiva alle cose animate e inanimate della pittura una funzione escatologica, vicina al pensiero di Nietzsche e Schopenhauer e in evidente contrapposizione con la filosofia bergsoniana dello slancio vitale. Lo spirito del realismo magico, cresciuto e nutrito tra il 1918 e il 1922 grazie al dibattito teorico aperto dalle pagine della rivista “Valori Plastici” diretta da Mario Broglio rivista cui contribuirono le intelligenze più vive dell’arte del tempo, da de Chirico, a Carrà, a Savinio all’incirca verso il 1923 confluì e per certi aspetti si saldò con i caratteri più austeri e composti di Novecento, che non fu un vero e proprio movimento, come del resto non lo era stato il realismo magico, ma più semplicemente una tendenza di stile. L’eterogeneità del lavoro dei pittori, che oggi si indicano come novecentisti, non consentì infatti di elaborare una poetica comune, anche se furono condivisi alcuni caratteri distintivi di uno stile che fece ricorso alla figurazione, alla fedeltà ai canoni di un naturalismo idealizzante, ad una composizione sommaria, non descrittiva, ma vigorosa nella ritrovata plastica dei volumi, ad atmosfere sospese che accoglievano forti suggestioni del realismo magico. Iconografia e caratteri stilistici di questa nuova figurazione traevano esempio da modelli del mondo classico per eccellenza, ma anche da quello già ricordato dei Primitivi italiani e soprattutto dalla lunga stagione rinascimentale e dalla sua rinascita in età neoclassica, da artisti della tempra di Ingres, ma anche dalla pittura dei fiamminghi e degli etruschi, un soggetto quest’ultimo che trovò compiuta celebrazione nell’opera di Massimo Campigli. I temi più diffusi furono il ritratto, la natura morta e l’allegoria, porta aperta tra la realtà apparente e la verità profonda delle cose. L’allegoria apparve nelle sue molteplici sembianze, da quella mitica a quella biblica, da quella implicita, celata dietro l’apparente realismo delle cose rappresentate, a quella esplicita rivolta alla poesia sommessa e raccolta del quotidiano, a quella, infine, allusiva legata ad un repertorio iconografico di simboli che riflettevano le grandi problematiche della vita e della morte, del tempo, del sacro. Novecento nacque nel 1922 da un raggruppamento di sette artisti, Bucci, Dudreville, Funi, Malerba, Marussig, Oppi, Sironi, che si presentarono riuniti sotto quest’etichetta nel 1923 alla mostra tenutasi nella Galleria Pesaro di Milano, con gli auspici di Mussolini e la presentazione della giornalista, critica d’arte Margherita Sarfatti. Nel 1924 il gruppo “Sei pittori del Novecento” (Oppi si era isolato) si presenta alla Biennale di Venezia con un testo della Sarfatti in catalogo: scopo della mostra, così come delle esposizioni che seguiranno, alcune di grande rilievo come quelle del 1926 e del 1929, fu quello di ridare alla pittura italiana, un primato nell’ambito della ricerca artistica europea. Margherita Sarfatti, teorica del gruppo, lavorò con fede e passione per ricondurre ad unità di stile e d’intenti il lavoro dei migliori artisti italiani dell’epoca, anche allo scopo di rifondare una tradizione pittorica italiana moderna. Tenace e volitiva Margherita Sarfatti difese i caratteri di “italianità” dell’arte contemporanea, cui però non pose mai veti né vincoli, accogliendo nel suo gruppo le più disparate inclinazioni, purché rivolte all’identico progetto di sostegno e valorizzazione dell’arte nazionale. E proprio in quella direzione, di un’arte profondamente italiana, capace di rappresentare il nuovo sentimento degli artisti, attenti ad un’interpretazione in chiave contemporanea della tradizione passata, ma anche di un’arte coincidente con i nuovi valori dettati dal regime si pose la delicatissima questione del rapporto arte e politica. È delicatissimo il compito di valutare criticamente, alla luce della storia tragica del Ventennio fascista, il significato di quella affinità tra l’interesse degli artisti per i Maestri Antichi e quell’identica passione espressa dalla dittatura, che in Italia proprio sulla pittura degli Antichi costruì gran parte del proprio repertorio di simboli e vaneggiamenti, di glorie e d’eroi, mostrando nella retorica della citazione il limite della propria politica conservatrice. I rapporti tra la poetica di Novecento e il regime di Mussolini, che a Novecento diede il proprio appoggio ufficiale nel 1923 in occasione della prima mostra del movimento alla Galleria Pesaro di Milano e nel 1926 alla mostra Il Novecento Italiano sempre a Milano, è un capitolo complesso della storia artistica dell’Italia fascista tra gli anni Venti e i Trenta. E la complessità derivò proprio dall’ambiguità della relazione tra l’immaginario dell’ideologia fascista, che nella sua febbrile attività di propaganda rispolverò molti dei vecchi miti dell’Italia antica, attualizzandoli in una veste retorica e conservatrice, e la poetica autenticamente originale di quel ritorno all’ordine, che dopo l’euforia dell’avanguardia, aveva ristabilito il valore dello stile come idea, della regola come metodo di conoscenza, del classico come origine e attualità. Negli anni Trenta il disperdersi all’interno della poetica di Novecento del silenzio e dell’aura incantata del realismo magico, che lasciò il posto ad un realismo sempre più concreto e assertore di valori ideologici funzionali al fascismo, fu manifesta espressione della fine dell’autonomia dell’arte. La perdita del sogno e del principio di verità favorirono l’avvento di un nuovo corso della pittura italiana, forzatamente epico e monumentale, per molti aspetti anche glorioso nei risultati, soprattutto là dove si misurò con le grandi dimensioni degli affreschi murali di propaganda. Mario Sironi fu tra i molti che si ritrovarono a dover fare i conti con le grandi committenze pubbliche, destinate a celebrare i sogni di gloria del regime, i suoi luoghi comuni, le sue virtù. Avvezzo ad una straordinaria e colta frequentazione dei repertori classici, frammista ad una pressoché unica capacità di governare con il suo gesto creativo la tettonica degli spazi delle grandi composizioni, il suo contributo emerse per qualità e altezza dei risultati pittorici, certo non secondi a quell’autentica vocazione magico realista, che nel corso degli anni Venti, nelle sue misteriose composizioni, come per esempio nel superbo dipinto del 1924 L’allieva, aveva offerto uno dei più significativi contributi del XX secolo alla rappresentazione della tragica melanconia dell’uomo contemporaneo. Per molti altri, invece, la concessione ad una pericolosa adulazione, trasformò il gesto creativo in una pedissequa propaganda, di segno dunque contrario ai principi di un’arte realmente libera. Non fu sempre facile nel turbinio degli eventi dell’arte del Ventennio riconoscere e distinguere la moralità dell’esercizio autentico dell’arte dall’acquiescenza al potere. Ciò avvenne principalmente per due motivi: da un lato per il fatto che in Italia la questione culturale non diventò mai una bandiera in prima linea della propaganda politica, a tutto vantaggio della circolazione delle idee dell’arte, anche di quelle non propriamente in linea con il gusto del regime, dall’altro lato perché anche là dove, come in Novecento, i temi della pittura coincisero con i nuovi miti del potere politico, questo fatto, come sopra si è ampiamente scritto, non fu se non in casi eccezionali tacciabile di consapevole connivenza ideologica. Va peraltro rilevato che l’organizzazione delle attività culturali sul territorio nazionale aveva creato nel settore artistico uno strumento molto avanzato di controllo, costituito da una rete capillare di premi e di mostre “sindacali” provinciali e regionali, i cui migliori esponenti confluivano nelle grandi manifestazioni nazionali. A queste mostre, è inutile dire, posizioni contrarie al regime non furono naturalmente ammesse, mentre furono ammesse, forse perché non riconosciute come antitetiche alla politica culturale del fascismo, molte opere che oggi si possono definire “di resistenza”, opere nelle quali gli artisti, contrari al gusto dominante di Novecento, e contrari soprattutto all’idea di un’arte di regime, manifestarono il loro disagio con una fuga nelle più svariate direzioni, dal facile ripristino della poetica del paesaggio postimpressionista, all’espressionismo di toni accesi della Scuola romana, all’astrazione geometrica dei pittori milanesi attivi attorno alla galleria del Milione di Milano, al chiarismo promosso dal critico Edoardo Persico, al Gruppo dei Sei di Torino sostenuto dal critico Lionello Venturi. In questo modo si assicurò alla vita culturale del Paese un passaggio sufficientemente ampio attraverso le more del fascismo, che solo alla fine degli anni Trenta, poco prima dello scoppio della guerra, rafforzò le proprie difese contro l’opposizione culturale, che inconsapevolmente era stata nutrita e cresciuta al suo stesso interno nel corso degli anni precedenti. Negli anni Trenta, nel clima di generale dispersione delle regole e degli indirizzi di stile, che avevano governato il fronte dell’arte novecentista, emerse dunque alla superficie, pur celata da un’apparente, innocua diversità, la fronda di chi non era stato solidale all’idea del ritorno all’ordine e aveva battuto altre strade. Molti di questi artisti trovarono ragioni comuni in una pittura calata in una sorta d’esistenzialismo capace di slanci lirici della materia e del colore, inimmaginabili per la sobria plastica di Novecento, o, ancora, sospinti verso il racconto di una visione tragica e angosciosa della realtà, cosa anche questa severamente bandita dalle serene, placide composizioni del vigoroso classicismo di Novecento. Tra i molti artisti impegnati nella battaglia per la sopravvivenza di quella voce antiformalista e anticlassica, Mario Mafai e Renato Guttuso rappresentano gli estremi di una ricerca, che per vie diverse coltivò l’identica tensione di ansia e di verità. Da un lato ci fu l’avventura della scuola di via Cavour a Roma, culla della cosiddetta Scuola romana, che ebbe come principali protagonisti tra il 1927 e il 1930 Mario Mafai, la moglie Antonietta Raphäel, e l’amico intimo Scipione. La loro storia, che iniziò con il comune apprendistato presso la Scuola libera di nudo a Roma nel 1925, si intrecciò naturalmente con quella “ufficiale”, scandagliò le possibilità dell’arcaismo, della metafisica, del classicismo, per approdare infine, in dialettica con Novecento e non come radicale opposizione, ad una pittura del tutto originale, intrisa di emozionalità dove il colore riconquistò una forte carica espressiva, aiutato dal ricorso ad un tonalismo romantico che soprattutto in Scipione e Mafai corroborava la forma di una nuova capacità evocativa, non più descrittiva e analitica ma sommaria ed enunciativa. La fine precoce di Scipione, morto nel 1933, e l’allontanamento dall’Italia di Mafai e della moglie Antonietta Raphäel, chiuse un capitolo brevissimo ma intenso dell’arte italiana, la cui eredità fu accolta e interpretata da altri artisti romani impegnati in percorsi alternativi alle strettoie del classicismo, come Cagli, Capogrossi, Melli, Ziveri. Protagonista del gruppo milanese ‘Corrente’, costituito da oltre una decina di artisti riunitisi nel 1938 attorno alla rivista “Vita giovanile”, fondata dal pittore Ernesto Treccani, fu invece il giovane Renato Guttuso, un’artista che salirà agli onori delle cronache internazionali dell’arte nell’immediato dopoguerra, per il suo rigoroso impegno culturale nella vita politica dell’Italia postfascista. Già sul finire degli anni Trenta Guttuso aveva fatto la sua scelta, proprio nella direzione anticlassica battuta da ‘Corrente’, che alla tradizione mediterranea e rinascimentale oppose una visione tutta europea, sorretta da una riflessione critica su quanto la pittura d’oltralpe aveva prodotto nella scia dell’anticlassicismo, dunque basata sul riesame dell’opera di Van Gogh, Ensor, Munch, gli espressionisti tedeschi e soprattutto di Picasso, sulla cui lezione si imposterà il lavoro di gran parte della pittura italiana alla fine della seconda guerra mondiale. Nel gruppo di ‘Corrente’ Guttuso rappresentò l’anima anti-lirica per eccellenza, che si opponeva a quel filone più incline all’espressività del colore che della forma, bene interpretato da Renato Birolli. La pittura di Guttuso fu inizialmente orientata in senso fortemente espressionista, sfuggendo ad ogni sospetto di classicità: il suo tragitto partiva da rappresentazioni nelle quali forma e colore, nell’esasperazione delle linee e dei toni, si mescolavano sulla tela come parti indistinguibili di una realtà nella quale, forse solo in misura pari alle visionarie tele di Scipione, si coagulava la ribellione alle regole e alla misura di Novecento. Agli inizi degli anni Quaranta – già dal 1937 Guttuso risiede stabilmente a Roma dove è vicino anche all’ambiente della cosiddetta Scuola romana – il suo espressionismo cede gli accenti più forti ad una più sobria figurazione, come nel caso di Figura, tavolo e balcone (1942) e Donna alla finestra (1942), opere nelle quali già si misura la sua vocazione per un realismo capace di accendere “una nuova sensibilità estetica, che andava di pari passo con una nuova coscienza sociale, che da un generico ribellismo antiborghese arrivava alla progressiva consapevolezza antifascista”. Negli stessi anni, nel silenzio di un’impresa quasi impossibile, giorno dopo giorno, ci fu chi giocò una partita assolutamente solitaria. È il caso del pittore bolognese Giorgio Morandi che rinunciò a partecipare a qualunque manifestazione pubblica e collettiva, dove l’arte fosse stata protagonista. Fu il suo un distacco dalla vita attiva, un prendere le distanze dalla politica, la dichiarazione di una propria diversità, così come diversa da ciò che si andava ricercando in Italia in quel torno di tempo, fu la sua opera, quotidianamente e quasi ossessivamente attesa allo studio e alla catalogazione delle poche, piccole cose del suo ristretto mondo domestico. Bottiglie, tazze, brocche e qualche barattolo vuoto, rimasto a decantare sul tavolo di casa divennero la ragione stessa della sua poetica, forma e contenuto della sua ricerca, tutta risolta nell’amore di un unico genere, la natura morta appunto, con qualche rara eccezione per il paesaggio. “Nel ’31 – scrive il critico Arcangeli nella monografia dedicata al grande bolognese – Morandi, torna a colare a picco, in silenzio. Modestamente, senza importunare nessuno, senza che nessuno intenda davvero, dipinge i quadri e lavora all’incisione ch’io ritengo le opere più ardite e nuove dell’Europa di quel momento. Sono i suoi soliti oggetti, ma adesso egli riprende l’indagine, tentata in profondità verso la fine del ’29 e proseguita saltuariamente nel ’30, con anche più dura, triste, accanita sapienza. Ogni opera, testimonia di un’ossessione allucinata, potente, quasi folle. Davvero, come testimonia Brandi, si potrebbe ora parlare d’attacco dissolvente all’oggetto… ma l’oggetto non cede mai… Sono i suoi ostaggi, questi oggetti di cui egli è, tuttavia, prigioniero; sono ostaggi e, sicuramente, houtes pates”. Solo un cenno ma ne vale la pena: la fine della seconda guerra mondiale azzera in Italia, come nel resto d’Europa, ogni certezza e riapre conflitti radicali tra gli artisti, tra chi è chiamato traditore e chi invece sa di non aver tradito. Ogni guerra vuole le sue vittime anche dopo la fine reale dei conflitti. In questo la cultura con le sue abiure e le sue licitazioni, con i suoi compromessi e le sue sconfessioni, sembra essere un terreno molto fertile dove si accalcano i morti, chi non ha reagito, chi non ha capito, chi non ha voluto capire, chi infine ha fortemente creduto. I vivi riannodano i fili della storia e per lo più ripercorrono il passato per ritrovare la strada.
La mostra è suddivisa in otto sezioni :
Novecento Italiano
Nei primi anni Venti, Margherita Sarfatti ha un ruolo di primo piano nell’orientare il gusto e l’attenzione di Mussolini verso le arti figurative. In qualità di Presidente del Consiglio, egli interviene all’inaugurazione della prima mostra dei sette Artisti del Novecento, tenutasi nel 1923 alla Galleria Pesaro di Milano, dichiarando di non voler incoraggiare un’arte di stato, in quanto “L’arte rientra nella sfera dell’individuo. Lo Stato ha un solo dovere: quello di non sabotarla […]”. I pittori che formano il gruppo originario Bucci, Dudreville, Funi, Malerba, Marussig, Oppi e Sironi sono tutti rappresentati in questa sezione, affiancati da altri artisti che partecipano alle mostre organizzate da Sarfatti a partire dal 1926, quando il movimento assume ufficialmente il nome di Novecento Italiano. Ognuno di essi dipinge in modo diverso, dalle stilizzazioni arcaiche di Campigli alle atmosfere sospese di Casorati, dalla concentrazione sui valori tonali di Morandi alle masse pesanti e squadrate delle figure di Sironi, ma per tutti valgono le parole di Sarfatti: “limpidità nella forma e compostezza nella concezione”, nonché quelle di Lino Pesaro che sottolinea la volontà di “fare dell’arte pura italiana, ispirandosi alle sue purissime fonti, sottraendola a tutti gli ‘ismi’ d’importazione”.
L’immagine del potere
Il ventennio fascista vede una larghissima diffusione dell’immagine di Benito Mussolini. La sua effigie viene utilizzata a fini di propaganda e costruzione del consenso, attraverso l’esaltazione di tratti fisionomici e caratteriali che diventano metafore del potere. L’evoluzione dell’iconografia mussoliniana segue lo svolgersi degli eventi, riflettendo l’ascesa del Duce verso un regime dittatoriale e le sue ambizioni imperialiste. I ritratti degli anni Venti rappresentano il primo ministro in abiti borghesi, nel solco del ritratto di matrice ottocentesca, anche se non mancano i ritratti ideali che ne fanno la personificazione di una rinnovata classicità, come ad esempio il busto monumentale commissionato a Wildt da Sarfatti per la Casa del Fascio di Milano. Qui il dittatore appare, severo e ieratico, nelle vesti di un imperatore romano. Questa iconografia classicista si affermerà ancor di più negli anni Trenta, per legittimare l’espansione coloniale dell’Italia. In quest’epoca prevale l’immagine del Duce come emblema di forza e progresso, modernizzato dallo stile degli artisti futuristi che lo ritraggono come eroe “nuovissimo”: condottiero a cavallo, nocchiere al timone della nazione, aviatore. Nelle sculture di Thayaht e di Bertelli la testa di Mussolini si trasforma in un elmo metallico o in una sintesi dinamica che esprime forza ed energia, un profilo che ruota di 360 gradi, metafora di colui che tutto vede e controlla. Come scrive Carlo Belli: “un candore commovente ci spingeva a credere che il fascismo fosse il movimento instauratore di una lucida modernità europea!”.
Futurismo. Celebrare l’azione
I rapporti di Mussolini con Marinetti e il movimento futurista sono complessi e non sempre lineari, tra allontanamenti e ritorni, ammirazione e distacco. Fascismo e Futurismo condividono il mito dell’azione, l’interventismo, l’estetica della guerra e dei mezzi meccanici, in particolare gli aeroplani, il fascino della scienza e della tecnica. Negli anni Trenta, gli aeropittori e gli artisti della seconda stagione del movimento fanno proprie le esigenze propagandistiche del regime, celebrandone gli ideali e coniando addirittura il termine “futurfascismo”. Tuttavia, l’avanguardia non riesce a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella politica culturale del ventennio, come si può capire dalla quantità modesta di opere futuriste entrate a far parte delle collezioni pubbliche e dal limitato coinvolgimento di artisti quali Prampolini, Balla e Depero nelle grandi committenze statali. Se è vero che il Futurismo non diviene mai arte di Stato, il movimento è però determinante per fondare qualcosa di più importante: un’estetica moderna in Italia. Un linguaggio visivo innovativo che sfrutta tutte le opportunità offerte dal vasto sistema autocelebrativo del regime, esprimendosi nella grafica e nell’illustrazione, negli allestimenti per padiglioni ed esposizioni, in immagini che vengono riprodotte in serie, amplificando in sommo grado questa nuova estetica.
Arte monumentale
Il Manifesto della pittura murale, firmato da Sironi, Funi, Campigli e Carrà nel 1933, sottolinea il valore collettivo e morale della grande decorazione, la sua destinazione sociale e la sua capacità di esprimere valori ideali. L’arte pubblica, diversamente da quella destinata ai salotti borghesi, deve essere accessibile a tutti e Sironi auspica una rinascita delle arti frutto della complementarietà di arte e architettura. “Quando si dice pittura murale” scrive l’artista “non s’intende dunque soltanto il puro ingrandimento sopra grandi superfici di quadri che siamo abituati a vedere […]. Si prospettano invece nuovi problemi di spazialità, di forma, di espressione, di contenuto lirico o epico o drammatico”. La questione della sapienza tecnica e della conoscenza del mestiere si rivela fondamentale per affrontare le difficoltà della grande decorazione a mosaico o ad affresco. Oltre a Sironi, impegnato nella decorazione dell’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma, si misura con questa tecnica Achille Funi, per il quale il ministro Bottai istituisce la prima cattedra di affresco in Italia, all’Accademia di Brera. I cartoni preparatori esposti in mostra evidenziano la sua predilezione per soggetti mitologici o tratti dalla storia antica, in sintonia con il classicismo novecentista. Tra gli scultori particolarmente attivi nell’ambito dell’arte pubblica vi è Arturo Martini che, nel nuovo Palazzo di Giustizia a Milano, colloca il grandioso bassorilievo in marmo La Giustizia corporativa, qui in una fusione in bronzo di dimensioni più piccole.
L’architettura e il rapporto con le arti
Nel 1933 Antonio Maraini, artista a capo del Sindacato Nazionale Fascista di Belle Arti, scrive del “meraviglioso germogliare di palazzi, di piazze, di vie aperte alla vita, allo studio, al traffico della nazione” su cui si andava fondando l’arte fascista. L’architettura è considerata la più importante tra le arti per il suo ruolo nella rappresentazione del potere e nella costruzione di una nazione moderna. È infatti al centro delle esposizioni del regime, promossa da eventi come la Triennale di Milano e diffusa dalle riviste. L’imponente piano di edificazione voluto dal fascismo dà impulso all’economia investendo sia nel rinnovamento delle città storiche sia nella fondazione di nuovi borghi e centri urbani come Littoria, Sabaudia e altre località dell’Agro Pontino, recentemente bonificato. Vengono realizzate, in particolare, opere pubbliche che rivestono un ruolo fondamentale nel portare l’ideologia fascista nella vita privata dei cittadini: scuole, stazioni, palazzi di giustizia e delle poste, case del fascio, complessi sportivi come il Foro Mussolini. Con questi temi si misurano gli architetti dell’epoca, interpretando il linguaggio internazionale del Razionalismo oppure conciliando le forme essenziali dell’architettura moderna con una monumentalità che il regime impone con sempre maggiore insistenza dopo la metà degli anni Trenta, quando si vuole sottolineare il legame con la Roma imperiale. Tale grandiosità celebrativa raggiunge il suo apice nei progetti per l’Esposizione Universale del 1942, alla quale viene destinato un nuovo quartiere a sud di Roma. Dall’Archivio del ’900 del Mart proviene la maggior parte dei progetti esposti, che riguardano personaggi come Angiolo Mazzoni, funzionario del Ministero delle Comunicazioni, Adalberto Libera, Luigi Figini e Gino Pollini, Giuseppe Terragni.
Nuovi miti
L’ideologia fascista suggerisce agli artisti nuovi temi che contribuiscono alla narrazione di un paese di eroi, atleti, contadini. In particolare, il corpo prestante e allenato, teso al movimento e alla competizione, rappresenta l’espressione più nobile della vitalità di un popolo. Il culto del corpo affonda le sue radici nella tradizione classica e alcune delle moderne discipline sportive hanno origine nelle attività fisiche praticate nell’antica Roma. Durante il ventennio, lo sport è considerato uno dei valori della società italiana e possiamo vedere il riflesso di tale convinzione nel moltiplicarsi di opere d’arte che hanno come protagonisti nuotatori, calciatori, lottatori, corridori o pugilatori. L’esaltazione classica della figura umana è presente anche in altri soggetti cari al regime, come il lavoro e la famiglia. Coerentemente con l’obiettivo dell’incremento demografico, quest’ultima ha un ruolo centrale nella società fascista, la quale impone una visione tradizionale e antiborghese che privilegia le famiglie numerose e legate alla terra. Carlo Bonacina, ad esempio, dedica alcuni suoi dipinti e affreschi a La famiglia rurale, rappresentando in modo edificante l’ambiente contadino in cui viveva dal 1931, dopo il suo trasferimento in una valle del Trentino. Quella raffigurata dallo scultore Arrigo Minerbi è, invece, la famiglia delle origini, con i progenitori raccolti intorno al fuoco e circondati da una natura con la quale sono ancora perfettamente in armonia.
Il sistema delle arti
Il fascismo, contrariamente ad altre dittature, non impone una vera e propria “arte di stato”, bensì preferisce controllare e indirizzare la produzione artistica attraverso un capillare sistema di premi, sovvenzioni, esposizioni. Questo complesso sistema delle arti garantisce una certa pluralità di linguaggi e, almeno fino al 1938, consente alla maggior parte degli artisti di beneficiare del sostegno dato dal regime allo sviluppo delle arti. Dopo la promulgazione delle leggi razziali, invece, pittori, scultori e architetti di origine ebraica si vedono negare il diritto di progettare, insegnare, esporre e vendere le proprie opere. Nel corso del ventennio nascono nuove rassegne: la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma affiancano la Biennale di Venezia, mentre alla fine degli anni Trenta vengono istituiti due concorsi: il Premio Bergamo e il Premio Cremona. Nato per iniziativa del ministro Bottai, il Premio Bergamo vede la partecipazione di artisti dalla spiccata originalità espressiva come Guttuso, Birolli, Morlotti, Capogrossi, Rosai. Il Premio voluto dal gerarca Farinacci a Cremona, invece, vuole essere una chiara espressione dell’arte fascista. Con esso si manifesta l’ingerenza della politica sull’arte e la volontà di stringere un’alleanza con la Germania nazista, che nel 1941 ospiterà ad Hannover la mostra della sua terza edizione. Le opere di Cesare Maggi e Alfredo Catarsini sono un esempio di come gli artisti interpretano, con un linguaggio semplice e comprensibile, i soggetti propagandistici dettati dal regime: “Ascoltazione alla radio di un discorso del Duce” e “La battaglia del grano”.
La caduta della dittatura
Tra la fine degli anni Trenta e l’inizio degli anni Quaranta si scorgono i primi segni della crisi della dittatura. Dopo anni all’insegna della celebrazione, viene il tempo in cui alcuni artisti esprimono una critica dura e implacabile, fino a quel momento proibita. Per molti di loro, che avevano militato nelle fila del fascismo, è un drastico cambiamento di rotta. È il caso del “fascista selvaggio” Mino Maccari, che, nell’estate 1943, presenta nella sua casa a Cinquale la serie Dux: dipinti e disegni realizzati “con furia gioiosa e insieme tragica”. Da sempre irreverente osservatore del malcostume della società, illustratore caricaturista e poi direttore della rivista “Il Selvaggio”, egli dà vita a impietose parodie di un Duce grottesco e dissoluto. In questo periodo Mario Mafai, in fuga con la famiglia per sottrarsi alle leggi razziali, crea le sue Fantasie, un ciclo pittorico di allucinata violenza che denuncia la brutalità della guerra, come in passato fece Goya con i suoi Capricci. Ma la satira più irriverente e beffarda è quella del Gibbo disegnato da Tono Zancanaro, caricatura di un Duce violento e osceno che incarna i vizi e i mali dell’intera società. Inesorabilmente, con la fine del regime cadono i suoi simboli: le effigi del dittatore che erano state oggetto di culto vengono colpite dalla furia iconoclasta che accompagna il declino di ogni tirannia. Ce lo ricorda il busto in bronzo Dux di Adolfo Wildt, danneggiato dai partigiani nei giorni della Liberazione.
Museo Mart di Rovereto
Arte e Fascismo
dal 14 Aprile 2024 al 1 Settembre 2024
dal Martedì alla Domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 21.00- Lunedì Chiuso
Arte e Fascismo. Veduta della mostra. Ph Mart, Edoardo Meneghini, 2024