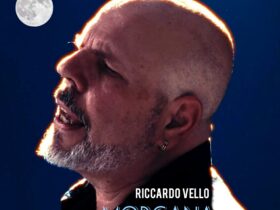Padre della Democrazia
Giovanni Cardone
Fino al 16 Giugno si potrà ammirare al Museo di Roma – Palazzo Braschi una mostra dedicata a Giacomo Matteotti – Vita e Morte di un Padre della Democrazia nel centenario della scomparsa,il percorso umano e politico del leader socialista a cura diMauro Canalicon la direzione e il coordinamento generale diAlessandro Nicosia. La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è organizzata e realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con l’Associazione culturale Costruire Cultura, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, sotto il patrocinio del Ministero della Cultura,con la presenza di Banca Ifis in qualità di main partner, con il contributo di Camera di Commercio di Roma e la partecipazione di Archivio Storico Luce, Rai Teche, Fondazione Pietro Nenni e AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. La mostra si pregia, inoltre, degli importanti prestiti di Fondazione Pietro Nenni, Archivio di Stato di Roma, Archivio Centrale dello Stato, Archivio Storico della Camera dei Deputati, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Accademia dei Concordi, Archivio Marco Steiner. Con la profonda dignità e l’alto senso civico dimostrati in un tragico momento della nostra storia, Matteotti è diventato l’archetipo dell’avversario tenace e incorruttibile del fascismo. Un esempio il suo, animato da un solido imperativo morale e da un forte slancio civile, che ancora interroga la vita politica e culturale del nostro Paese. In una mia ricerca storiografica e scientifica sulla figura di Giacomo Matteotti apro il mio saggio dicendo : Giacomo Matteotti nacque il 22 giugno 1885 a Fratta, un comune di 4000 abitanti del Polesine. I genitori erano Gerolamo (1839-1902) e Elisabetta Garzarolo (1851- 1931), di condizione modesta. Il padre veniva da Pejo, da una famiglia di calderai. Ebbero in esercizio un negozio di mercerie e di ferramenta: lavoratori tenaci e risparmiatori raggiunsero una media agiatezza investendo in terreni e fabbricati, il cui valore complessivo fu stimato nel 1925 pari a 1.203.826 lire. Visitandone la casa nell’estate del 1915, Aldo Parini la descriveva a un piano, “ammobigliata modestissimamente”, perché solo successivamente venne restaurata e abbellita di mobili appartenenti ad una villa gentilizia di Ficarolo. A piano terreno, a destra entrando, era una stanzetta arredata con tavoli e scaffali, e serviva a Matteotti da studio: “qui lavorava e riceveva visite”. Padrona della casa era la madre: “una vecchietta asciutta e energica dallo sguardo vivido” (Aldo Parini, La vita di Giacomo Matteotti, a cura di Marco Scavino e Valentino Zaghi, Rovigo, Minelliana 1998). Nell’Epistolario Giacomo ha lasciato un’immagine viva dei genitori: “la irrequietudine che la tien sempre in movimento, sempre in attività, dalla mattina alla sera, quasi mai un momento seduta. Non ha avuto quasi nessuna istruzione; ma conosce praticamente più di tanti uomini. È all’antica, ma nessuna cosa moderna la offende, e anzi aborre la femminilità indolente o sentimentale. In alcune cose le assomiglio; ma in altre assomiglio a mio padre: negli occhi, nel mento, e nella durezza del carattere, che lo aveva lasciato solo contro i molti, odiato e calunniato spesso, così che le mie facili vittorie di oggi mi sembrano la dovuta rivendicazione: è anche un debito che io assolvo, è una speranza nutrita fin da bambino, quando mi struggevo per non capire e per non potere”. È soprattutto in questa veste, di madre premurosa nei confronti del figlio impegnato, che ci viene restituita dalla documentazione a noi pervenuta. In quanto al padre si sa che Giacomo gli avrebbe dedicato quel grosso lavoro sulla Cassazione sul quale molto si impegnò, ma che mai avrebbe visto la luce. Giacomo ebbe due fratelli: Matteo (1876-1909), il maggiore, e Silvio, che si occupava delle aziende di famiglia. Entrambi morirono prematuramente per etisia.
Giacomo subì l’influenza decisiva di Matteo. Questi, compiuti gli studi universitari a Venezia e a Torino, aveva pubblicato il volume L’assicurazione contro la disoccupazione, per i tipi Bocca nel 1901. Consigliere comunale e provinciale, sindaco di Villamarzana, presidente della Società di mutuo soccorso di Fratta, Matteo contribuì non poco a indirizzare il fratello più giovane verso l’idealità e la militanza socialista, così come all’approccio rigoroso verso gli studi. Al saggio sulla Recidiva Giacomo premise la seguente dedica: “Alla memoria di Matteo, fratello mio e amico, che con occhio affettuoso protesse il crescere di queste pagine, e non poté vederne il compimento”; e Matteo chiamò il secondo nato. Resta da dire di Velia Titta, conosciuta all’Abetone nel 1912, moglie dal 1916. Dotata di notevole cultura, fu anche autrice di un romanzo, L’idolatra, che pubblicò nel 1920 presso l’editore Treves sotto lo pseudonimo di Andrea Rota. Fu la compagna di vita, punto di riferimento costante sul piano psicologico a cui comunicare speranze, preoccupazioni e ansie; insostituibile sostegno e completamento affettivo, attrice sensibile di un intimo dialogo di natura strettamente culturale. Il matrimonio fu allietato dalla nascita di tre figli, Giancarlo, Matteo e Isabella, tutti chiamati con curiosi vezzeggiativi (Chico, Bughi, Cialda). La corrispondenza con Velia a noi pervenuta ci restituisce un Matteotti passionale, amante della vita, dell’arte, del cinema, della musica, viaggiatore sempre curioso. Grazie all’agiatezza famigliare Giacomo fu nella condizione di compiere gli studi superiori al liceo ginnasio “Celio” di Rovigo. Si iscrisse quindi alla Facoltà di Giurisprudenza a Bologna, dove si laureò il 7 novembre 1907 discutendo in diritto e procedura penale la tesi Principi generali di Recidiva con Alessandro Stoppato, giurista eminente di orientamento clerico-moderato, deputato e senatore dal 1920. Si sa così che a Roma, dove risiedette dal 1906 al 1908 presso il dottore Curzio Casini, in Via Florida, ben lontano dall’ambito polesano, apprese “un po’ di inglese”, scambiò “qualche conversazione in tedesco”, non tralasciò la lettura di “qualche romanzo in francese”, e soprattutto curò gli studi di statistica. Ancora nel 1909 Stoppato ne assecondava l’intento di rivedere e pubblicare la tesi anche ai fini di un eventuale concorso per la libera docenza (“io sarò lieto di vederla salire”). Ne lesse il lavoro con attenzione riconoscendone “originalità d’indagine”, senza mai dismettere il ruolo di maestro (“ho segnato qualche punto”). Il libro uscì nel 1910 per i tipi Bocca con il titolo La recidiva e sottotitolo Saggio di revisione critica con dati statistici. Vi sosteneva l’urgenza della riforma del sistema penale e penitenziale e, in un capitolo conclusivo intitolato La liberazione dal carcere, caldeggiava come “ultimo grado di evoluzione il moderno principio della pena a tempo indeterminato”, cioè la determinazione giudiziaria di un massimo alto “insieme a larghissime facoltà di liberazione anticipata”, sia pure in subordine a controlli e garanzie. La militanza non sembrava conciliarsi con lo studio del diritto penale (“ci rimette”), specialmente dopo che nel 1910 fu eletto nel consiglio provinciale per il mandamento di Occhiobello. Ma l’attrazione degli studi penalistici rimase ugualmente viva. Nella compresenza di tali e tanti impulsi avvertiva una propria momentanea “debolezza”, che gli sembrava di ostacolo al buon fine dell’impegno, qualunque esso fosse. È un punto importante, questo, per comprendere il carattere di Matteotti: la tensione verso un obiettivo compiuto, che poi tale non avrebbe mai potuto essere del tutto, e in ciò l’impulso ad agire con tenacia e in prima persona. Riprese di buona lena gli studi solo sotto le armi, nel 1917-19, quando, a fronte delle incombenze materiali della vita di caserma, “proprio lo studio (restava) una delle maggiori consolazioni”. Occorre tenere presente, infatti, che nella seduta del 5 giugno 1916 in Consiglio provinciale aveva tenuto un duro discorso contro la guerra, pur aderendo al programma assistenziale annunciato, per cui era stato denunciato e processato per il reato di “grida sediziose” e “disfattismo”, e quindi condannato nel luglio 1916 dal pretore di Rovigo, con sentenza confermata dal Tribunale il 18 aprile 1917, finché la Cassazione non ne annullò il dispositivo senza rinvio con la motivazione dell’insindacabilità dei discorsi dei consiglieri provinciali nell’esercizio delle funzioni. Riformato per la causa della morte dei fratelli, fu sottoposto a revisione e ritenuto idoneo ai servizi sedentari. Seguì anche un corso allievi ufficiali a Torino, ma gli fu negata la nomina a ufficiale. Fu trasferito lontano dal fronte, a Messina, come “pervicace violento agitatore, capace di nuocere in ogni occasione agli interessi nazionali e pericoloso”, ma riuscì, protestando, a evitare il campo di concentramento dei pregiudicati per reati comuni. Nel marzo 1917 Matteotti aggiornava Stoppato sui nuovi studi orientati su problematiche processuali connesse al progetto del trattato sulla Cassazione a cui stava attendendo. L’interlocutore manifestò apprezzamento (“interessante”, “scritto veramente su basi scientifiche”) per l’articolo Nullità assoluta della sentenza penale, che apparve su “Rivista di Diritto e procedura penale”: Matteotti non era più solo il discepolo stimato, ma il “carissimo amico”. I riconoscimenti e gli incoraggiamenti pervenutigli nel corso degli anni da personalità politicamente distanti, perfino negli anni in cui ricopriva cariche politiche a livello nazionale, ne attestavano la precoce autorevolezza. In una delle ultime lettere, in data 10 maggio 1924, proprio al senatore Luigi Lucchini, conservatore, direttore de “La Rivista penale”, che gli confermava la stima personale e lo esortava a dedicarsi agli studi forse mosso anche da un proposito protettivo, Matteotti rispondeva di non vedere “purtroppo” il tempo nel quale ciò gli sarebbe stato possibile e con accenti nobili concludeva: “Non solo la convinzione, ma il dovere oggi mi comanda di restare al posto più pericoloso, per rivendicare quelli che sono, secondo me, i presupposti di qualsiasi civiltà e nazione moderna. Ma quando io potrò dedicare ancora qualche tempo agli studi prediletti, ricorderò sempre la profferta e l’atto cortese che dal Maestro mi sono venuti nei momenti più difficili”. Posto in licenza nel marzo 1919 e in congedo illimitato il 16 agosto 1919 Matteotti tornò immediatamente all’impegno politico, interrompendo, e questa volta definitivamente, gli studi penalistici, nonostante le aspirazioni accademiche. Lo stesso Matteotti ebbe a definirsi “un irregolare attratto per temperamento dalla politica”, la cui volontà però sarebbe stata sempre ed esclusivamente rivolta agli studi penali. In realtà Matteotti non abbandonò affatto l’attitudine allo studio, ma piuttosto la declinò a sostegno dell’attività politica e amministrativa, che improntò al rigore metodico e al ricorso costante alle fonti documentarie, collegando obiettivi e prefigurando esiti, al punto che è difficile negarne il debito contratto con la pratica del diritto penale e poi della disciplina finanziaria. Né deve sfuggire che nell’operare non trascurava mai la valutazione del quadro normativo nella logica dello Stato di diritto: ne esaminava i passaggi consentiti e perfino le forzature ammissibili per spiegarle ai compagni, ma senza finalità di rottura. E quando in occasione delle elezioni politiche del maggio 1921 cercò di raccogliere sistematicamente le testimonianze delle violenze e delle intimidazioni subite dai rappresentanti e dagli elettori della lista “falce, martello e libro” lo fece con il proposito di presentare alla Camera una denuncia circostanziata, documentata (“testimonianza in forma autentica, cioè controfirmata da un notaio oppure da un pretore”). Le testimonianze, suffragate anche da immagini fotografiche, ci consegnano un giovane magro, quasi smilzo, sia pure agile nei movimenti; ma in quella magrezza tutte tendevano a evidenziarne la grande energia interiore. A tale immagine molto contribuivano le sue capacità di sistemazione argomentativa, di critica e di sintesi, che tanto, accompagnandosi alla vis polemica, irritavano avversari e contraddittori. Portava puntuale attenzione ai problemi concreti rifuggendo dalla genericità e dalla improvvisazione. I compagni lo ricordavano “sobrio e senza vizi”, frugale, non amante delle sagre e dei banchetti. Risoluto sempre, fino all’arroganza, nella intransigente difesa delle proprie opinioni, diventava perfino scontroso, e, con gli avversari, acido nella polemica. In breve, era un compagno autorevole sì, ma anche temuto. Secondo la testimonianza del citato Parini, era diventato “un incubo” per gli amministratori: “Anche senza mandati precisi si era fatto controllore di pubbliche amministrazioni. Era l’incubo dei sindaci e dei segretari comunali per la sua diligenza di spulciatore di atti e di bilanci, per le critiche inesorabili e severissime. I bilanci comunali dovevano essere compilati con onestà in realistica corrispondenza con le possibilità finanziarie del Municipio. Economie fino all’osso, niente debiti”. Un riscontro è dato dalla stessa ammissione di Matteotti a Velia: “non mi accontentavo di preparare i bilanci o gli altri atti più importanti, ma in ogni piccola cosa avrei voluto intervenire e magari togliere la scopa di mano allo spazzino per insegnargli a pulire, poiché mi pareva che nessuno facesse bene abbastanza in confronto di quello che desideravo”. Anche in questo era l’insofferenza verso la retorica, il pregiudizio estremistico. Eugenio Florian attribuiva tale “severità” alla mentalità di giurista; Parini all’influenza del padre, un conservatore parsimonioso, oltre che alla frequentazione di Stoppani, “conservatore di stile e di razza, parlamentare fra i più rappresentativi e militante nella destra clericomoderata”. Certo, le relazioni famigliari, con il fratello maggiore Matteo innanzitutto e poi con la madre, ebbero un’influenza rilevante sul suo carattere. E resta da chiedersi se nelle circostanze ambientali ricordate in ciascun atto avvertisse l’impulso a dare testimonianza dell’autenticità della fede nell’ideale dichiarato, ad amici ed avversari, e, perché no?, anche a se stesso. Altri, come Filippo Turati, ne colsero un dato caratteriale portato ad un infaticabile attivismo (“bisogna far presto, non bisogna perdere tempo”), al punto tale da attribuire quell’attitudine ad una sorta di “gelosia del tempo che fugge irrevocabile”, che poi, nella rievocazione, assumeva perfino le sembianze del presagio di chi avvertiva di non averne molto a disposizione. Lo straordinario rigore di Matteotti, se era immediatamente percepibile, al punto da mettere a disagio, non era facilmente decifrabile. Dante Gallani, che gli fu compagno di partito, ma in una corrente avversa, ne assimilò la personalità ad “una strana interessante fusione di due elementi che sembrano antitetici: metodo riformistico e temperamento intransigente”. Una difficoltà interpretativa neppure superata da alcuni commentatori recenti. In realtà aveva la mentalità del riformatore. Pur appartenendo alla generazione successiva dei “grandi pionieri”, quella di Turati, Bissolati, Prampolini e Badaloni, ne condivideva l’attitudine pedagogica, ma chiamata alla prova del “fatto”, cioè del socialismo operante, e non solo idealizzato e ipotizzato, e dunque proiettata sul terreno difficile del proletariato rurale del Polesine. Non c’è da stupirsi, dunque, se, oltre ad una costante presenza fisica sul territorio con finalità di propaganda, formazione e organizzazione, tanto che nel 1914 aveva perfino acquistato un’automobile per muoversi più agevolmente, utilizzasse il mezzo tipico della comunicazione politica tra ’800 e ’900, e cioè la stampa periodica locale, nella fattispecie “La Lotta”, settimanale dei circoli e delle organizzazioni economiche, per lo più con articoli brevi e documentati, anche non firmati, oppure ricorresse al supporto di tipo manualistico, per spiegare ai quadri sindacali e ai nuovi amministratori o potenzialmente tali, i meccanismi normativi, e al fac-simile di regolamenti o di concordati, opportunamente chiosati punto per punto, da distribuire ai quadri sindacali. Anche in questo era l’insofferenza verso la retorica e il pregiudizio estremistico. Matteotti era un educatore. In anni di incipiente mobilitazione politica e sindacale di masse assai poco acculturate, al dirigente o al quadro erano richieste doti di oratore. Matteotti non lo era in senso tradizionale, perché la sua era “un’oratoria a base di fatti, fredda, precisa, tagliente”. Secondo Parini “amava sfrondare il suo dire di ogni fiore retorico, ma era convincente ed eloquentissimo. I suoi discorsi erano illuminati dalla citazione di documenti rivelatori e da numeri precisi. Era un ragionatore implacabile e si rivolgeva più alla mente che al cuore dell’uditore”. E sottolineava come non si sottraesse al contraddittorio, anzi!: “ironico, beffardo, sferzava, faceva fremere gli avversari. Raccoglieva le interruzioni e rispondeva agilissimo e pronto come uno schermitore espertissimo, confutando e tagliando netto la parola dell’interruttore”. La intensa attività amministrativa nei piccoli comuni del Polesine e la dimestichezza con le leghe ne affinò i moduli discorsivi, lontano da qualsiasi forma allusiva. Lo si evince in particolare nel dopoguerra dalla corrispondenza con Claudio Treves, pur maestro di giornalismo e di oratoria parlamentare, a cui senza alcun complesso di inferiorità non mancò di raccomandare maggiore efficacia comunicativa (“quei piastroni sulla riorganizzazione del Partito, sulla “Giustizia” non vanno. Essi devono servire di incitamento al lavoro, e allora occorrono molti titoli da leggersi facilmente e poco testo”). Per provenienza sociale e rilievo politico non poteva non suscitare un’avversione particolare negli avversari, che non mancavano di irridere al “socialista milionario”, e, ancor più, al “traditore”, con una singolare valenza eticoantropologica che rovesciava lo schema classista, ancorché condannato.

L’ambito locale era anche il luogo dei personalismi, delle vendette, dei rancori a lungo coltivati e tramandati. E non solo sul piano politico. Contro Matteotti quel motivo polemico, ora sottotraccia ora in modo palese o addirittura provocatorio fu ricorrente nella pubblicistica del tempo, e venne rilanciato con toni virulenti nel dopoguerra quando si accompagnò ad un secondo e non meno rilevante addebito, e cioè quello di un presunto massimalismo, che si voleva acceso e prepotente nel collegio, e tiepido a Roma, anche quando si tradusse in una posizione più conforme a quella di Turati. L’intento era evidente, quello cioè di screditare l’uomo come incoerente e dunque inaffidabile, e, più sottilmente, di presentarlo come agente provocatore nel Polesine, così da alimentare la singolare tesi che lo squadrismo fascista ne costituisse la risposta dura, ma coerente, anzi inevitabile. Del resto, l’organo fascista di quella provincia non si chiamava “Legittima difesa”? Isolandolo, lo si voleva esporre più facilmente alla rappresaglia. In questo contesto il 12 marzo 1921 Matteotti fu sequestrato, fatto oggetto di violenze e di minacce e infine bandito dal collegio. Le provocazioni e le aggressioni non cessarono mai. Un dato sinistro: l’ultima lettera è del 4 giugno 1924 indirizzata al “Corriere del Polesine”, che due giorni prima a caratteri di scatola gli aveva attribuito le seguenti parole: “noi ci sentiamo autorizzati a difenderci dai fascisti e dai carabinieri. E parleranno i medici e i becchini”, e dal medesimo prontamente smentite come parole “di schietto stile mussoliniano, ante e postbellico”, minacciando querela. L’assassinio di Matteotti ebbe anche una indubbia componente polesana, essendo maturato nell’entourage di Mussolini, dove spiccavano personaggi come Giovanni Marinelli e Aldo Finzi. Con ciò, non può non suscitare forti riserve il recente tentativo, in vero non riuscito, di riproporre la tesi della doppiezza matteottiana, che sotto la parvenza della novità, in realtà risulta adagiata sui modi e sui tempi della pubblicistica di allora. Ancora più superficiale, anzi maldestro è il tentativo di cogliere tale occasione per rilanciare l’immagine di un socialismo uniforme nella sua inconcludenza, sempre e comunque riassumibile all’interno del massimalismo classista. Il cursus honorum fu quello tipico del personale politico dell’Italia liberale. Dalla corrispondenza datata dal 27 settembre 1904 con Giulia e Ada Gherardi, che lo avevano ospitato da studente a Bologna, si ricavano interessanti informazioni sull’apprendistato politico. A quella data risultava già militante “da un po’ di tempo”, e l’impegno si traduceva nella creazione di un circolo o di una lega di contadini “con un’infinità di discussioni”, nonché nella collaborazione a “La Lotta”, foglio socialista del Polesine. L’azione di propaganda e di organizzazione si intensificava in occasione della campagna elettorale, come per le elezioni politiche dell’ottobre-novembre 1904 a fianco di Badaloni, riuscito eletto a Badia Polesine. Matteotti appoggiò Badaloni anche nelle elezioni politiche del 1909, e gli era ancora legato nell’aprile 1912 se raccomandava a Gino Piva di recensire sull’”Avanti” e sull’”Adriatico” il volumetto di A. Gherardini, Il Pensiero e l’opera di Nicola Badaloni, edito a Badia Polesine nel 1912. Ne prese le distanze solo dopo la scissione dei bissolatiani dal Partito socialista al congresso di Reggio Emilia del 1912, che produsse effetti laceranti anche nel Polesine prima nelle elezioni politiche del 1913 e poi di fronte alla guerra mondiale. La formazione politica di Matteotti ebbe un’accelerazione decisiva con l’elezione nel consiglio comunale di Fratta Polesine il 16 gennaio 1908, a cui fecero seguito quelle in altre amministrazioni comunali, da Villamarzana a Boara, dove fu sindaco, e ancora a Lendinara, Badia, Bellino. Eletto nel consiglio provinciale di Rovigo nel 1910, fu escluso per incompatibilità durante la guerra, ma vi tornò con le elezioni dell’autunno 1920. La molteplicità degli incarichi amministrativi era resa possibile dalla legge che riconosceva diritto elettorale attivo e passivo in tutti quei comuni dove un individuo possedesse proprietà e pagasse le imposte: legge che lo stesso Matteotti cercò di modificare nel dopoguerra. Fu Matteotti a datare dal 1913 il suo “spostamento” su Rovigo. Lo stesso Piva, diventato avversario dopo l’allontanamento dal partito socialista, lo descriveva allora in posizione di “combattimento e di dominazione”.
In effetti, la lettera inviata il 23 maggio 1913 a Manlio Bonaccioli, socialista di Reggio Emilia, riottoso ad accettare l’incarico di organizzatore nel Polesine che gli veniva proposto, ci dà l’idea del dirigente già sicuro dei propri mezzi e consapevole degli obiettivi, che erano quelli di “dare unità di indirizzo e di forza” alle leghe contadine e di preparare la campagna elettorale per le prossime elezioni a suffragio universale, per le quali ci si orientava verso la candidatura del reggiano Soglia nel collegio di Lendinara, “roccaforte del clericume”. Al di là delle motivazioni di circostanza per convincere il diffidente interlocutore, l’interesse è dato dalla indicazione dei requisiti dell’organizzatore/propagandista tipo: “cultura generale”, “saturazione di principi socialisti” e “attitudine della mente a presto apprendere e ritrovarsi”. In quanto al movimento polesano delle leghe, osservava Matteotti, è “semplicissimo” perché “la forma dei patti agrari è la stessa per tutta la provincia”, mentre l’unica struttura organizzativa qua e là funzionante era la cooperativa di lavoro. Insomma, ben poco a che vedere con la complessità della “formidabile organizzazione reggiana”, a cui in tutta evidenza andava la sua piena ammirazione. Alla vigilia della guerra Matteotti aveva conseguito ormai un’assoluta rilevanza nell’intera provincia. A fronte delle richieste che gli venivano rivolte da molteplici località perché si candidasse, si sentì in obbligo di declinare pubblicamente tali inviti dichiarando di poterlo e volerlo fare solo in uno o due luoghi, per la precisione laddove fosse “necessario rompere qualche vecchia crosta clericale o agraria”. Altrimenti, aggiungeva, non sarebbe stato nelle condizioni materiali di assolvere bene l’incarico ricevuto, ma soprattutto sarebbe stato “ridicolo che i lavoratori volessero continuare a restare sempre sotto tutela, sia pure di un loro compagno”. Ma non fu così. Rappresentando e patrocinando gli interessi dei comuni rurali Matteotti acquisì una consolidata autorevolezza in campo nazionale attraverso la collaborazione con la stampa, che dall’iniziale “Lotta” si andò progressivamente allargando a “Critica sociale”, all’“Avanti!”, a “La Giustizia”, al “Comune moderno”, a “La Nuova Antologia”, e soprattutto imponendosi nei congressi nazionali per la puntigliosità e la vis argomentativa che non indietreggiava neppure di fronte alle personalità più prestigiose del Partito. Il passaggio da dirigente a livello provinciale a personalità politica di livello nazionale fu in occasione del congresso nazionale di Ancona del Partito socialista dell’aprile 1914 e di quello dei comuni socialisti nel gennaio 1916, che portò alla costituzione di una Lega, con organo ufficiale “Il Comune moderno” di Giulio Casalini, del cui direttivo entrò subito a far parte. Ben presto diventò autorità indiscussa in materia tributaria e amministrativa. Il salto definitivo avvenne nel 1919, quando, sulla scia della grande avanzata del Partito socialista nelle prime elezioni con il sistema proporzionale e a scrutinio di lista (156 seggi), fu eletto deputato per il collegio di FerraraRovigo, poi confermato nel 1921 e 1924 per il collegio di Padova-Rovigo. In quanto tale partecipò assiduamente ai lavori del Gruppo parlamentare, del cui comitato direttivo fece parte per la componente riformista, in una costante azione concorde/discorde con la Direzione massimalista del Partito, uscita vincitrice nei congressi nazionali del dopoguerra negli echi della rivoluzione russa e nel clima esasperatamente rivendicativo del cosiddetto “biennio rosso”, che presupponeva la crisi irreversibile dello Stato liberale. Correlatore al congresso nazionale del Partito dell’ottobre 1921, costituì con Turati, Treves e Modigliani una sorta di gruppo dirigente della componente riformista, specialmente per l’attività parlamentare, fino ad assumere la carica di segretario del Partito socialista unitario nato il 4 ottobre 1922 dalla scissione dal Partito socialista ufficiale, massimalista. L’elezione a deputato non ne comportò affatto l’abbandono della precedente attività amministrativa locale, in Comune e in Provincia, nei limiti e finché lo squadrismo fascista glielo consentì dal marzo 1921, e anzi si può ben dire che da quell’esperienza continuò a trarre ispirazione, evidenziando un legame particolarmente profondo con il territorio. Anche sotto questo profilo cercare di cogliervi una dicotomia tra l’agire nel Polesine e a Roma è opera vana.
La collaborazione con Turati (e la Kuliscioff), a cui si accompagnava l’assidua frequentazione, e l’incarico di segretario del PSU, sia pure ricoperto per poco più di un anno e mezzo, contribuirono a segnalarlo come uno dei leader più competenti e promettenti del socialismo europeo. Per Matteotti lo spazio della politica aveva valenza positiva se e quando fosse espressione di scelte convinte, maturate, di esperienze vissute e di competenze acquisite, traducendosi in patrimonio collettivo. Il socialismo gli appariva l’espressione più matura e conseguente, in quanto fattore etico e pedagogico, perché poneva a premessa del cambiamento, anzi ne considerava natura intrinseca la spinta dal basso, la partecipazione consapevole, l’azione costante che sola avrebbe reso durature le conquiste; e perché affidava al proletariato, in quanto figlio della industrializzazione e della modernizzazione della società, il compito primario di accompagnare l’ingresso delle masse nella storia nel segno della giustizia sociale, della libertà individuale e collettiva, della solidarietà diffusa, dello sviluppo economico. In altre parole, lo identificava in una grande opera di civilizzazione, che collegava la militanza all’educazione e alla formazione del cittadino. Alla vigilia del Congresso di Bologna del 1919, scriveva su “La Lotta”: “Il socialismo esige non soltanto la lotta e la vittoria sopra la classe avversaria, ma anche e soprattutto la lotta e la vittoria sopra noi stessi, sopra i lavoratori medesimi, per toglierne i sentimenti egoistici e prepararli al socialismo”. Insomma, “il più” era riuscire a “costruire il socialismo dentro di noi”. Allora c’era la percezione di far parte di un moto generale, anzi di concorrere ad una fase storica nuova, di progresso sociale, di sviluppo economico e di modernizzazione delle istituzioni, a beneficio dell’intera umanità per impulso del protagonismo dell’universo lavorativo, il quale, per potersi dispiegare pienamente, presupponeva l’opera di attori provenienti dalle file della borghesia colta. Come, per l’appunto, era Matteotti. A presupposto dell’agire politico egli poneva la libertà dell’uomo, come individuo e come membro di una comunità o di una classe, limitata solo dall’osservanza dei diritti della minoranza. Al fondo c’era il rispetto della persona, in relazione ad una concezione etica che lo rendeva istintivamente diffidente verso qualsiasi forma di imposizione e di sopraffazione. In un contraddittorio al Teatro sociale di Rovigo il 23 settembre 1913 in piena campagna elettorale, rimproverò all’oratore, Guido Podrecca, direttore dell’“Asino”, non solo di sacrificare sull’altare dell’anticlericalismo qualsiasi altro obiettivo, come quello del contenimento delle spese militari e dell’espansionismo coloniale, ma anche e soprattutto di impostare da un punto di vista giacobino, cioè “con fatti e leggi restrittive della libertà d’azione dei clericali”, il problema della laicità, che pure esisteva come prodotto della modernizzazione. “Ebbene noi – concludeva – a questa specie di anticlericalismo siamo contrari; noi siamo per la più intera ed assoluta libertà per tutti; e non solo per ragioni ideali, ma anche per ragioni di interesse, avendo noi bisogno di questa stessa libertà per diffondere la propaganda socialista. Invece il vostro giacobinismo persecutore è la giustificazione migliore del settarismo e del dogmatismo clericale, che torturava e perseguitava. Voi siete i veri fratelli siamesi dei clericali!” (La purezza del socialismo rivendicata, “La Lotta”, 27 settembre 1913). Analogo orientamento Matteotti tenne al congresso nazionale del Partito socialista ad Ancona nell’aprile 1914, il primo organizzato dalla corrente intransigente-rivoluzionaria che aveva conquistato la direzione al precedente congresso di Reggio Emilia nel 1912 nel clima antigiolittiano e anticolonialista innestato dalla guerra contro l’Impero Ottomano per il possesso della Libia. Tra gli argomenti in discussione era il rapporto con la massoneria, su cui l’assemblea infine votò un odg Zibordi-Mussolini per l’incompatibilità con il socialismo, fino a prefigurare l’espulsione di coloro che vi fossero iscritti. Ebbene Matteotti, che per la circostanza presentò un proprio odg, condivideva sì la tesi della incompatibilità, con la motivazione che l’“azione difensiva del diritto individuale contro la reazione” dovesse essere affidata “agli organismi di classe e al movimento professionale” piuttosto che all’azione anticlericale; che nella massoneria fosse l’incubazione “di mescolanze e connubi politici dannosi alla chiara fisonomia del partito e contrari ai suoi supremi interessi nell’ora presente”, e deleteri alla formazione dei giovani; ma si limitava ad “invitare” i compagni “anziani” a rinunciare all’eventuale adesione e a circoscrivere la proibizione alle nuove iscrizioni. La differenza non era di poco conto, perché, come affermava Matteotti, il procedimento dell’espulsione avrebbe aperto in ogni sezione “un processo inquisitorio”, e ciò avrebbe contrastato con l’immagine del partito come libera palestra di idee e comunità di uomini liberi . Matteotti fu un riformista perché pensava e operava per l’allargamento della cittadinanza politica e sociale, senza dogmatismi, con un disegno progressivo e graduale, che non contrastava con la tenacia e il rigore, ma al contrario li presupponeva. Il debito nutrito nei confronti del marxismo aveva ben poco di dogmatico, e nulla di fatalistico. Per lui il socialismo era meta ideale, ma anche militanza, prassi concreta perché esso non costituiva un bene assoluto in un sistema chiuso e predefinito, bensì un ideale che si concretizzava e si definiva nel farsi. Nelle polemiche con l’intransigentismo-rivoluzionario e poi con il massimalismo e il comunismo, osservava che la realtà era fatta di paradossi e di contraddizioni e pertanto chi si proponesse di trasformarla avrebbe dovuto “applicarsi ad essa in tutte le sue sinuosità, risalirla per tutti i suoi meandri”. In alternativa al “puritanesimo infecondo nell’intransigenza negativa, intorno al sogno dell’urto miracoloso che scrolla il mondo borghese”, poneva la ricostruzione evolutiva della società, pur nella consapevolezza che “questo metodo penetrativo” fatto di fermezza e di interesse fondamentale e di pieghevolezze e duttilità esteriori, di transigenze formali e di intransigenza sostanziale richiedeva nei dirigenti, nei quadri e nelle truppe maturità, onestà, spregiudicatezza, agilità e moralità, che erano “rarissime a trovarsi insieme”. Ciò implicava, infatti, “un lavoro enorme, molteplice, vario: propaganda e organizzazione, revisione teorica e azione pratica, studio ed esperimento, preparazione tecnica per le riforme legislative, preparazione per l’opera amministrativa nei Comuni; facoltà di comprendere l’ideale e il reale, l’immediato e il lontano: da discernere il lecito e l’illecito; di conoscere l’anima popolare, di non titillarla demagogicamente, ma non di prenderla di fronte ed allontanarla da sé con atteggiamenti ad essa inaccessibili; di accostarla e piegarla, e educarla ad essere astuta, ma insieme diritta, pratica e idealistica, socialista insomma: e non dovrebbe esserci bisogno di aggiungere altro!” (Come intendiamo il riformismo, “La Lotta”, 26 agosto 1911). Il riformismo di Matteotti, anche nelle manifestazioni più radicalizzate, restava ancorato ad un fondamento pragmatico, attento cioè all’efficacia delle azioni nel presente e in futuro. Una chiara riprova era data dal modo in cui considerava il nodo delle alleanze, cioè dei rapporti con i cosiddetti partiti affini e con la borghesia liberale, che per il movimento socialista del primo ‘900, solo da poco forte di una propria autonomia e identità, aveva una valenza tutta particolare, fino ad investire la stessa posizione da assumere nelle assemblee elettive verso il Governo. Il ministerialismo e il ministeriabilismo, cioè l’appoggio esterno e/o la partecipazione ai governi borghesi, fu il tema classico che attraversò tutta la vicenda socialista sul piano internazionale, e che trovò soluzione solo dopo la prima guerra mondiale, ad eccezione dell’Italia. Al congresso provinciale socialista di Lendinara del 29 settembre 1912 Matteotti sostenne sì la tesi della intransigenza, ma per ragioni contingenti, negandone la valenza generalizzata: “io opino infatti che noi sul nostro cammino domani potremo trovarci accanto a qualsiasi partito; e come i socialisti di Germania nel votare contro la legge giacobina sui gesuiti si sono trovati insieme con i clericali, così questo potrebbe avvenire anche a noi”. Respingendo la pregiudiziale “anticollaborazionista” sostenne che la dogmatica lettura del marxismo, secondo la quale ogni governo fosse da ritenersi comitato di affari della borghesia, avrebbe precluso la possibilità di adottare le tattiche più consone. A tale assunto rimase sempre fedele. A Matteotti non sfuggiva neppure il nodo dello spazio politico, e in particolare delle dimensioni idonee a favorire o meno il processo riformatore. Nella sua idea di socialismo il problema si riproponeva sotto due profili. La logica della socializzazione era alternativa a quella capitalistica, ma era pur sempre ad essa correlata: la grande azienda, l’ampiezza del mercato e l’economia di scala, la mobilità degli uomini e dei beni, lo sviluppo tecnologico con l’industrializzazione e l’espansione dei trasporti, la città, l’istruzione diffusa e perfino il godimento di un maggior tempo libero costituivano requisiti irrinunciabili dello sviluppo, senza il quale sarebbe stato inconcepibile anche il processo di emancipazione. Ciò induceva a guardare con sospetto al piccolo, al quale si poteva concedere credito solo se e in quanto tramite l’associazione riacquistasse quella più ampia dimensione che lo avrebbe reso idoneo a cogliere le occasioni offerte dallo sviluppo tecnologico e le sollecitazioni del mercato. Perfino quando parlava della “campagna senza fine del Polesine”, Matteotti si sforzava di considerarla come una sorta di “grande centro” o “città”, purché pervenisse all’unione dei comuni su scala provinciale. Al tempo stesso riteneva essenziale conferire allo spazio politico una fisicità, possibilmente densa e mobile, come poteva esserlo una rete infrastrutturale che innervasse il sistema locale superando la frammentazione e l’isolamento, e con ciò la condanna all’inefficienza. Nel Consiglio provinciale di Rovigo, Matteotti dedicò attenzione al problema delle tranvie a vapore; alla costituzione di una rete intercomunale telefonica, che inizialmente abbracciasse 14 comuni; alla costruzione di un nuovo ponte sull’Adige; alla manutenzione delle strade provinciali. A proposito della rete tranviaria si diceva certo che avrebbe incrementato “la somma dei desideri dei lavoratori” e “migliorata la qualità dei piaceri ricercati (viaggi, istruzione generale e professionale) staccandoli così dall’antica e dai clericali lodata facile contentabilità delle classi povere”. Insomma, c’era la fiducia che la mobilità, traguardo storicamente inarrivabile per i lavoratori dei campi se non per emigrare, costituisse di per sé un fattore di emancipazione culturale, tale da contrastare l’atavico e passivo attaccamento viscerale al pezzo di terra coltivata. D’altra parte la prospettiva gradualista e partecipata del processo riformatore induceva alla sperimentazione, alla costruzione per piccoli passi, come se vi si consumasse una partita decisiva. Da lì passava lo stesso disegno riformatore della “grande città” polesana, che non poteva prescindere dall’impulso dell’organizzazione dei lavoratori nel mentre imparavano a gestire la cosa pubblica, dai nuovi organismi economici e sociali improntati alla solidarietà, e dalla riqualificazione degli enti territoriali. Al loro successo era subordinato il superamento della dicotomia piccolo/grande, alto/basso, locale/nazionale. Semplificando possiamo dire che i nuclei di base della nuova società erano il Comune, la scuola, la cooperativa, la lega. Gli interessi e i campi di intervento di Matteotti riguardarono l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa; il dimensionamento, l’uniformità formale e l’autonomia dell’ente territoriale; la finanza locale; la rappresentanza; i nuovi diritti sociali; gli istituti dell’economia sociale. Il 26 novembre 1919 Matteotti entrava alla Camera, dove fu protagonista di un’attività straordinaria. Fece parte della Giunta generale del bilancio e di quella per l’esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali. Quando, nelle tornate del 24-26 luglio 1920 e 6 agosto 1920, la Camera modificò il regolamento istituendo le Commissioni permanenti, Matteotti entrò a far parte della terza, Finanze e Tesoro, dove fu confermato anche nella XXVI legislatura. Infine fu segretario della Commissione parlamentare per la riforma della burocrazia i cui lavori iniziarono il 28 settembre 1921. Gli argomenti oggetto dei suoi interventi furono molteplici, e in alcuni momenti la sua presenza alla Camera assunse un ritmo addirittura incalzante. E così furono sempre puntuali e numerosi gli interventi polemici, le interruzioni date e ricevute, alle quali non si sottraeva, perfezionando quell’esperienza del contraddittorio con gli avversari nel quale eccelleva senza mai scomporsi e mantenendo piena lucidità. Prese la parola per la prima volta il 21 dicembre 1919. Si discuteva della proroga dell’esercizio provvisorio 1919- 20, e Matteotti illustrò un odg di condanna della politica economica del governo Nitti, colpevole di non riparare la falla aperta nel bilancio italiano dalle spese di guerra, senza colpire gli indebiti arricchimenti. Soprattutto ne criticava la mancata imposizione di un’imposta sul capitale, cosicché riteneva che gli oneri sarebbero ricaduti sulle masse lavoratrici. Analoga denuncia di tale “politica di classe della borghesia” pronunciò nel discorso del 28 maggio 1920, sulle comunicazioni del secondo governo Nitti formatosi dopo la crisi provocata dai popolari che restarono fuori dal governo, così come su quelle dei Governi successivi. Sostenendo tale linea, a favore cioè di un Governo che solo operasse a tutela e incremento della ricchezza nazionale al di sopra della speculazione privata, Matteotti riteneva, come disse nella seduta del 21 luglio 1921, che i socialisti si rendevano “i veri rappresentanti della Nazione”. Un commentatore autorevole come Achille Loria ebbe a definire la relazione di Matteotti del 10 agosto 1922 sullo stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 1922-3 documento di “sapienza legislativa”. Essendo ormai diventato autorità indiscussa sui problemi economici e di bilancio fu quasi sempre designato a oratore ufficiale dal Gruppo parlamentare socialista, del cui direttivo entrò a far parte. Oltre agli interventi sul bilancio dello Stato, si segnalò per quelli a tutela delle prerogative parlamentari o addirittura delle norme statutarie. In particolare Matteotti non accettava che al parlamento fosse impedito il controllo della circolazione monetaria e di una politica economica che tendeva a coprire con mezzi straordinari i disavanzi dei bilanci ordinari, occultando di fatto il debito pubblico il cui ammontare sui dati ufficiali al 31 marzo 1920 era valutabile in circa 83 miliardi di lire, ma che egli ricalcolava per 93 miliardi, a cui poi ne aggiungeva un’altra trentina per la differenza dei cambi (seduta del 27 giugno 1920). Né si può tacere qui la ribellione di fronte alle tendenze autoritarie del Governo Mussolini, specialmente dopo la legge Acerbo nella quale coglieva la volontà di schiacciare le minoranze, fatte passare come ”antinazionali”. Da ultimo, fu la denuncia al ministro delle poste e telegrafi, Colonna di Cesarò, per la sistematica violazione del segreto postale, invocando “il rispetto delle leggi”, quelle “prima dell’era nuova”. Nella stessa linea è l’esposto rivolto il 29 ottobre 1923 ad Enrico De Nicola, presidente della Camera dal giugno 1920, sulla difficoltà perdurante o sull’impossibilità di svolgere la funzione di controllo su importanti leggi di spesa. Come si è detto, portò nell’attività parlamentare tutta l’esperienza maturata sul campo sui tributi locali, e in proposito presentò un ddl di riordino organico. In parallelo si adoperò per la riforma della legge elettorale amministrativa, che tuttavia rimase ferma al Senato. Dove dette prova eccelsa del senso dello Stato, fu sull’ordine pubblico. Tra i primi a richiamare l’attenzione del Parlamento sul dilagare delle violenze fasciste nel Polesine e in Emilia e Romagna, denunciò precocemente il filofascismo del ceto liberale in chiave antisocialista e individuò la ragione d’essere dello squadrismo nell’aspirazione degli agrari a non permettere che i loro profitti fossero contenuti dall’azione sindacale delle leghe, e ne denunciò la strategia militare squadrista finalizzata all’abbattimento dell’”organizzazione dei lavoratori”. Documentando il favore concesso in loco dalle autorità, arrivò a accusare Il Governo Giolitti di complicità, ammonendo che, così continuando, i lavoratori avrebbero perso ogni fiducia nello Stato democratico: “Per conto nostro, proclamò, mai come in questo momento abbiamo sentito che difendiamo insieme la causa del socialismo, la causa del nostro Paese e quella della civiltà”. Dopo la replica di Giolitti la mozione socialista, che Vincenzo Vacirca e altri 28 deputati avevano presentato contro il Governo sulla politica interna, fu respinta dalla Camera il 13 febbraio 1921. Tornò a interrogare il Governo sulle violenze nel Polesine Il 10 e il 17 marzo 1921, e ancora Il 27 luglio 1921, un crescendo accorato e ammonitore. Deplorava allora le “dimissioni estorte con la violenza alle amministrazioni comunali nella provincia di Rovigo e lo scioglimento forzato del Consiglio provinciale di Rovigo” mentre l’autorità si dimostrava incapace di garantire la libertà delle riunioni, con ciò vanificando ogni “possibilità di vita”. Di qui l’appello al Governo: “Noi domandiamo di restituire alla nostre terre la libertà”. A cui faceva seguire il monito: “perché non ci si convinca che dalla legge e dal Governo non c’è da aspettarsi, ma che vale soltanto la violenza bestiale”. Un tema, questo, che riprenderà e svilupperà in seguito. Il 2 dicembre 1921 pronunciò il secondo grande discorso contro il fascismo. Il Gruppo parlamentare socialista aveva presentato una nuova mozione di censura sulla gestione dell’ordine pubblico. Nella circostanza le interruzioni furono tali che il presidente De Nicola fu costretto a sospendere la seduta. La parole di Matteotti suonarono gravi e solenni: continuava “la violenza inesorabilmente voluta e organizzata, (perché) continua(va) la complicità del Governo, e nessuno sorge(va) in questa Camera a comprendere l’immensa tragedia del popolo e dell’animo nostro, noi sentiamo che questo è anche l’ultimo sforzo , ogni legame civile sarebbe irreparabilmente disciolto”. La successiva seduta del 12 dicembre 1921 sulle mozioni socialiste a seguito del fallito tentativo del “patto di pacificazione” e sulle spedizioni punitive risultò tesissima. Lo stesso avvenne il 20 maggio e il 13 giugno 1922. Ancora il 20 maggio 1922, al Governo Facta che si era formato il 15 marzo 1922, Matteotti tornò a rivolgere un’interrogazione sull’occupazione militare di Rovigo da parte di 10000 fascisti, facendo presente che gli imputati di precedenti omicidi politici erano stati assolti da giudici compiacenti o impauriti sotto la minaccia delle squadre fasciste. In una rievocazione alla Camera Giuliano Vassalli concluse ricordando il “deputato esemplare per diligenza, per competenza, per impegno, per combattività, per fede indomita nella libertà e nella giustizia. Un deputato che ha onorato di fronte al mondo l’istituzione parlamentare e l’Italia. Credo doveroso aggiungere una chiosa: ciò lo fu a maggior ragione perché in un Parlamento che a grande maggioranza si dispose a dare la fiducia a Mussolini, incaricato dal Re di formare un governo di coalizione dopo la marcia su Roma del 28 ottobre 1922. Gli interventi pubblici e, soprattutto, la corrispondenza evidenziano l’attenzione con cui, con crescente preoccupazione, Matteotti seguiva il progressivo deteriorarsi degli equilibri politici. Il rapido succedersi dei governi Nitti, Giolitti, Bonomi e Facta, nonostante il rinvio di alcuni di essi al Parlamento, evidenziava la mancanza di una solida maggioranza parlamentare, ma ancor più il vuoto di potere nel quale stava avvitandosi la crisi dello Stato liberale. Colse le implicazioni derivanti dagli esiti delle elezioni politiche anticipate del 15 maggio 1921, non tanto per il relativo arretramento delle liste socialiste, quanto per il fallimento del progetto di Giovanni Giolitti, presidente del consiglio, che si proponeva di rilanciare la sua fragile maggioranza, ormai indebolita, attraverso la presentazione di un listone nazionale comprensivo anche di candidati fascisti e nazionalisti. Il voto indebolì ulteriormente lo schieramento liberale per il successo dei popolari, cosicché lo stesso Giolitti fu costretto a rassegnare le dimissioni. Non solo: i fascisti, che portarono in Parlamento 35 deputati (a cui si aggiungevano 10 nazionalisti), lungi dall’essere “addomesticati”, si trovarono pienamente legittimati, e dunque trassero ulteriore forza nella campagna “militare” contro i socialisti. In questo contesto Matteotti sostenne l’esigenza che il Gruppo parlamentare socialista dovesse essere “pronto a fare tutto ciò che era parlamentarmente utile al proletariato”, libero da condizionamenti della Direzione massimalista, pur con un generico impegno a svolgere comunque un’azione unitaria. Al tempo stesso preparò il ricorso alla Giunta per le elezioni per l’invalidazione delle elezioni in provincia di Rovigo, che poi portò all’annullamento dell’elezione del fascista Piccinato. Il tentativo dei socialisti riformisti di condizionare il Governo per una più efficace politica interna che contenesse il dilagante fenomeno squadristico si andò chiaramente delineando In occasione del discorso programmatico del Governo Bonomi del 18 luglio 1921, immediatamente successivo a gravi episodi di violenza squadristica verificatisi il 10 e 12 luglio. Scrisse a Velia: “Noi cercheremo di non dar troppo contro il Ministero, per averlo almeno un po’ favorevole, o che almeno diventi meno ingiustamente complice dei fasci. Ormai anche gli altri pare che la capiscano”. E il 25 luglio 1921: “Il ministero ha una grande votazione. Noi abbiamo votato contro; ma per le nostre aspettative avremmo volentieri votato a favore o per lo meno astenuti”. Ancora al Congresso nazionale socialista di Milano del 10-15 ottobre 1921 fece un intervento per superare l’ “equivoco inerte” del Partito al fine di contrastare il fascismo con ogni mezzo, ma inutilmente perché la maggioranza massimalista, che si trovava a contrastare a sinistra la concorrenza del neocostituito Partito comunista d’Italia di Amedeo Bordiga e Antonio Gramsci attestatosi su posizioni ancor più estremistiche e velleitarie, rinnovò l’esclusione di ogni collaborazione parlamentare in attesa che la crisi dello Stato liberale precipitasse. Per Matteotti la disputa con gli “estremissimi” non verteva più tanto sulla collaborazione parlamentare o meno, quanto sul “metodo per la conquista del potere politico”, essendo la posizione dei riformisti attestata senza incertezza sul principio della “conquista legale graduale”, e quella dei massimalisti (“proselitismo, propaganda avveniristica, pressione continua, opera di critica”) prigioniera di un equivoco o un errore, essendo di fatto prossima alla prospettiva comunista della “formazione di quadri di forza che con un assalto violento si impadroniscano del potere, mediante una dittatura”. La distanza dal mito della rivoluzione di Lenin non poteva essere maggiore. Ritenendo Bonomi reo di “tollerare” o addirittura fiancheggiare “coi suoi organi esecutivi e giudiziari l’aperta organizzazione di bande armate”, il Gruppo parlamentare cercò di affrettarne la caduta nel novembre 1921. Matteotti scriveva alla moglie: “La Camera è in ebollizione per mantenere il ministero o per la crisi. Credo che anche per il nostro partito si svolgano giorni difficili. Tutta l’organizzazione può perire sotto la violenza dei criminali; e nello spirito anche dei più mansueti si fa strada il concetto della necessità di resistere con la forza. I pochi mesi per venire sono decisivi. Molti ne hanno l’incoscienza”. Il riferimento era chiaramente rivolto ai comportamenti degli organi del Partito, che ancora nel gennaio 1922 si espressero contro ogni appoggio a governi borghesi. Le attese dimissioni, rilasciate il 2 febbraio 1922 non portarono comunque alla attesa svolta parlamentare, per la quale si riponeva fiducia nel presidente della Camera De Nicola. Questi rinunciò all’incarico il 7 febbraio 1922 e Matteotti ne attribuì la responsabilità a Giolitti, anche perché il testimone passò dopo a Facta, giolittiano di stretta osservanza. Di fronte ad una nuova ondata di violenze fasciste, il 1 giugno 1922 la maggioranza del Gruppo parlamentare si dichiarò finalmente disponibile ad “appoggiare un governo che assicurasse il ripristino delle libertà pubbliche e della legge”; e a fronte del confermato intransigentismo del Consiglio nazionale del Partito il 14 giugno rivendicò finalmente piena libertà d’azione, nominando il 16 giugno un nuovo direttorio, chiamando a farvi parte anche Turati, Treves e Matteotti, in precedenza dimissionari. L’evidenza della drammaticità della crisi emerse tutta nella seduta parlamentare del 15 luglio 1922: “Giornata grossa, tumulti – scrisse alla moglie – la crisi deve esser raggiunta ad ogni costo, e devono essere allontanati questi imbecilli o complici”. Non celando i suoi timori: “Pare che tutti abbiano piacere della sconfitta in pieno del socialismo; eppure non ne rimangono sconfitti i difetti, ma la civiltà medesima”. In effetti la crisi del Governo Facta precipitò il 19 luglio, ma non contribuì a aprire le strade sperate. Restava solo vivissima la percezione della gravità del passaggio: “La situazione – Matteotti scriveva alla moglie – è all’estremo della gravità e dell’aspettativa. Qui è l’arco teso all’estremo. Grande è la speranza, ma tutto dipende dai più grandi e dai minimi fatti: Il pericolo è enorme, ma tutto può ancora essere salvato”. Il 22 luglio 1922 il direttorio del Gruppo avanzò l’auspicio di “un Governo non più mancipio della Destra sedicente liberale e del fascismo agrario”, dichiarandosi disponibile a “concorrere” a tale obiettivo. Luigi Sturzo ricordò: “Sopravvenne il voto alla Camera contro il gabinetto Facta e fu aperta la crisi. Tornarono Turati e Matteotti da me”; “i popolari avevano trattato, a mezzo mio, la collaborazione con Turati, Matteotti e Treves, venuti a casa mia nel luglio di quell’anno”. Ma tali tentativi, pur promettenti, non approdarono a nulla, mentre di contro, dopo il fallimento dello sciopero generale legalitario dell’camera indetto dalla CGdL, la crisi interna al Partito precipitò fino alla scissione consumata al Congresso di Roma il 4 ottobre 1922, alla vigilia della marcia su Roma. Nasceva il Partito socialista unitario, di cui Matteotti fu eletto segretario. Matteotti percepì tra i primi la drammaticità della svolta che si andava compiendo nell’ottobre 1922, convinto che l’avvitamento della crisi sarebbe sboccato nella dittatura, termine che usò precocemente e senza incertezza. Di fronte alla crisi del Governo Facta e alla marcia su Roma la posizione sembrava quella dello spettatore passivo, a testimonianza dell’inanità politica dei socialisti così come delle altre forze di opposizione (“del resto tutto si è svolto fuori di ogni azione o possibilità di azione”). Nella lettera a Treves dell’ottobre 1922 segnalava la natura “extraparlamentare della crisi”, preannunciando le dimissioni di Facta, e indicava la parvenza di “un movimento per Orlando” (“ma non è ancora chiaro”), ben presto abortito. In una successiva a Turati osservava: “Se il Governo o il Re avessero voluto resistere, sarebbe stato facilissimo. Si dice che il Re dapprima avesse consentito allo Stato d’assedio, e solo poi abbia pensato altrimenti. Si dice che i comandi d’esercito abbiano risposto che essi erano pronti a resistere solo se il Governo voleva fare sul serio.

Ciò che naturalmente Facta non voleva”. Dava conto dell’ipotesi di un Ministero Salandra e delle voci di un dissidio tra i liberal-nazionali e i fascisti, del coinvolgimento presunto di Baldesi, dirigente della Cgdl. E a proposito della marcia su Roma: “molti studi distrutti, una ventina di morti, indifferenza pubblica. Viltà generale alla Camera: tranne il vecchio Cocco. Tutti pronti a entrare nel Ministero con lo strazio nel cuore!”, e “l’aria di non sicurezza, perché tutto è affidato all’arbitrio”, nonostante che la grande maggioranza delle squadre è partita. Come segretario del Partito socialista unitario, Matteotti diradò l’impegno parlamentare occupandosi del partito da una stanzina in Piazza di Spagna, dove era costretta la direzione non riuscendo a trovare domicilio altrove. Il locale era sprovvisto di riscaldamento, e Matteotti vi prese a lavorare con il soprabito sulle spalle, con l’impegno di sempre. Alla nascita del Governo Mussolini, nato pochi giorni dopo la scissione dal PSI massimalista, il neo segretario si trovò di fronte a due opzioni: l’aperta opposizione o, per vivere “vellutare la nostra opposizione, considerare il fatto rivoluzionario esclusivamente dannoso alla democrazia e portarci sui problemi concreti”. Al socialista teramano Giuseppe De Dominicis in data 4 novembre 1922 ammetteva che era “probabile che permanga ancora quello stato di cose in virtù delle quali ci siano rese impossibili le nostre attività di organizzazione e di propaganda”, ma che era necessario continuare “a lavorare com’era possibile, riunendo le sezioni”, senza “atteggiamenti che possono dare al nostro lavoro un carattere cospiratorio” e soprattutto assicurando la pubblicazione del giornale poiché in quel momento la stampa era il solo mezzo di propaganda utile. La lotta si riduceva alla pura “difesa delle posizioni”. E poi c’era il disorientamento, del resto comune alle altre forze politiche, mentre la debole opposizione parlamentare rischiava di sfaldarsi. Per i socialisti unitari ciò era ancora più grave per le ripercussioni sull’universo organizzativo, sindacale e cooperativo. Nella lettera a Treves del 9 novembre 1922 Matteotti già parlava “di tutto un movimento di circuizione, esercitato su molti dei nostri uomini, dagli emissari del dittatore”, convinto com’era che si volesse indurre il Partito “a piegare, a consentire, cioè a permettere il più comodo sviluppo della Dittatura”. Si confermava “l’opera perfida di assalto a tutto l’ultimo rimasuglio di ciò che possediamo, non più con la violenza certamente, ma con la semplice minaccia del terrore, con la corruzione degli elementi più resistenti, con la prigionia morale di chiunque dei nostri sarebbe capace di agire”. Matteotti era convinto che, anche a prendere per buone, ma non lo erano, “le inevitabili tendenze demagogiche (cosiddette di sinistra) del Governo Mussolini”, la migliore tattica restava comunque “la più ferma e dignitosa resistenza”. A Treves, che dirigeva a Milano “La Giustizia”, organo del Partito, che sembrava individuare i più impellenti problemi del nuovo Governo nell’ordine pubblico e nel pareggio di bilancio, opponeva che sarebbe stato meglio parlare semplicemente di “libertà” e di “vita, cioè del pareggio nella economia dei lavoratori”. A Turati scriveva il 18 dicembre 1922: “Le cose interne sembrano accomodate, e le corporazioni divengono fasciste, mentre le milizie che divengono del Presidente del Consiglio dovrebbero aprire gli occhi a tutti”. Nello stesso Gruppo parlamentare serpeggiava verso il Governo una linea attendista, che faceva capo a Enrico Ferri (“leale attesa”), e con qualche difficoltà Matteotti riuscì a imporre la propria in una riunione del 6 febbraio 1923, favorevole ad un’opposizione decisa, e se ne lamentava: in un “momento grave come questo, non fanno che danneggiare proprio l’unica cosa che ci resta, il nostro bagaglio ideale”. Ancora più grave si presentava “la crisi di persone per la particolare situazione in cui ci troviamo”: l’accenno era alle visite a Mussolini di Gino Baldesi, autorevole dirigente della CGdL, e di Antonio Vergnanini, segretario della Lega nazionale delle cooperative, entrambi nella speranza di salvare il salvabile delle rispettive organizzazioni. Matteotti continuava a vedere nella linea di Baldesi un pericolo mortale, e quando al convegno confederale di Milano del 23-25 agosto 1923 questi pretese che spettasse al sindacato “la difesa degli interessi immediati dei lavoratori organizzati” e dunque la valutazione delle condizioni “della solidarietà e dell’aiuto a quei partiti e a quei governi che si trovino sulla stessa linea del programma minimo di attuazione pratica e immediata del Sindacato”, vi colse un favore agli avversari per colorare i socialisti di scopi piccolo-borghesi di bassa utilità immediata, e interpretò la rivendicata autonomia politica del sindacato come premessa per un possibile accordo col Governo. In ogni caso, capì che una volta accettata la rinuncia all’azione “mediata di tutta la classe e di tutta la collettività produttrice” attraverso il Partito, sarebbe stata inarrestabile la condanna all’assoluta marginalità del PSU. Nel manifesto redatto per il 1 maggio 1923 (“Di tutta l’Europa civile, solo l’Italia mancherà alla festa del lavoro”), oltre a denunciare la perdita della “libertà”, e cioè dei diritti di associazione, riunione, propaganda e di stampa, e del peggioramento delle condizioni salariali, la riflessione era finalmente portata anche sulla debolezza della sinistra, sulle esagerate illusioni, sui rapidi scoramenti di coloro che avevano ingrossato le file del partito e del sindacato dopo la guerra e che più facilmente erano passati più tardi alle violenze opposte, sui seminatori e sugli autori di continue scissioni, sugli egoismi delle categorie “più pronte a mutare colore”, sulla trascuratezza degli elementi morali ed intellettuali. Tale impietosa denuncia, anche autocritica, era la premessa alla proclamazione di nuovo manifesto di indirizzo politico. Con la lettera del 4 maggio 1923 trasmetteva a Turati la prefazione del citato Direttive del Partito socialista unitario italiano, ricordava la feconda opera di redenzione delle plebi svolta in tre o quattro decenni dal partito socialista e i significativi risultati ottenuti in tutti i campi dalla “civiltà del lavoro”. Con orgoglio constatava come “l’ascesa e lo sviluppo dell’Italia nella corte civile delle nazioni” coincidessero con quelli del partito socialista e delle “libere organizzazioni operaie”. L’immagine era quella di un graduale, ma profondo processo di emancipazione popolare, e quindi dell’intera nazione, che prima la guerra, poi le illusioni comuniste, e infine “la reazione e la violenza fascista” avevano interrotto e in larga parte distrutto. L’attesa era di riprendere il lavoro avviato improntato alla “grande solidarietà umana” (“lo, rifaremo!”), essendo “il socialismo, un’idea che non muore! Come la libertà!”. Nell’opuscolo Matteotti rilanciava le ragioni del socialismo rivedendone la dottrina e saggiandola al confronto dell’esperienza non senza una severa autocritica nei confronti degli errori passati (“è cosa degna di un partito d’avvenire”). Rivolgendosi non solo agli strati popolari ma anche “ai più colti e moderni della borghesia”, ribadiva la scelta irreversibile del metodo democratico di libertà politica e del sistema rappresentativo, ritenuto migliore delle dittature e delle oligarchie perché aveva il vantaggio della libera critica e quindi della capacità di correggere i propri errori. Confermava fedeltà al principio della “lotta di classe”, ma nella chiara distinzione dalla “guerra di classe”, di fatto riducendola al conflitto di interessi – nella fattispecie tra datore di lavoro e lavoratore dipendente – tanto più perché la riconduceva entro un quadro di regole condivise, con la significativa notazione che così in ognuno sarebbero state sollecitate “l’aspirazione e la capacità di elevarsi nella coordinata armonia di tutti per la comune ascensione”. Declinava la tradizionale logica produttivistica nel contrasto alle aree della rendita e della speculazione. Non escludendo la collaborazione, anche se saltuaria con i partiti borghesi, quando questi favorissero l’istruzione popolare, la libertà di organizzazione e di voto per l’opposizione, la pace internazionale, enunciava il concetto che la “nazione, realtà geografica e vivente, entro cui tutti viviamo e cresciamo, è la condizione prima del suo domani socialista”, un “domani” concepito a beneficio di tutti, e non di una classe esclusiva. Matteotti guardava all’Europa, e al ruolo che la ricostituita Internazionale socialista avrebbe potuto avere nel conseguimento di un equilibrio geopolitico, prodomo ad un futuro sistema comune, che superasse i nazionalismi e i rischi di una nuova guerra ancora più rovinosa di quella del 1914-18, alla quale egli con tanta forza si era opposto e che continuò sempre a considerare una tragedia epocale. È da rilevare che con assoluta pertinenza Matteotti non divideva il profilo diplomatico da quello economico e finanziario: ciò sarebbe diventato luogo comune in occasione della seconda guerra mondiale, ma non lo era affatto per la prima.
È dunque particolarmente significativo che su “Critica sociale” avesse recensito il libro di J. M. Keynes critico degli esiti della Conferenza di pace di Versailles, alla quale aveva partecipato con la delegazione inglese (La revisione di Versailles secondo J. M. Keynes), per denunciare la politica di ”oppressione della nuova Germania democratica” con la condanna alle “riparazioni di guerra”. È da osservare ancora che assumeva tale orientamento anche dal punto di vista dell’interesse nazionale. Nella corrispondenza con il pubblicista francese Charles Omessa del dicembre 1921, ad esempio, lamentò che la Francia si acconciasse ad politica di armamenti contro la Germania disarmata, prevedendo che così avrebbero risuscitato e fatto rimpiangere al popolo tedesco “l’antico regime militarista e prussiano come quello che almeno incuteva rispetto ai nemici”. Criticava la politica francese anche per la Polonia e la Jugoslavia perché, anziché mirare alla pace e alla ripresa dei rapporti con la Russia e con l’Italia, “attizzava gli odi e provocava armamenti e sospetti di qua e di là dei confini”, cosicché il nazionalismo italiano avrebbe profittato della tattica del nazionalismo francese, “per ripeterne gli errori e i danni contro l’Europa lavoratrice che anelava al ritorno della pace”. Riteneva infine che in economia le pretese francesi a danno della Germania sollecitassero il protezionismo, “specialmente dannoso al popolo italiano privo di materie e ansioso di occupare la sua manodopera sia in casa sia all’Estero”. Sviluppò tali posizioni in tutti i consessi socialisti europei ai quali partecipò, specialmente dopo l’occupazione francese della Rhur nel gennaio 1923, con una coerenza e una competenza che gli furono riconosciute. In Europa, in un’Europa distratta, portò anche l’accorata denuncia contro il fascismo, che presentava come fenomeno sì italiano, ma anche minaccia comune. Matteotti era un socialista europeo. Contro il fascismo Matteotti puntava su un blocco di alleanze per la libertà. Nel dicembre 1923 aderì ad un’Associazione nazionale per il controllo democratico fondata da antifascisti a Milano su un precedente inglese durante la prima guerra mondiale, ma insorse quando per il raggruppamento antifascista Prampolini propose il nome “Democratico”, ritenendolo del tutto inopportuno. Tra momenti di grande disillusione e incoercibili impulsi a operare, Matteotti non perdeva comunque la speranza di fare del PSU il centro aggregativo delle opposizioni (“l’unione di tutte le forze che onestamente e lealmente intendono di opporsi alla dittatura fascista”), e in tale prospettiva giunse a carezzare l’ipotesi di una riunificazione con i massimalisti, anche per non perdere completamente “il contatto con le masse”. Stava lavorando all’opuscolo Mussolini nel 1919-20 (sarebbe uscito postumo con il titolo Fascismo della prima ora. Pagine estratte dal “Popolo d’Italia”) e portava avanti il lavoro preparatorio per il libretto Un anno di dominazione fascista, terminato poi agli inizi del dicembre 1923, e pubblicato nel febbraio 1924. L’opuscolo sarebbe diventato di 200 pagine, e ne ipotizzava l’uscita “ora per lo scioglimento Camera”. Gli accludeva solo una premessa breve, ma di grande efficacia, dove alla pretesa del Governo fascista di giustificare “la conquista armata del potere politico, l’uso della violenza e il rischio di una guerra civile, con la necessità urgente di ripristinare l’autorità della legge e dello Stato, e di restaurare l’economia e la finanza salvandole dal pericolo”, opponeva “i numeri, i fatti e i documenti raccolti (che) dimostrano invece che mai, come nell’anno fascista, l’arbitrio si è sostituito alla legge, lo Stato asservito alla Nazione, e divisa la Nazione in due ordini, dominatori e sudditi”. Per rilanciare il partito considerò l’opportunità di un concorso a premi per il “distintivo” o per la tessera del 1924, la quale infine fu oggetto di studi e vari tentativi. Aveva in mente di organizzare convegni a Napoli, Roma e, il più importante, a Milano tra settembre e ottobre. Contava ancora sulla autorevolezza di Turati, come dimostrava la lettera del 29 agosto 1923: sarebbe un suo discorso quel “qualcos’altro”, più forte, su cui far leva per cercare di aggregare ceti e persone interessate ad “un’azione per la riconquista della libertà, e per toccare l’opinione pubblica”. Ipotizzava come sede Torino, alla presenza dello stato maggiore del Partito, e come “programma” la riaffermazione di che cosa ci fosse di vivo nella dottrina socialista, per poi ribadire “l’avversione ai metodi che hanno discreditato il partito nel dopoguerra e a tutti gli eccessi negli scioperi, negli appetiti di categoria, nei servizi pubblici” e quindi concludere con obiettivi immediati per la riconquista della libertà e per “la ricostruzione economica e morale del paese”. La prospettiva era ambiziosa: solo così sarebbe possibile “preparare una piattaforma nuova e a larga base, che (avesse) ripercussione non soltanto negli strati popolari, ma anche nei più colti e moderni della borghesia”. Turati restava molto dubbioso “sull’opportunità – direi anche sulla serietà e sulla possibilità – di aprire il fuoco così presto, e di aprirlo proprio a Torino, dove il comunismo e il fascismo ci prendono tra due fuochi, dove, non è molto, si poterono assassinare varie diecine di compagni, e dove un insuccesso comprometterebbe tutto per un pezzo”. Ma infine accettò di aprire la campagna elettorale il 20 gennaio 1924 al Teatro Scribe di Torino. Il testo integrale del discorso apparve su “La Critica sociale” e poi venne raccolto in opuscolo: resterà uno dei documenti più alti dell’antifascismo italiano. I rapporti con lo stesso Turati, tuttavia, non furono sempre in sintonia, anche perché ben presto l’attività di partito ebbe due centri, non sempre all’unisono: a Roma restava la Direzione, a Milano si stampava “La Giustizia” e l’influenza del gruppo di “Critica sociale” era più forte. Il motivo di maggiore dissenso fu dato dalla risistemazione dell’organico del giornale. In data 8 gennaio 1924 Turati lamentò la frettolosità di certe decisioni della Direzione. Matteotti si sentì spiazzato, deprecò l’assenza di un minimo di disciplina, alzò i toni parlando di “disfattismo” che trovava “tutti i pretesti e tutte le ragioni”, fino a coinvolgere lo stesso Turati (“mi duole soprattutto quando arriva a far presa su di te che eri uno dei pochissimi che resistevi all’inerzia dei molti. Io non comprendo codesto eterno dire e disdire”), fino a minacciare le dimissioni (“se ciò non va, dite di riconvocare la Direzione, affinché provveda altrimenti. Io così non vado avanti”). Ma poi Matteotti si ributtò nella lotta con inalterato impegno. Nel febbraio 1924 favorì una riunione con repubblicani, bonomiani, sardisti, Italia libera e altri gruppi per rilanciare l’idea del blocco elettorale per la libertà, cioè di una lista nazionale comprendente tutta l’opposizione, ovvero della comune deliberazione per l’astensione. Una volta tramontata l’idea della lista nazionale delle opposizione riunite, il partito avrebbe preferito l’astensione purché in questo proposito convenissero tutti i partiti d’opposizione, da Amendola e Bonomi ai massimalisti, “non richiedendo invece il concorso dei popolari e dei comunisti”. Ma anche l’ipotesi dell’astensione svanì ben presto, come risultava in una lettera a Giulio Zanardi del febbraio 1924. Restava il fatto che – lui stesso protagonista – già si preannunciava l’Aventino. A fronte della proposta del PCdI di un blocco tra i tre partiti di classe, Matteotti rispondeva a Palmiro Togliatti in data 25 gennaio 1924 che essa contrastava “con l’obiettivo preliminare della restaurazione pura e semplice delle “libertà statutarie”, perseguito invece dal PSU. Riteneva inaccettabili tre condizioni poste dai comunisti: l’indirizzo tattico (“antitetico al nostro”); la rinuncia a priori dell’astensione dalla lotta elettorale che invece avrebbe potuto esprimere con più immediatezza la protesta del proletariato contro il regime di dittatura fascista, e soprattutto l’esclusione della “restaurazione pura e semplice delle libertà statutarie”, magari con l’appoggio di elementi non appartenenti ai tre partiti di sinistra, come finalità di qualsiasi blocco di opposizione al fascismo e alla dittatura da esso instaurata. Tale posizione era confermata nella risposta alla Direzione del Partito comunista in data 16 aprile 1924 in merito all’ipotesi di una manifestazione unitaria per il 1 maggio. Matteotti respingeva la tesi del fronte unico, di cui coglieva la strumentalità polemica da parte di chi aveva inasprito le ragioni della scissione e della discordia nella classe lavoratrice. E scriveva: “Restiamo quel che siamo. Voi siete comunisti per la dittatura e per il metodo della violenza delle minoranze; noi siamo socialisti e per il metodo democratico delle libere maggioranze. Non c’è quindi nulla di comune tra noi e voi”. Per lui il nemico era uno solo: il fascismo, ma complice involontario di esso era il comunismo, perché la violenza e la dittatura predicata dall’uno, divenivano il pretesto e la giustificazione della violenza e della dittatura in atto dell’altro. Il distacco con i comunisti era ormai incolmabile.
Troppo diversi gli obiettivi tattici e di fondo, perfino il linguaggio. Quello socialista unitario parlava di libertà e di democrazia. Le enormi difficoltà incontrate nella preparazione della campagna elettorale indussero Matteotti a rivolgersi ancora a Turati per annunciare le dimissioni dalla segreteria dopo le elezioni. In realtà, percepiva chiaramente che la lotta politica era entrata in una fase nuova, per la quale larga parte dei vecchi quadri del Partito non sembravano più idonei (“gente arrivata in altri tempi e per altri modi”). I tempi richiedevano gente di volontà e non scettica, per una “resistenza senza limite” contro la dittatura fascista (“Cerco la vita, voglio la lotta contro il fascismo. Per vincerla bisogna inacerbirla”). Tale presupposto si basava sulla convinzione, rivelatasi corretta, che il fascismo dominante non avrebbe deposto le armi, né tantomeno restituito spontaneamente all’Italia un regime di legalità e di libertà perché “tutto ciò che esso ottiene, lo sospinge a nuovi arbitri a nuovi soprusi. È la sua essenza, la sua origine, la sua unica forza, ed è il temperamento stesso che lo dirige”. Da politico perseguiva sempre la “ricostituzione delle nostre file” con fede nella libertà, ma l’appello era sempre più rivolto ai “puri di cuore”. Andava dunque a ricercare “gli atti di coraggio e di fermezza compiuti dai compagni in nome del Partito, perché d’ora in avanti intendiamo più che mai attingere alle energie morali del partito che fortunatamente rimangono intatte in mezzo al frantumarsi dell’inquadramento materiale della nostra organizzazione”. La dimensione della lotta al fascismo era spostata sul piano dei simboli, dei valori, delle idee. Il martirio di Matteotti ne avrebbe rappresentato l’apoteosi. Come previsto, le politiche del maggio 1924 segnarono la débacle dei socialisti (il Psu portò alla Camera 24 deputati, il Psi 22). Il 30 maggio 1924 il neo presidente della Camera Alfredo Rocco, presente Mussolini al banco del Governo, ricevuta dalla Giunta delle elezioni la relazione di convalida in blocco di tutti gli eletti della maggioranza, ne mise ai voti l’accoglimento. Le opposizioni furono prese alla sprovvista, e chiesero la sospensione, che fu rigettata. Nella discussione su eventuali contestazioni, Matteotti contestò in blocco la validità delle elezioni e, chiedendo il rinvio di quelle inficiate dalle violenze alla Giunta delle elezioni, per un’ora e mezzo parlò degli episodi di violenza, fra urla e interruzioni. Denunciò l’invadenza di “una milizia armata, composta di cittadini di un solo partito”, la quale aveva il compito di sostenere “un determinato Governo con la forza, anche se ad esso il consenso mancasse”. La proposta di rinvio degli atti alla Giunta delle elezioni, a firma Arturo Labriola, Matteotti e Enrico Presutti, fu messa ai voti e ottenne solo 57 sì, 42 astenuti su 384 presenti e votanti. Come bene scrisse Sandro Pertini nella premessa ai Discorsi parlamentari pubblicati in tre volumi dalla Camera dei deputati nel 1970, a Matteotti “appariva un’insipienza quella di far sì che fosse distrutto l’ultimo rimasuglio di Parlamento nel momento in cui crescevano l’arbitrio e la prepotenza della piazza. Quasi presagio della fine dell’istituto rappresentativo, si sorprendeva che dovessero essere proprio i socialisti le ultime, sciolte, guardie del sistema costituzionale”. Mentre ogni spazio di agibilità politica si andava restringendo nel paese, Matteotti aveva concentrato ogni azione nella sede parlamentare, certamente la tribuna più autorevole, ma anche il cuore autentico della democrazia rappresentativa, il bene ultimo e più prezioso della collettività. E lì si sarebbe consumato il suo sacrificio. Il 10 giugno 1924 alle ore 16,30 Matteotti usciva dalla sua abitazione in Via Pisanelli 40, a pochi passi dal Lungotevere Arnaldo da Brescia, fu aggredito e ucciso a coltellate. I miseri resti furono trovati nella macchia della Quartarella presso Riano Flaminio. Filippo Turati lo commemorò il 27 giugno 1924 a Montecitorio, ma non nell’Aula dove i deputati dell’opposizione avevano deciso di non tornare più. Matteotti non si era mai stancato di ammonire che l’inefficienza delle istituzioni nella tutela delle libertà comuni generava disaffezione e lacerazione nel tessuto sociale, fino a minarne irrimediabilmente la stessa coesione. A ben vedere, il 10 giugno 1924 si determinò un solco non più colmabile tra due Italie, destinato a produrre effetti negativi nel lungo periodo. Subito dopo la morte, “La Giustizia” scrisse che Matteotti era rimasto vittima del “suo civico eroismo”, della sua “virtù”, e così egli ascendeva “alla volontà operosa di redimerci per raccogliere la sua eredità, di costruire su quelle ossa il monumento ideale del riscatto d’Italia”. Certo, Matteotti diventò immediatamente l’antiMussolini, simbolo dell’eroismo antifascista, con cui iniziava una nuova storia d’Italia. Nell’esigenza di segnare la discontinuità con il regime fascista e con l’Italia monarchica, nella rimozione del passato (che pure era cosa diversa dalla critica del passato) Piero Calamandrei, massimo cantore della Resistenza, nel discorso alla Costituente il 4 marzo 1947, interrogandosi sul giudizio dei posteri in merito all’opera dei Costituenti stessi, ammonì a tradurre il sogno dei “Caduti in leggi chiare, stabili e oneste, per una società più giusta e più umana”, in modo da rendere la Costituzione “non una carta morta”, ma piuttosto “il testamento” di un popolo”. Si designava così a mito fondante del nuovo Stato democratico il culto dei Caduti per la Libertà, spesso oscuri ma per questo non meno significativi, dietro i quali si stagliavano i martiri dell’antifascismo: Matteotti apriva la scia nella quale si annoveravano Amendola, Gobetti, Don Minzoni, Gramsci, Rosselli. In termini epici, la loro morte era rappresentata a riscatto/espiazione per tutti, per una nazione intera: mito fondativo dell’Italia repubblicana. Un mito fondativo che conviene ricordare sempre, quando si avverta la necessità di esaltare il valore più alto della politica e della coesione sociale nella libertà. Forte dell’autorevolezza delle istituzioni coinvolte e ricca di materiali inediti, la rassegna annovera documenti originali – con particolare riferimento agli atti istruttori e giudiziari, mai mostrati in precedenza, che sostanziano il percorso interpretativo – tra fotografie, manoscritti, oggetti, libri d’epoca, articoli di giornali e riviste, filmati e documentari, opere d’arte, sculture, ceramiche, quadri, nonché brani musicali dedicati al leader politico. L’esposizione è suddivisa in quattro sezioni, che ripercorrono la vita di Matteotti e il drammatico passaggio dallo Stato liberale alla dittatura fascista. La sezione Il giovane Matteotti registra l’impegno in Polesine a favore di braccianti e mezzadri, la carriera accademica, l’attività pubblicistica per “La Lotta”, l’adesione al Partito Socialista. Quella sull’Impegno politico nazionale 1919-1924, ne distingue l’attività parlamentare, l’azione politica contro il fascismo, considerato da subito un pericolo mortale per le istituzioni democratiche, e gli squadristi, intesi quale “guardia bianca” degli interessi agrari e dei “collaborazionisti”, in seno al neonato Psu di cui è segretario. La sezione Sequestro e morte 1924-1926, partendo dall’affermazione alle elezioni del 1924 del Psu quale partito più forte della sinistra, include il celebre discorso del 30 maggio 1924 in Parlamento contro i brogli e le violenze dei fascisti, fino al sequestro di cui fu vittima il 10 giugno 1924 a Roma, all’assassinio, al ritrovamento del cadavere il successivo 16 agosto e al processo-farsa di Chieti. Infine la sezione Il mito di Matteotti, focalizza il lascito fattuale e ideale del politico, dalle commemorazioni alle Brigate Matteotti fino alla perdurante residenza nell’immaginario collettivo perché, come lui stesso ebbe a dire: “Uccidete me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai… La mia idea non muore”. L’intento della mostra è quello di restituire al grande pubblico il valore di uno dei padri della nostra democrazia e di far conoscere alle nuove generazioni, con approfondimenti multimediali, iniziative formative e linguaggio immediato, un politico e intellettuale di notevole valore. “Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della democrazia” è corredata dal catalogo edito da Treccani che, recependo contributi iconografici inediti e preziose testimonianze, contempla origini, attività ed epilogo di un martire dell’antifascismo votato alla libertà.
Museo di Roma – Palazzo Braschi
Giacomo Matteotti. Vita e morte di un Padre della democrazia
dal 1 Marzo 2024 al 16 Giugno 2024
dal Martedì alla Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Lunedì Chiuso